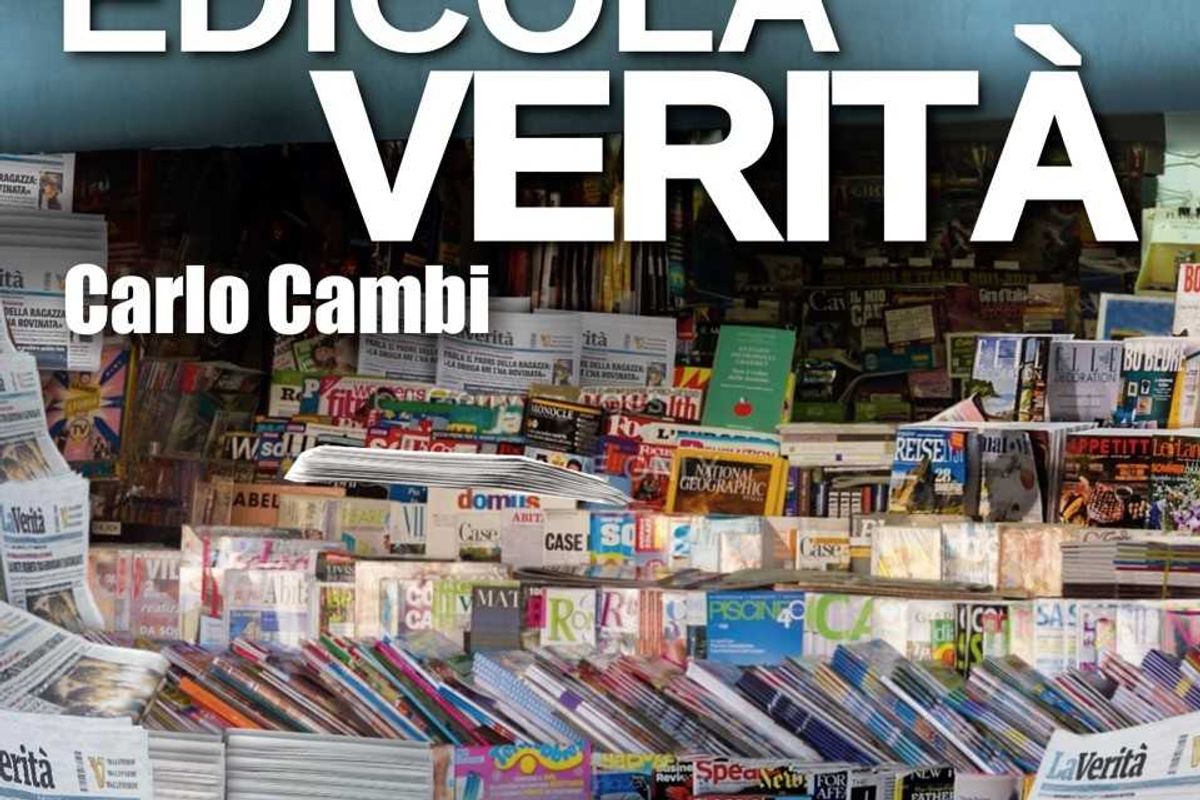True
2019-02-27
Nei rapporti commerciali con la Cina Trump può giocare la carta Taiwan
Ansa
Il summit che si tiene in questi giorni ad Hanoi tra Donald Trump e Kim Jong Un mostra come la distensione tra Stati Uniti e Corea del Nord stia pian piano procedendo. Per quanto non poche incognite incombano sui negoziati, il clima risulta relativamente ottimista, anche alla luce del fatto che le relazioni commerciali tra Washington e Pechino siano migliorate nelle ultime settimane. Non è del resto un mistero che, nel rapporto tra lo Zio Sam e Pyongyang, la Cina svolga da sempre un ruolo decisivo. Eppure, a ben vedere, c'è una nube che si staglia all'orizzonte. La questione di Taiwan.
Recentemente i senatori repubblicani Ted Cruz, Marco Rubio, Tom Cotton, Cory Gardner e John Cornyn hanno scritto una lettera, chiedendo alla Speaker della Camera, Nancy Pelosi, di invitare la presidentessa di Taiwan, Tsai Ing-wen, a tenere un discorso davanti al Congresso americano. Una richiesta che mira ovviamente a rinsaldare i rapporti con l'antico alleato, comportando inevitabilmente un messaggio critico nei confronti della Cina. Si tratta a ben vedere di un fattore che si inserisce nella più complessa questione delle relazioni tra Pechino e Taipei. Dai tempi della nascita della Repubblica popolare nel 1949, la Cina ha sempre ritenuto Taiwan un territorio di sua appartenenza, laddove per lungo tempo Washington ne ha radicalmente difeso la libertà e l'autonomia da quello che considerava uno dei suoi nemici più feroci e pericolosi. La situazione cambiò negli anni Settanta: con la distensione, promossa da Richard Nixon verso Pechino, la Casa Bianca optò per normalizzare i rapporti diplomatici con il suo antico avversario. Un cambio di rotta che avrebbe portato Jimmy Carter, nel 1979, a rompere le relazioni con Taiwan per abbracciare la cosiddetta «politica di una sola Cina». Evento, questo, che condusse il Congresso ad approvare il Taiwan relations act: una legge che manteneva in vigore de facto le relazioni con le autorità dell'isola. Da allora, Washington ha spesso oscillato tra Pechino e Taipei, cercando di tenere così due piedi in una staffa: un comportamento che si palesò in tutta la sua evidenza durante la presidenza di Ronald Reagan.
Del resto, la spinosa questione continua ancora oggi ad attanagliare la politica statunitense. E il problema di Taiwan riemerge costantemente in quelle che sono le burrascose relazioni che intercorrono tra Trump e la Repubblica popolare. Durante la campagna elettorale, il magnate newyorchese aveva adottato una durissima retorica anticinese, tacciando Pechino di concorrenza sleale ai danni degli Stati Uniti. In questo clima, a dicembre del 2016 Trump, da presidente in pectore, ebbe una telefonata proprio con la presidentessa di Taiwan: il fatto - neanche a dirlo - mandò su tutte le furie la Repubblica popolare. Tanto che molti parlamentari americani (soprattutto tra i repubblicani) credevano che il magnate fosse intenzionato ad usare il pugno duro verso Pechino. Gli eventi successivi mostrarono tuttavia ben altro.
In questi due anni di presidenza, nei suoi rapporti con la Cina la Casa Bianca ha alternato momenti di rottura a momenti di distensione. Un'autentica altalena, che sta mostrando come, forse, l'obiettivo del presidente non sia tanto quello di arrivare a uno scontro con Pechino quanto - semmai - quello di conseguire un buon accordo sul fronte commerciale. Perché se è nella memoria di tutti la dura guerra dei dazi dell'estate scorsa, bisogna altrettanto ricordare che in quel periodo ci fosse, in America, la campagna elettorale per le elezioni di metà mandato. E che il presidente americano nutrisse tutto l'interesse a mantenere alta la tensione verso Pechino, visto l'astio anticinese espresso da buona parte della sua storica base elettorale (la classe operaia impoverita della Rust belt). Inoltre, anche sul fronte geopolitico, per Trump la rottura con la Cina minerebbe seriamente la distensione con la Corea del Nord: un Paese legato alla Repubblica popolare sia dal punto di vista commerciale che geopolitico. Ecco che allora, forse, episodi come la telefonata alla presidentessa taiwanese potrebbero essere ricondotti in seno a una più generale strategia negoziale che il magnate starebbe portando avanti per arrivare a un'intesa commerciale con Pechino. D'altronde, che il presidente non nutra obiettivi troppo «bellicosi» è testimoniato anche dal fatto che abbia ufficiosamente richiamato in servizio il vecchio Henry Kissinger: proprio colui che, da segretario di Stato, fu l'artefice del disgelo tra Washington e la Repubblica popolare.
Il punto è che il presidente potrebbe ritrovarsi delle serpi in seno su questa strada. E la lettera dei senatori repubblicani potrebbe proprio per questo rivelarsi alla fine come manifestazione di una fronda che voglia mettergli i bastoni tra le ruote. Non dimentichiamo, del resto, come nel 2018 il Congresso abbia varato svariate leggi in questa direzione: dal Taiwan travel act (che incoraggia le visite tra funzionari statunitensi e taiwanesi ad ogni livello) al Taipei Act (una proposta che mira al rafforzamento diplomatico di Taiwan). Norme che - neanche a dirlo - hanno irritato non poco la Cina. In questo senso, non è esattamente chiaro quanto simili provvedimenti legislativi siano apprezzati da Trump. E, lo stesso fatto che dietro queste iniziative compaia spesso il nome di un suo ex avversario come Marco Rubio, effettivamente lascia intendere che qualcuno a Washington non apprezzi la linea morbida né con Pechino né - di riflesso - con Pyongyang. E che, forse, voglia complicare la vita a un presidente in cerca di rielezione nel 2020.
Il fisco di Trump alla fine grazia i big del Web
Riforma fiscale di Donald Trump all'insegna di più occupazione e di una maggiore elusione da parte delle multinazionali. Gli incentivi fiscali e la riduzione dell'aliquota per le società hanno infatti aiutato le multinazionali americane a pagare molte meno tasse in patria ed a ottenere profitti da record nel 2018. Il pacchetto «Tax reform» voluto dalla Casa Bianca aveva però un duplice obiettivo. Da una parte incentivare le multinazionali a riportare in patria i capitali detenuti all'estero. E dall'altra rafforzare il mercato americano creando maggiore occupazione. Il primo obiettivo non è però stato centrato, dato che molte multinazionali hanno sfruttato le agevolazioni per la ricerca e lo sviluppo e il meccanismo della compensazione in forma di azioni, per pagare meno tasse in patria. A tutto ciò si aggiungono anche altre due questioni.
La prima riguarda le scappatoie fiscali, che non sono state chiuse, e la seconda l'abbassamento del livello di corporate tax, tassa sui profitti della società, dal 35% al 21%. Le multinazionali possono dunque ancora non pagare le tasse sulle somme non riportate in patria. E se investono in ricerca e sviluppo o ha venduto azioni hanno ricevuto un'ingente somma di rimborso che andrà a compensare le tasse pagate (21%)
Il mix di incentivi, scappatoie fiscali e corporate tax hanno dunque portato le società Usa a realizzare profitti in crescita e tasse vicino allo 0. Netflix, Amazon e Google hanno infatti pubblicato i conti del 2018, da dove sono emersi profitti record e imposte pagate molto basse. Andando in ordine cronologico, Netflix, la prima a rendere pubblici i dati, ha realizzato profitti pari a 845 milioni di dollari, risultato in netta crescita rispetto agli anni passati. E tasse pari allo 0%. Inoltre, la società è riuscita a ottenere anche un rimborso fiscale pari a 22 milioni di dollari. Se si confronta la situazione rispetto al passato non sembrano però esserci molti cambiamenti. Stando infatti all'ultimo rapporto dell'Institute on taxation and economic politicy (Itep, organizzazione no profit che si occupa di analisi fiscali ed economiche), pubblicato nel 2017, Netflix era stata identificata come una delle 100 società di Fortune 500, che ha pagato tra il 2008 e il 2015 un'aliquota fiscale federale dello 0%. Tassazione che non ha dunque visto variazioni prima e dopo la riforma fiscale di Trump. Unica differenza, l'aver ottenuto maggiori rimborsi fiscali rispetto al passato. Stessa situazione per Google. La società è infatti riuscita ad ottenere più di 10 milioni di dollari in agevolazioni fiscali, grazie alle attività di ricerca e sviluppo nel 2018.
Infine l'ultima big ad aver pubblicato i conti è Amazon. La società ha realizzato un profitto pari a 11 miliardi di dollari (il 2017 si era chiuso con 5,6 miliardi di dollari), tasse pagate pari allo 0%. E il credito fiscale, come nei casi precedenti è decollato. Amazon è riuscita ad ottenere agevolazioni fiscali grazie alle attività di ricerca e sviluppo e alle azioni vendute. Da diversi anni la società ha infatti iniziato a premiare i dipendenti dandogli azioni. Questa politica di incentivi aziendali ha però avuto un notevole effetto fiscale, soprattutto dopo la riforma di Trump, dato che lo stock dato ai dipendenti risulta essere deducibile. Inoltre, più le azioni vanno meglio, più aumenta il rimborso che Amazon ottiene. Anche in questo caso si può notare come la situazione rispetto al passato non sia cambiata più di tanto. Tra il 2009 e il 2018, sottolinea l'Itep, il colosso del Web ha realizzato 27 miliardi di profitti e pagato tasse per un miliardo (aliquota effettiva del 3%). Se dunque da una parte è innegabile affermare che l'ultima riforma fiscale abbia agevolato le finanze delle multinazionali americane, dandogli maggiori incentivi fiscali. Dall'altra non si può negare che le misure prese per stimolare il mercato del lavoro interno abbiano funzionato.
Nel 2018, stando ai dati del dipartimento del lavoro Usa, l'economia americana ha creato 2,64 milioni di posti di lavoro. Il dato non è da sottovalutare dato che rappresenta uno dei migliori risultati ottenuto dal 2009. A dicembre le società americane hanno infatti assunto più di quanto gli analisti stessi avessero previsto. 312.000 nuovi posti di lavoro contro i 176.000 annunciati. I settori che hanno contribuito maggiormente all'incremento dell'occupazione sono: le costruzioni 280.000 (+12%), il manifatturiero 32.000 e le vendite al dettaglio 24.000. Il numero degli occupati tocca è un risultato record, dato che si tratta del maggior numero di assunti da inizio 2018
Continua a leggereRiduci
Mentre prende il via il summit ad Hanoi tra il presidente americano e il dittatore nordcoreano Kim Jong Un, l'obiettivo di The Donald è conseguire un buon accordo con Pechino, che rassicurerebbe anche Pyongyang.La riforma della Casa Bianca aveva due obiettivi: creare posti di lavoro e fare rientrare i capitali. Nel 2018 i contratti in più sono stati 2,6 milioni, mentre Netflix ha chiuso con 845 milioni di utile, zero tasse e 22 milioni di rimborsi grazie alla politica delle stock option.Lo speciale contiene due articoliIl summit che si tiene in questi giorni ad Hanoi tra Donald Trump e Kim Jong Un mostra come la distensione tra Stati Uniti e Corea del Nord stia pian piano procedendo. Per quanto non poche incognite incombano sui negoziati, il clima risulta relativamente ottimista, anche alla luce del fatto che le relazioni commerciali tra Washington e Pechino siano migliorate nelle ultime settimane. Non è del resto un mistero che, nel rapporto tra lo Zio Sam e Pyongyang, la Cina svolga da sempre un ruolo decisivo. Eppure, a ben vedere, c'è una nube che si staglia all'orizzonte. La questione di Taiwan.Recentemente i senatori repubblicani Ted Cruz, Marco Rubio, Tom Cotton, Cory Gardner e John Cornyn hanno scritto una lettera, chiedendo alla Speaker della Camera, Nancy Pelosi, di invitare la presidentessa di Taiwan, Tsai Ing-wen, a tenere un discorso davanti al Congresso americano. Una richiesta che mira ovviamente a rinsaldare i rapporti con l'antico alleato, comportando inevitabilmente un messaggio critico nei confronti della Cina. Si tratta a ben vedere di un fattore che si inserisce nella più complessa questione delle relazioni tra Pechino e Taipei. Dai tempi della nascita della Repubblica popolare nel 1949, la Cina ha sempre ritenuto Taiwan un territorio di sua appartenenza, laddove per lungo tempo Washington ne ha radicalmente difeso la libertà e l'autonomia da quello che considerava uno dei suoi nemici più feroci e pericolosi. La situazione cambiò negli anni Settanta: con la distensione, promossa da Richard Nixon verso Pechino, la Casa Bianca optò per normalizzare i rapporti diplomatici con il suo antico avversario. Un cambio di rotta che avrebbe portato Jimmy Carter, nel 1979, a rompere le relazioni con Taiwan per abbracciare la cosiddetta «politica di una sola Cina». Evento, questo, che condusse il Congresso ad approvare il Taiwan relations act: una legge che manteneva in vigore de facto le relazioni con le autorità dell'isola. Da allora, Washington ha spesso oscillato tra Pechino e Taipei, cercando di tenere così due piedi in una staffa: un comportamento che si palesò in tutta la sua evidenza durante la presidenza di Ronald Reagan.Del resto, la spinosa questione continua ancora oggi ad attanagliare la politica statunitense. E il problema di Taiwan riemerge costantemente in quelle che sono le burrascose relazioni che intercorrono tra Trump e la Repubblica popolare. Durante la campagna elettorale, il magnate newyorchese aveva adottato una durissima retorica anticinese, tacciando Pechino di concorrenza sleale ai danni degli Stati Uniti. In questo clima, a dicembre del 2016 Trump, da presidente in pectore, ebbe una telefonata proprio con la presidentessa di Taiwan: il fatto - neanche a dirlo - mandò su tutte le furie la Repubblica popolare. Tanto che molti parlamentari americani (soprattutto tra i repubblicani) credevano che il magnate fosse intenzionato ad usare il pugno duro verso Pechino. Gli eventi successivi mostrarono tuttavia ben altro.In questi due anni di presidenza, nei suoi rapporti con la Cina la Casa Bianca ha alternato momenti di rottura a momenti di distensione. Un'autentica altalena, che sta mostrando come, forse, l'obiettivo del presidente non sia tanto quello di arrivare a uno scontro con Pechino quanto - semmai - quello di conseguire un buon accordo sul fronte commerciale. Perché se è nella memoria di tutti la dura guerra dei dazi dell'estate scorsa, bisogna altrettanto ricordare che in quel periodo ci fosse, in America, la campagna elettorale per le elezioni di metà mandato. E che il presidente americano nutrisse tutto l'interesse a mantenere alta la tensione verso Pechino, visto l'astio anticinese espresso da buona parte della sua storica base elettorale (la classe operaia impoverita della Rust belt). Inoltre, anche sul fronte geopolitico, per Trump la rottura con la Cina minerebbe seriamente la distensione con la Corea del Nord: un Paese legato alla Repubblica popolare sia dal punto di vista commerciale che geopolitico. Ecco che allora, forse, episodi come la telefonata alla presidentessa taiwanese potrebbero essere ricondotti in seno a una più generale strategia negoziale che il magnate starebbe portando avanti per arrivare a un'intesa commerciale con Pechino. D'altronde, che il presidente non nutra obiettivi troppo «bellicosi» è testimoniato anche dal fatto che abbia ufficiosamente richiamato in servizio il vecchio Henry Kissinger: proprio colui che, da segretario di Stato, fu l'artefice del disgelo tra Washington e la Repubblica popolare.Il punto è che il presidente potrebbe ritrovarsi delle serpi in seno su questa strada. E la lettera dei senatori repubblicani potrebbe proprio per questo rivelarsi alla fine come manifestazione di una fronda che voglia mettergli i bastoni tra le ruote. Non dimentichiamo, del resto, come nel 2018 il Congresso abbia varato svariate leggi in questa direzione: dal Taiwan travel act (che incoraggia le visite tra funzionari statunitensi e taiwanesi ad ogni livello) al Taipei Act (una proposta che mira al rafforzamento diplomatico di Taiwan). Norme che - neanche a dirlo - hanno irritato non poco la Cina. In questo senso, non è esattamente chiaro quanto simili provvedimenti legislativi siano apprezzati da Trump. E, lo stesso fatto che dietro queste iniziative compaia spesso il nome di un suo ex avversario come Marco Rubio, effettivamente lascia intendere che qualcuno a Washington non apprezzi la linea morbida né con Pechino né - di riflesso - con Pyongyang. E che, forse, voglia complicare la vita a un presidente in cerca di rielezione nel 2020.<div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem1" data-id="1" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/nei-rapporti-commerciali-con-la-cina-trump-puo-giocare-la-carta-taiwan-2630091586.html?rebelltitem=1#rebelltitem1" data-basename="il-fisco-di-trump-alla-fine-grazia-i-big-del-web" data-post-id="2630091586" data-published-at="1770712555" data-use-pagination="False"> Il fisco di Trump alla fine grazia i big del Web Riforma fiscale di Donald Trump all'insegna di più occupazione e di una maggiore elusione da parte delle multinazionali. Gli incentivi fiscali e la riduzione dell'aliquota per le società hanno infatti aiutato le multinazionali americane a pagare molte meno tasse in patria ed a ottenere profitti da record nel 2018. Il pacchetto «Tax reform» voluto dalla Casa Bianca aveva però un duplice obiettivo. Da una parte incentivare le multinazionali a riportare in patria i capitali detenuti all'estero. E dall'altra rafforzare il mercato americano creando maggiore occupazione. Il primo obiettivo non è però stato centrato, dato che molte multinazionali hanno sfruttato le agevolazioni per la ricerca e lo sviluppo e il meccanismo della compensazione in forma di azioni, per pagare meno tasse in patria. A tutto ciò si aggiungono anche altre due questioni. La prima riguarda le scappatoie fiscali, che non sono state chiuse, e la seconda l'abbassamento del livello di corporate tax, tassa sui profitti della società, dal 35% al 21%. Le multinazionali possono dunque ancora non pagare le tasse sulle somme non riportate in patria. E se investono in ricerca e sviluppo o ha venduto azioni hanno ricevuto un'ingente somma di rimborso che andrà a compensare le tasse pagate (21%) Il mix di incentivi, scappatoie fiscali e corporate tax hanno dunque portato le società Usa a realizzare profitti in crescita e tasse vicino allo 0. Netflix, Amazon e Google hanno infatti pubblicato i conti del 2018, da dove sono emersi profitti record e imposte pagate molto basse. Andando in ordine cronologico, Netflix, la prima a rendere pubblici i dati, ha realizzato profitti pari a 845 milioni di dollari, risultato in netta crescita rispetto agli anni passati. E tasse pari allo 0%. Inoltre, la società è riuscita a ottenere anche un rimborso fiscale pari a 22 milioni di dollari. Se si confronta la situazione rispetto al passato non sembrano però esserci molti cambiamenti. Stando infatti all'ultimo rapporto dell'Institute on taxation and economic politicy (Itep, organizzazione no profit che si occupa di analisi fiscali ed economiche), pubblicato nel 2017, Netflix era stata identificata come una delle 100 società di Fortune 500, che ha pagato tra il 2008 e il 2015 un'aliquota fiscale federale dello 0%. Tassazione che non ha dunque visto variazioni prima e dopo la riforma fiscale di Trump. Unica differenza, l'aver ottenuto maggiori rimborsi fiscali rispetto al passato. Stessa situazione per Google. La società è infatti riuscita ad ottenere più di 10 milioni di dollari in agevolazioni fiscali, grazie alle attività di ricerca e sviluppo nel 2018. Infine l'ultima big ad aver pubblicato i conti è Amazon. La società ha realizzato un profitto pari a 11 miliardi di dollari (il 2017 si era chiuso con 5,6 miliardi di dollari), tasse pagate pari allo 0%. E il credito fiscale, come nei casi precedenti è decollato. Amazon è riuscita ad ottenere agevolazioni fiscali grazie alle attività di ricerca e sviluppo e alle azioni vendute. Da diversi anni la società ha infatti iniziato a premiare i dipendenti dandogli azioni. Questa politica di incentivi aziendali ha però avuto un notevole effetto fiscale, soprattutto dopo la riforma di Trump, dato che lo stock dato ai dipendenti risulta essere deducibile. Inoltre, più le azioni vanno meglio, più aumenta il rimborso che Amazon ottiene. Anche in questo caso si può notare come la situazione rispetto al passato non sia cambiata più di tanto. Tra il 2009 e il 2018, sottolinea l'Itep, il colosso del Web ha realizzato 27 miliardi di profitti e pagato tasse per un miliardo (aliquota effettiva del 3%). Se dunque da una parte è innegabile affermare che l'ultima riforma fiscale abbia agevolato le finanze delle multinazionali americane, dandogli maggiori incentivi fiscali. Dall'altra non si può negare che le misure prese per stimolare il mercato del lavoro interno abbiano funzionato. Nel 2018, stando ai dati del dipartimento del lavoro Usa, l'economia americana ha creato 2,64 milioni di posti di lavoro. Il dato non è da sottovalutare dato che rappresenta uno dei migliori risultati ottenuto dal 2009. A dicembre le società americane hanno infatti assunto più di quanto gli analisti stessi avessero previsto. 312.000 nuovi posti di lavoro contro i 176.000 annunciati. I settori che hanno contribuito maggiormente all'incremento dell'occupazione sono: le costruzioni 280.000 (+12%), il manifatturiero 32.000 e le vendite al dettaglio 24.000. Il numero degli occupati tocca è un risultato record, dato che si tratta del maggior numero di assunti da inizio 2018
Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi (Ansa)
«Nei gruppi di antagonisti ci sono veri e propri “esperti del disordine” che si macchiano di violenze gravissime da decenni. Sono sempre in cerca di nuovi pretesti per mobilitarsi: Tav, Tap, Medio Oriente, alternanza scuola lavoro, il Ponte, l’Expo, l’ambiente e adesso perfino le Olimpiadi invernali. Ora si mobiliteranno anche per il pacchetto sicurezza? Io credo che, se non avessimo varato le norme, questi soggetti sarebbero comunque all’opera. Basta leggere i loro comunicati per capire le loro intenzioni deliranti».
Per Maurizio Gasparri, capo dei senatori di Forza Italia «hanno ragione quelli di Askatasuna quando dicono che il loro non è un edificio, ma è una proposta, un’attitudine e un atteggiamento. In effetti, è la proposta di praticare il metodo della violenza mettendo a ferro e fuoco le città. È un metodo, quello della prevaricazione, dell’intolleranza, dello stalinismo. È un’attitudine, quella di avere atteggiamenti contrari ai principi fondamentali della legge. Pertanto, Askatasuna non è un edificio e forse non è neanche soltanto una proposta, un metodo, un’attitudine. È semplicemente una tragedia che si è abbattuta sul nostro Paese, che ha prodotto centinaia e centinaia di poliziotti, carabinieri e esponenti della guardia di finanza, feriti in questi anni. Non bisogna soltanto togliergli la sede, bisogna anche infliggergli le giuste condanne che la magistratura ha sin qui esitato a definire nella proporzione adeguata». Insomma il 28 marzo sarà il banco di prova per capire se queste nuove norme potranno realmente limitare i danni e le violenze di queste guerriglie urbane.
Rispetto alla misura del fermo preventivo, si contesta che per gli arrestati di Torino non si poteva applicare perché i violenti risultavano tutti incensurati. Piantedosi però ha chiarito che non si valuteranno solo i precedenti ma anche tutte quelle azioni che possano portare a pensare la predisposizione allo scontro: «Si valuteranno anche altri comportamenti univoci ed eloquenti, ad esempio proprio quelli di essersi predisposti agli scontri, rilevabile da oggetti trovati addosso». Altri strumenti da valutare potrebbero essere le conversazioni delle chat oppure il monitoraggio dei social.
Per quanto riguarda l’organico delle forze dell’ordine, anche quello è destinato a crescere. Negli ultimi 3 anni sono stati assunti 40.000 tra uomini e donne in uniforme, nell’ultimo anno 3.500 unità e a giugno ci sarà un’altra tornata. Sino al 2027 avremo altre 30.000 unità: «Dobbiamo coprire il turn over che abbiamo trovato dei pensionamenti, ma soprattutto adeguare le forze di polizia anche alle strumentazioni: dai guanti anti-taglio che non c’erano ai mezzi per bloccare dei cortei violenti come quelli che abbiamo visto», ha spiegato il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro, aggiungendo: «Abbiamo dovuto rafforzare i presidi nelle grandi stazioni e nei pronto soccorso. Vediamo quello che avviene nelle tante piazze italiane. Quello che chiede il cittadino è sicurezza che purtroppo si avverte spesso essere traballante. Ma parliamo anche di nuovi pericoli, di forme eversive. Ciò che è avvenuto ad Askatasuna è una forma eversiva. Noi siamo il Paese che ha concesso in Europa più libere manifestazioni».
Sul decreto, Ferro spiega che queste nuove misure rispondono a nuove urgenze come «il fermo preventivo di 12 ore in occasioni di manifestazioni dove le forze di polizia hanno elementi per essere preoccupate».
Continua a leggereRiduci
Ansa
Una decisione, quella di sgomberare lo storico edificio in corso Regina Margherita, che Askatasuna stigmatizza alla stregua «di un attacco al centro e un attacco alla città». E se di offensiva si tratta, stando alla logica, è giusto rispondere. Anche con la violenza. Perché anche se qualcuno ad Askatasuna ci prova a prendere le distanze dall’uso della forza, poi contestualizzando e complessificando alla fine si finisce sempre per giustificarla. «Aggredire un agente è grave ma voi ignorate la rabbia sociale», ha ammesso Andrea Bonadonna, storico leader e fondatore del centro sociale a La Stampa. Rabbia sociale contro il governo Meloni e chi mette a repentaglio gli spazi sociali. Parlando con i media, ieri i portavoce di Askatasuna hanno ribadito che l’obiettivo è ridare lo stabile a tutte le realtà che l’hanno sempre attraversato dal basso resistendo alle logiche del terzo settore o di pubblico-privato che lo andrebbero a snaturare. «Lo stabile deve continuare ad essere a disposizione dei cittadini con spazi mantenuti gratuiti a libero accesso». Tema, quello degli spazi sociali, di cui si potrebbe anche discutere. L’immagine presentabile a favore di telecamere fa però a pugni con quella sempre troppo pronta a strizzare l’occhio alla violenza. Lo lascia intendere Bonadonna. «Adesso credo che il governo ci penserà tre volte prima di sgombrare un altro centro sociale». Come a dire che alla fine gli scontri hanno fatto gioco agli autonomi. Altro che black block infiltrati. Con buona pace delle teorie cospirative secondo cui gli scontri sarebbero stati un assist al governo.
Ne sa qualcosa uno degli assalitori del poliziotto, come riportato ieri da La Verità. Tale Leonardo, di vent’anni e immortalato nel video che ha scosso il Paese intero con l’immagine del poliziotto Calista accerchiato e salvato dal collega Lorenzo Virgulti cui proprio ieri è stata riconosciuta la benemerenza civica dall’amministrazione di Ascoli Piceno. «Se vai a manifestare per lo sgombero di Askatasuna ovviamente un minimo di lotta la devi fare» ha dichiarato il picchiatore. «I compagni vogliono una rivolta seria, non vogliono fare la passeggiata del sabato». Arrestato dopo gli scontri è già stato rilasciato. Libero di tornare «a combattere» contro lo Stato, contro i poliziotti e di dare man forte ai militanti che ora Askatasuna chiama nuovamente a raccolta. Prima una due giorni a Livorno «per un confronto sulle modalità di lotta» e poi il 28 marzo a Roma. Nel tentativo di non disperdere l’opposizione sociale che a suo dire si sarebbe consolidata con «il grande successo» del 31 gennaio e 50.000 manifestanti. Ci sono fatti gravi ma Torino non è mai stata avulsa dai conflitti sociali, ripetono quelli del centro sociale. «Voi guardate il dito e non la luna». Insomma, questione di prospettive. E di capacità interpretative, visto che Askatasuna motiva l’appuntamento nella capitale con l’esigenza «di costruire un confronto a partire dalle modalità che si sono date, ossia quelle del blocchiamo tutto». Strano modo di cercare un dialogo.
In vista di Roma, Askatasuna continua con gli ammiccamenti alla linea dura conditi da un po’ di diplomazia. Equilibrismi che sembrano andare a nozze con quell’area grigia di supporter di matrice colta e borghese evocata dal Procuratore generale di Torino Lucia Musti. Una linea sottile tra legalità e illegalità dove gli ossimori non si escludono. Come nel solito refrain già proposto a Torino. «Continueremo a portare in piazza l’opposizione sociale al governo e contro le guerre». Strano modo di chiedere la pace
Tutto questo proprio mentre nelle scorse ore, gli atti di sabotaggio sulle linee ferroviarie di Bologna e Pesaro di sabato scorso vengono rivendicati dai movimenti anarchici. Con un documento che alza ancora di più il livello dello scontro. «Pare necessario armarsi degli strumenti della clandestinità, della decentralizzazione del conflitto e la moltiplicazione dei suoi fronti, dell’autodifesa e del sabotaggio per sopravvivere ai tempi cui andiamo incontro». E poi «fuoco alla Olimpiadi e a chi le produce», con tanto di collegamento con quanto accaduto due anni fa quando prima dei Gioghi di Parigi vennero vandalizzate cinque infrastrutture attorno alla capitale francese. Dura la reazione del ministro dei Trasporti Matteo Salvini che promette di «inseguire e stanare questi delinquenti ovunque si nascondano».
Continua a leggereRiduci