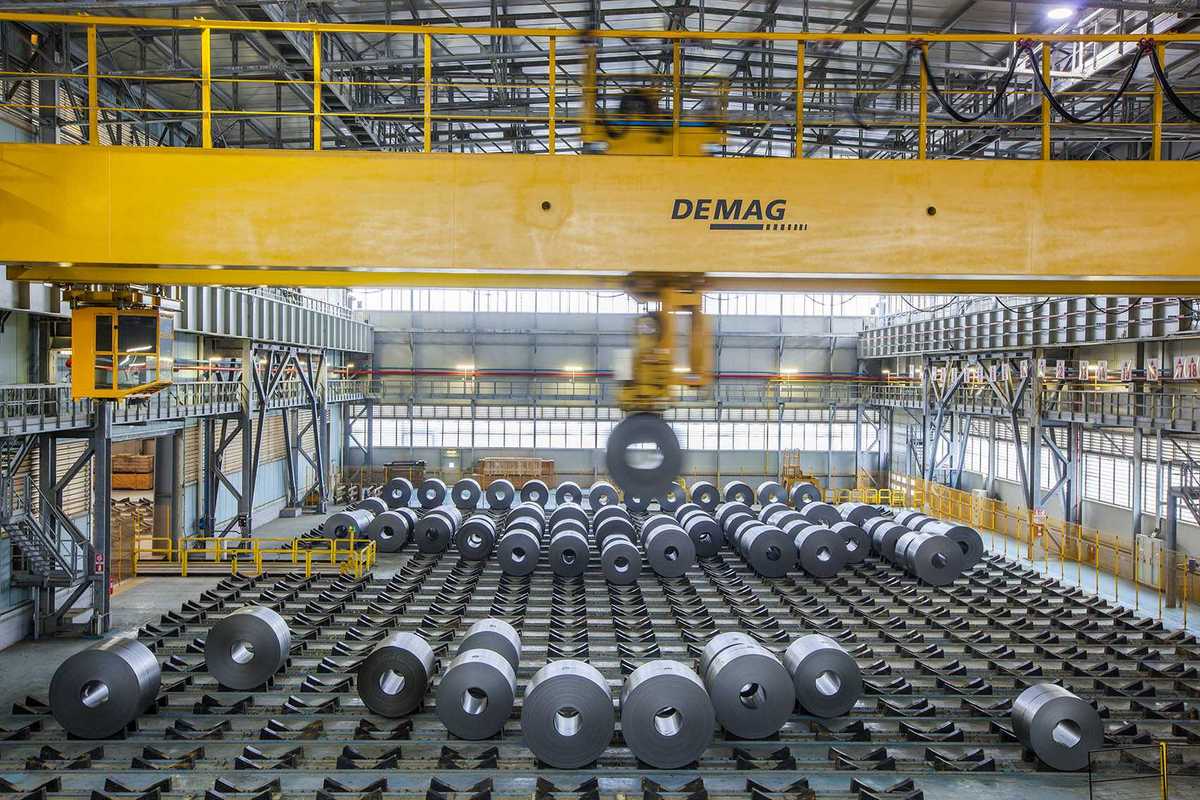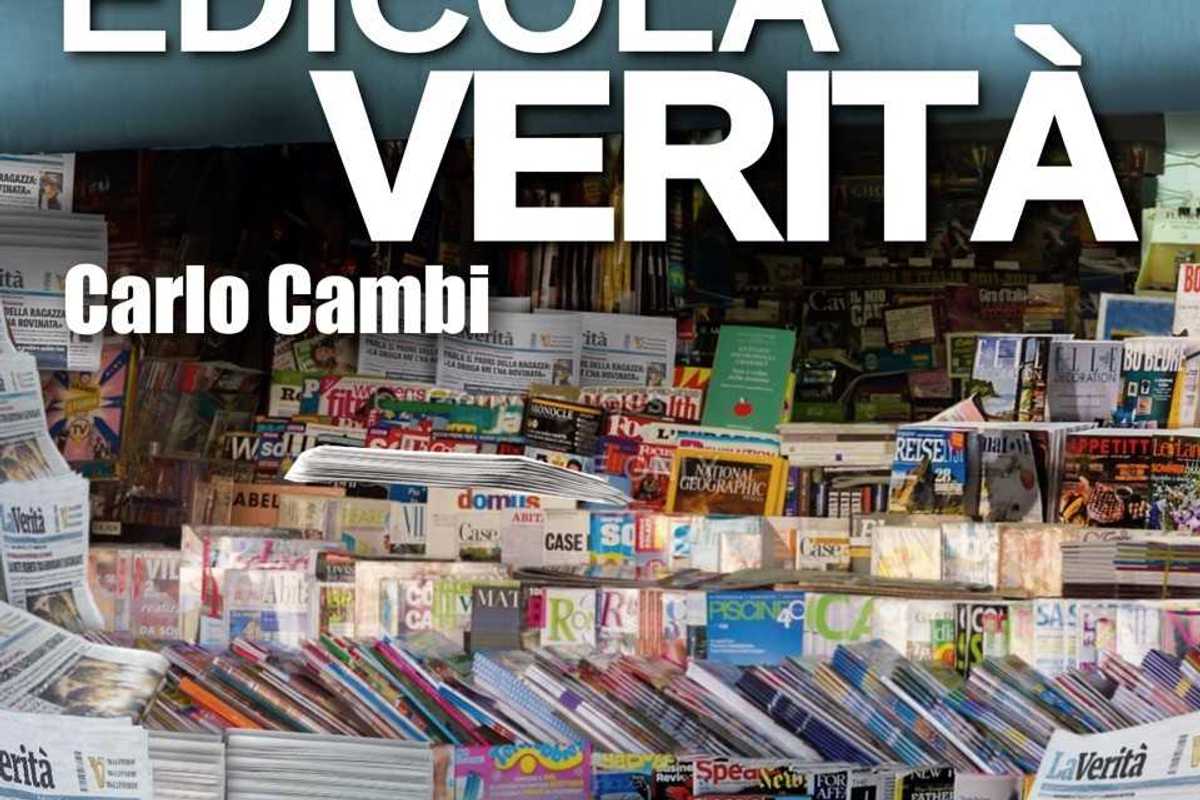Londra studia i danni dei bavagli in classe. Qui ragazzi e maestri devono usarli ancora

La propaganda del vecchio governo assicurava: gli alunni italiani sono liberi dalle mascherine. La realtà è un’altra: le mascherine ancora si usano.
I protocolli concordati da Roberto Speranza e Patrizio Bianchi, ex ministri di Salute e Istruzione - protocolli mantenuti dall’esecutivo di Giorgia Meloni, che si è insediato a lezioni già cominciate - impongono l’utilizzo delle museruole ai contatti stretti dei positivi (Ffp2 per dieci giorni) e agli studenti che manifestino sintomi sospetti. Insomma, basta un naso che cola e si finisce imbavagliati. In più, c’è la prescrizione rivolta ai fragili, cioè al personale e ai ragazzi «a rischio di sviluppare forme severe di Covid-19»: per loro, i dispositivi di protezione delle vie respiratorie restano pane quotidiano. Infine, qua e là, lungo la Penisola, spuntano presidi zelanti. O ipocondriaci. Che ripristinano, in varie modalità, l’obbligo di fasciarsi naso e bocca. Un paio di esempi: dieci giorni fa, al liceo scientifico Paolo Lioy di Vicenza, la dirigente Rossana Eberle aveva reintrodotto le mascherine coatte per tutti «fino all’attenuarsi dei contagi». A Carini (Palermo), con stravagante ridondanza rispetto alle regole già vigenti, la preside dell’istituto superiore Ugo Mursia, Simonetta Calafiore, ha firmato una circolare per costringere lavoratori e alunni a rischio a indossarle. Benché, appunto, le norme già lo prevedano. Spia che le leggi esistono, ma poi vengono applicate con ampi margini di tolleranza? Forse è proprio questa elasticità, questa mano che lava l’altra, ciò che salva il Paese?
C’è però una cosa che, in Italia, nessuno si preoccupa di fare: una valutazione dell’impatto che certe misure, di dubbia efficacia, hanno avuto sui ragazzi e sugli insegnanti. È uno strano concetto di previdenza: l’Oms dice che siamo immersi in una «permacrisi»; Ursula von der Leyen che viviamo nell’«era delle pandemie»; ma nello Stivale, non ci stiamo preparando alla prossima, asseritamente inevitabile emergenza sanitaria. O almeno, non stiamo verificando quali provvedimenti funzionano, quali sono inutili e qual è, per ciascuno, il rapporto tra costi e benefici.
Un lavoro del genere lo hanno portato avanti nel Regno Unito, dove il ministero dell’Istruzione ha promosso un ampio sondaggio sull’impiego delle mascherine tra i banchi, contattando genitori, figli e docenti. Il report è stato appena pubblicato. Alle domande sull’uso dei Dpi hanno risposto 2.396 mamme e papà, 1.810 bambini tra 7 e 11 anni, 2.153 adolescenti di 12 e 13, 310 prof e 80 tutor. I risultati potrebbero sorprendere solamente i nostalgici dei «visi coperti», rimpianti in un famigerato editoriale da Caterina Soffici.
Se un buon numero di ragazzini conviene con l’idea che le mascherine abbiano trasmesso un senso di sicurezza (lo sostiene il 50% degli alunni tra 7 e 13 anni) e che servissero a preservare gli altri (è d’accordo il 75% di loro), molto diverso è stato l’effetto che imbavagliarsi ha provocato su apprendimento e socializzazione.
Le statistiche sono eloquenti. Il 49% degli scolari tra 7 e 13 anni ritiene che l’uso delle mascherine abbia reso più faticoso imparare. Tra gli alunni di etnia caucasica, lo pensa addirittura il 52% del campione, percentuale che scende al 42 tra gli oriundi asiatici. Il 66% degli studenti, poi, concorda sul fatto che i Dpi abbiano complicato la comunicazione con gli insegnanti e il resto del personale scolastico. Il 52% è convinto che abbiano ostacolato le interazioni con i compagni.
Anche i docenti sono apparsi perplessi. Il 49% conferma che apprendere, per gli alunni, era diventato più arduo. Il 66% che le mascherine hanno peggiorato la qualità della comunicazione. Non sorprende che il dato salga al 75% del totale degli intervistati, quando il quesito verte sulle difficoltà dei giovani affetti da patologie come l’autismo e altre disabilità.
Una minoranza, comunque non trascurabile (21%), di bambini tra 7 e 13 anni ha accusato problemi d’ansia collegati all’utilizzo delle coperture di naso e bocca. Anche in questo caso, l’inconveniente è stato più frequente nelle categorie svantaggiate: i piccoli con disabilità, o quelli provenienti da famiglie a basso reddito. I docenti tracciano un quadro persino peggiore: è il 59% di loro a ricordare crisi ansiose negli alunni con disturbi cognitivi.
Tutti elementi che lasciano emergere, nella sua crudezza, il lato più oscuro dei provvedimenti anti Covid: la profonda ingiustizia sociale sulla quale si sono incistati e che hanno contribuito ad aggravare.
Ciliegina sulla torta: secondo i maestri, le mascherine sono state «un ulteriore pretesto per il disordine in classe: potevano essere lanciate nell’aula, o sfruttate per celare il chiacchiericcio a bassa voce». Croce per i diligenti, delizia per i discoli. Il cui comportamento era comunque peggiorato durante la pandemia, complice il confinamento. A quell’età, stare tra i coetanei è d’importanza vitale.
Le conclusioni della relazione governativa sono oneste. Il testo riconosce che indossare i bavagli «ha posto alcune sfide», che secondo i docenti «ha creato una barriera all’insegnamento e all’apprendimento» e che «ha esacerbato difficoltà già fronteggiate da gruppi specifici», tipo i disabili e i figli di famiglie indigenti. «È stato riferito anche che le coperture del viso hanno influenzato la salute fisica e mentale» di numerosi alunni. Guai la cui mitigazione è stata affidata alle creative «strategie» dei docenti. Ma sui quali sarebbe opportuno aprire una riflessione. In caso di nuove emergenze, è meglio non ripetere gli stessi errori. Perché ci bombardano con il dogma della resilienza; ma così passeremo direttamente all’amnesia.