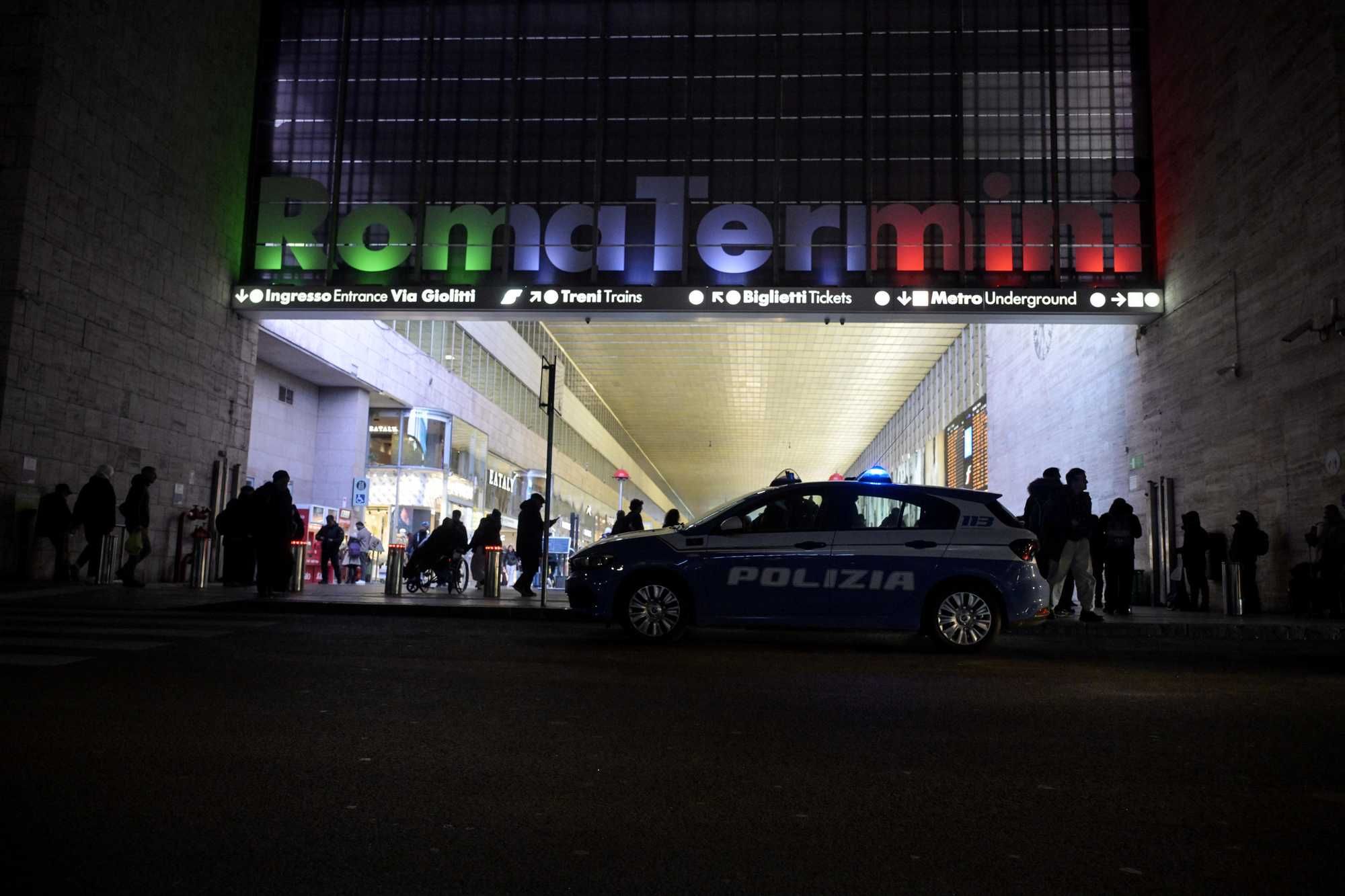Magia del foliage e fiammate poetiche rendono più caldi i colori dell’autunno

Ogni epoca ha le proprie parole. Siamo sopravvissuti al dilagante maoismo, siamo sopravvissuti ai figli dei fiori e agli hippy, quindi siamo sopravvissuti, invero un po' ammaccati, alla corrosiva fascinazione di potere al popolo e potere operaio, a tutte quelle simpatiche e canagliesche invenzioni novecentesche che dovevano ribaltare il mondo intero, e per fortuna a qualcosa sono pure servite. Se uno ripensa alle condizioni di molta gente ai tempi in cui Ermanno Olmi ha ambientato l'indimenticato Albero degli zoccoli, e pensa agli stili di vita odierni, qualche passo in avanti è pur stato fatto. Sia chiaro, governano sempre pochi e le possibilità eventuali di cambiamento sono sempre nelle mani di élite ristrette, ma almeno certe forme di servitù sembrano aver cambiato indirizzo, sebbene i problemi siano ancora molti e folti. E non parliamo dello spavento e degli impedimenti che il Covid-19 ha portato e sta tutt'ora disseminando.
Una delle parole che nelle ultime stagioni si è imposta è foliage. Delicato termine dal sapore parigino, sembra quasi un condimento da caffetteria d'antan: Bonjour, mi dia per cortesia un foliage! Invece è una parola che si usa in autunno per indicare il cambio di colorazione degli alberi caducifoglia. Sebbene il foliage sia abbinato alla presenza di un bosco, il foliage può essere campestre oppure urbano, possiamo ammirare il cambio di colorazione delle foglie che si preparano a cadere sulle nostre panchine e sulle nostre strade in una città qualsiasi, grande, media o piccina, così come sui fianchi forestati di una montagna in Alto Adige, nel Parco dello Stelvio piuttosto che a Palermo, a Roma, a Torino o a Nuova York.
La mia generazione è cresciuta con le maestre che a scuola ci facevano raccogliere le foglie da catalogare, disegnare e scocciare su fogli colorati che poi decoravano, assieme ai ricci delle castagne, le aule di scuola. Erano esercizi elementari di scuola delle foglie, il modo se vogliamo più rapido per imparare ad individuare una foglia di ippocastano, una foglia di platano, una foglia di tiglio e quella di un acero.
Il foliage è una moda che si irrobustisce negli ultimi anni sul confine fra Stati Uniti e Canada, in stati boscosi quali il piccolo e democratico Vermont, e le vastità canadesi. Precipita in Italia da un decennio a questa parte e alimenta un vasto indotto turistico, come dimostrano gli immancabili articoli che quotidiani e riviste - ma oramai sei bravo, anzi un genio se scovi le differenze - che a ottobre compaiono con foto di boschi ingialliti, fiabeschi, nostalgici. Per anni me ne chiedevano, quando ero una delle poche firme che si occupavano di alberi non in termini scientifici, oggi, che tutti o quasi se ne occupano con egual competenza ovviamente, e per fortuna, posso evitare di riproporre l'ennesimo elenco dei boschi assolutamente imperdibili. Che poi, quale bosco, se è un bel bosco, non è di suo imperdibile?
Facendo qualche passo indietro merita di andare a focalizzare alcune letture utili a capire da dove venga questo foliage. Ultima opera dell'americano Henry David Thoreau (1817-1862), Autumnal Tints venne pubblicata per la prima volta nell'ottobre 1862 sulle pagine della rivista Atlantic monthly, e ci racconta come mai i boschi nordamericani siano così vistosi in autunno: «Gli europei che giungono in America sono sorpresi dalla smagliante livrea assunta dalla nostra vegetazione in autunno […] La foresta stessa e la verzura dei campi, questa epidermide terrestre deve così acquisire la sua brillantezza quale prova della propria maturazione, quasi che il nostro globo medesimo altro non fosse che un frutto sospeso al suo picciolo, che perennemente rivolga una gota al sole». Qui già abbiamo una dimostrazione dell'adorabile capacità / abilità di Thoreau di descrivere e paragonare, di concepire immagini impreviste per fare fuoco sui dettagli del mondo che lo circondano, del mondo naturale, anzitutto. È proprio grazie a queste fiammate poetiche che noi continuiamo a leggerlo e pubblicarlo, a tradurlo, a citarlo, da generazioni.
Nei brani che compongono Tinte autunnali, Thoreau si cimenta nella catalogazione delle piante che rendono l'autunno del suo mondo così vivido e arlecchinesco: panicella purpurea, fitolacca, brecco, barba forcuta, sorgo, acero rosso, olmo americano, acero zuccherino, edera e quercia rossa, a cui dedica un intero capitolo: «La quercia rossa esige cieli tersi e la luce dei giorni di fine ottobre». Gli alberi e le piante vengono analizzati nelle proprietà estetiche, tanto che «dovrebbero essere piantati lungo le vie anche soltanto in considerazione della sagra di colori ch'essi sogliono allestire per noi in ottobre», suggerisce con quel suo malcelato tono saccente.
Sappiamo che Thoreau ha dedicato molto tempo a camminare lungo i sentieri, a perdersi nello sguardo squadernante dei boschi del Massachusetts, dai fatidici due anni circa passati in una minuscola capanna addossata alle rive del piccolo lago di Walden, nella proprietà degli Emerson (Ralph Waldo, suo mentore, era professore all'università, oltre che poeta e autore rinomato), ma anche in seguito, quando si rifiutò di pagare le tasse per sostenere le spese militari del proprio Paese e scrisse altre opere immerse nella natura, come I boschi del Maine, Camminare, Walden e Cape Cod. e i suoi journals, recentemente tradotti da Mauro Maraschi.
In Italia abbiamo diverse edizioni di Autumnal Tints, ne cito due: Colori d'autunno, a cura di Massimo Scorsone, dalla quale ho attinto gli stralci riprodotti in precedenza, pubblicato da Lindau nella bella collana Piccola biblioteca, dove affianca altri titoli quali Camminare, Mirtilli ed Una passeggiata d'inverno. E Tinte autunnali, a cura di Chiara Gallese, per Galassia arte, nella collana Le sequoie.
Ascolto musicale del giorno: le foglie cadono, i cieli incominciano a scurirsi presto, la nostra malinconia è vigile. Perché non farci cullare dalle canzone sussurrate di Elliott Smith, agente del caos dei miei vent'anni? Mi torna sempre questo nodo in gola quando ci ripenso, i dischi - o i cd -
che fecero epoca, nonostante non fosse il classico adone e non facesse ricorso alle solite forme di marketing quali video e tour mondiali. Erede manco a dirlo di figure magnetiche e iellate, come Nick Drake e le divinità con chitarra dei morti a ventisette anni, Smith ci ha lasciato canzoni lancinanti, che potete ascoltare, ad esempio nel doppio New Moon (2007, Domino), una sorta di the best of, anche se Smith va ascoltato tutto. Quando il suo corpo venne trovato senza vita purtroppo era il 21 ottobre 2003: aveva soltanto 34 anni.