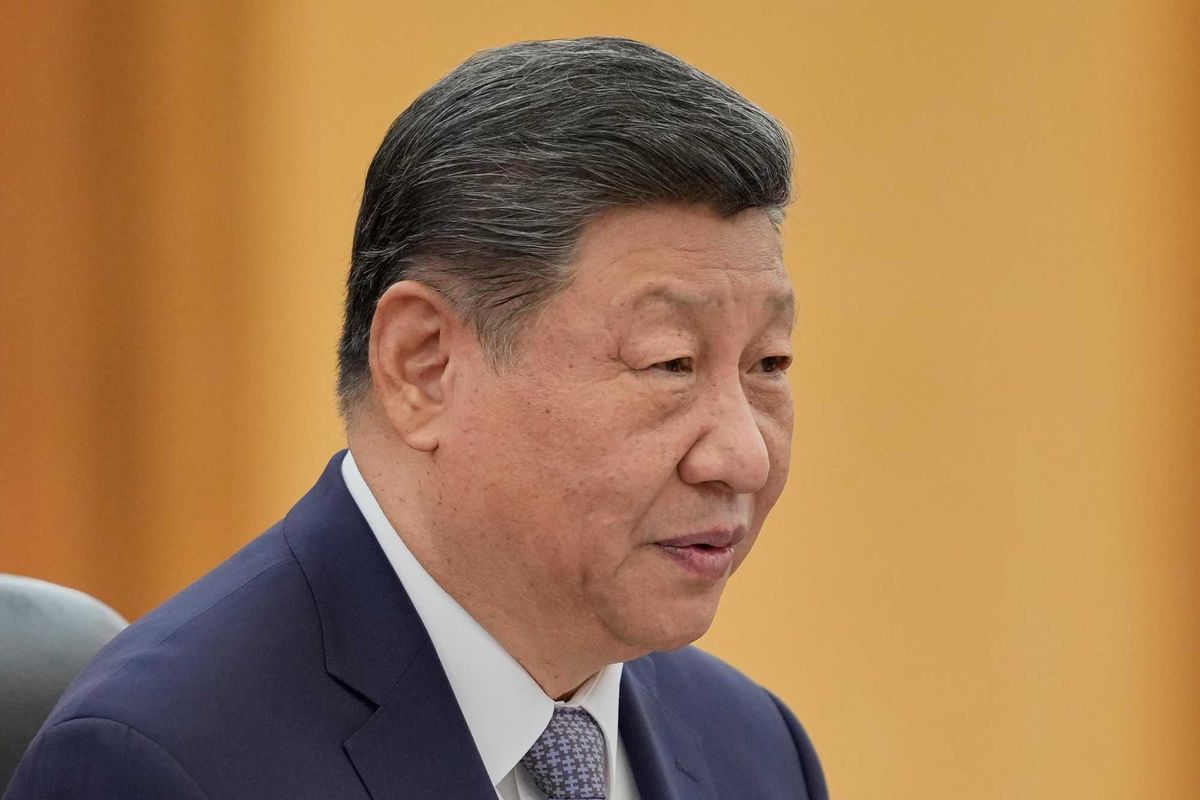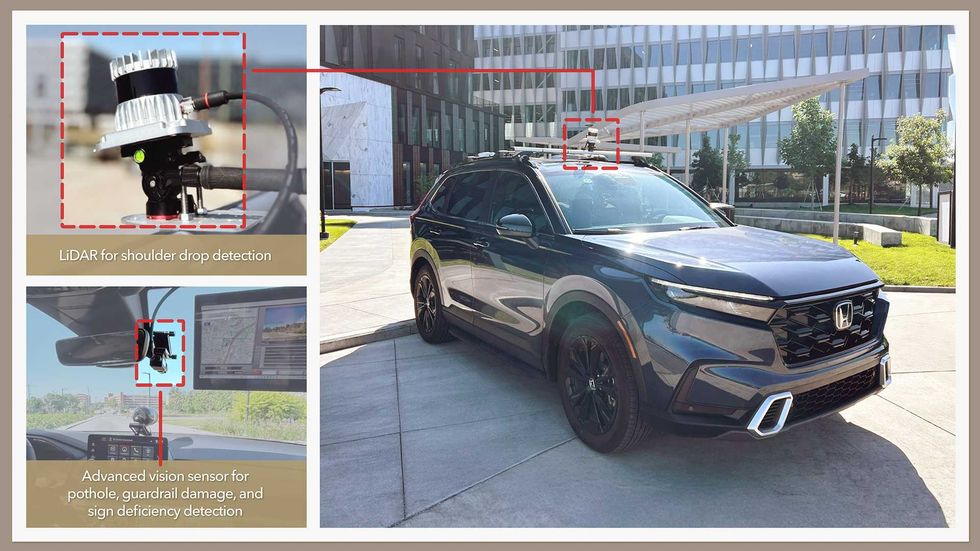Luigi Curini, da scienziato della politica, che giudizio dare alle reazioni mediatiche susseguitesi all’omicidio dell’attivista conservatore americano Charlie Kirk? Spesso quelle reazioni sono tese quasi a giustificare la cosa. Se non in maniera esplicita, quanto meno implicita.
«Non mi hanno stupito. Bensì hanno confermato tutte le mie aspettative. Viviamo in un mondo ad elevata polarizzazione affettiva. La controparte non è un avversario ma sempre un nemico che appartiene a un’altra tribù. Da disumanizzare. Fenomeno che riguarda non solo la politica. Durante il Covid, chi criticava il Green pass era un “no vax”. E nel termine era implicita questa totale disumanizzazione di chi non la pensa come me. Con una simile controparte non si può scendere a compromessi. Farlo è per definizione un’onta. Deve essere sempre silenziata per arrivare financo a considerare l’assassinio come una modalità di gestione del confronto. Su cui posso dissentire ad alta voce, anche per mettermi in pace la coscienza, ma tutto sommato comprenderne la necessità».
Oltre la metà degli elettori democratici americani non si indigna di fronte all’ipotesi di un omicidio di Donald Trump.
«È quanto emerso da un’importante ricerca fatta ad aprile dal Network Contagion Reserach Institute dopo che sui social media molte persone avevano giustificano - se non addirittura esaltato- l’assassinio di un dirigente di un’assicurazione sanitaria privata compiuto da Luigi Mangione. L’utilizzo della violenza che arriva all’assassinio viene sdoganato. Dal sondaggio emergeva che una parte non banale degli americani, soprattutto nella parte democratica, arrivava a legittimare l’assassinio di Donald Trump o di Elon Musk. Soprattutto fra i giovani universitari. Guarda caso il contesto in cui Kirk è stato ucciso. In un certo senso era tutto già tristemente prevedibile».
Ma che aria tira nelle università italiane?
«Da quello che vivo all’Università degli Studi di Milano dove lavoro, continua a esserci una forte differenza rispetto a molti campus americani dove spesso ahimé si insegna che ogni forma di disaccordo è dannosa, e in cui quindi la possibilità di avere una posizione diametralmente differente tra il corpo docente e gli studenti diventa una scelta rischiosa. Per arrivare al paradosso che i docenti non schierati su posizioni progressiste scelgono, in quella che dovrebbe essere dopotutto la sede principale di dibattito e di confronto, la strada del silenzio perché temono reazioni da parte degli studenti. Quelle reazioni che invece Charlie Kirk cercava. Questa deliberata autocensura che i docenti e anche gli studenti americani non di sinistra spesso compiono, nelle università italiane non l’ho ancora percepita nella sua drammaticità. Certo le recenti aggressioni all’Università di Pisa o di Torino non rassicurano e possono essere un campanello di allarme».
Questa polarizzazione può portare anche al terrorismo? Fenomeno che abbiamo conosciuto in Italia negli anni Settanta.
«Ci sono elementi in qualche modo sono comuni con gli anni Settanta. La frase “uccidere un fascista non è reato” ritorna e rappresenta che cosa, se non ancora una volta la totale e completa disumanizzazione della controparte?»
L’epiteto che giustifica l’esecuzione.
«Però ci sono anche importanti differenze. La più importante è che viviamo in un mondo molto più disintermediato rispetto agli anni Settanta. Stiamo sui social in modo individuale. Non come gruppi o collettivi. La dinamica di interazione con gli altri è quindi molto più individualizzata. Questa circostanza può favorire casi come quelli del singolo che prende il fucile e uccide Charles Kirk, perché l’oltraggio e l’odio che corre veloce online può avere profonde conseguenze per alcuni. Ma rende più difficile lo sviluppo di un movimento antagonista ed organizzato sul modello delle Brigate Rosse. Insomma, se la disintermediazione social, come spesso si sente dire, crea un problema di coesione sociale, almeno mi pare fare da ostacolo per la possibile rinascita del terrorismo organizzato».
Charlie Kirk, con provocatoria abilità, dava voce al sentire della classe media. In America detto common sense. Sposarsi, avere una famiglia, un lavoro, una bella casa, vivere in un quartiere tranquillo senza delinquenza. Una volta tutto questo sarebbe stato definito «piccolo borghese» dall’intellettuale che quasi si vantava di un pensiero estremo. Oggi invece l’intellettuale dà dell’estremista a colui che ambisce a questa normalità. Un rovesciamento semantico stupefacente.
«Fenomeno interessante e paradossale. Negli anni Settanta, i punti che tu hai sollevato giustamente erano oggetto di critica perché chi li sosteneva era visto come parte costitutiva del sistema da abbattere. Culturalmente quello era ciò che l’intellettuale combatteva».
Che oggi invece difende come un guardiano ed anzi lo impone.
«Esattamente. Perché adesso il “sistema” è diventato lui. D’altra parte tutto il dibattito sul populismo verte su questo crescente iato. Ovvero sulla distanza tra l’élite in senso ampio e i comuni cittadini. Per mainstream culturale non intendiamo solo gli intellettuali ma anche i media e buona parte dei ceo in giro per il mondo. Se il mainstream culturale è oramai identificato con quella roba lì, il fatto che il cittadino comune abbia una posizione differente è completamente irrilevante. Tant’è vero che l’accusa tipica che si fa ai cittadini è di essere “analfabeti funzionali”; di credere alla disinformazione, e via dicendo. Un mainstream culturale che sa di essere minoranza in cuor suo, ma che non si percepisce come tale. L’idea è “noi abbiamo già ragione e se non siamo maggioranza è semplicemente perché gli elettori sono stupidi. Perché se invece fossero intelligenti come noi e non credessero alla disinformazione che c’è su Internet, ecco che loro la penserebbero come noi”»
«Il Comitato centrale ha deciso. Poiché il popolo non è d’accordo bisogna nominare un nuovo popolo» scriveva Bertol Brecht.
«Ci stavo arrivando. Un approccio straordinariamente elitista molto più marcato di quello che c’era nel passato. Negli anni Settanta, negli anni Sessanta, il mainstream culturale era ancora in grado di sollevare tutta una serie di tematiche che parlavano alla gente comune. Oggi invece in questo mainstream la gente comune fa molta più fatica a trovare punti di contatto».
L'allontanamento di Jimmy Kimmel dal suo show in America scatena l’indignazione della sinistra. Secondo cui sarebbe in ballo la libertà di espressione. Che lettura dai di questo allontanamento?
«In primo luogo, è interessante scoprire come chi in questi ultimi anni è stato zitto, oppure ha abbracciato la cosiddetta “cancel culture” e preso in giro definendo estremisti chiunque difendesse il tema “free speech” – perché, sia chiaro, l’hanno fatto in questi ultimi dieci anni – improvvisamente riscopre il tema. Solita doppiezza. L’atteggiamento che in qualche modo cambia a seconda della circostanza. Questo è il primo punto. Il secondo punto è che c’è stata anche un’alzata di scudi a destra da una parte del mondo Maga contro l’idea di mettere fuori legge i cosiddetti Antifa in America. Noi siamo diversi rispetto a quelli di sinistra, dicono. Il terzo punto fondamentale, venendo al caso specifico, riguarda il network Abc dove Kimmel lavorava. A differenza di Cnn, proprietaria dei cavi su cui trasmette, ha bisogno di licenze per usare l’etere. E quindi è più sensibile agli umori della politica e della Casa Bianca. Le pressioni di Trump non sono proprio impercettibili. Mettiamola così».
Parli di polarizzazione affettiva e molti utenti social hanno delle caratteristiche fisiognomiche, oserei dire quasi antropologiche, comuni nel festeggiare l’omicidio di Kirk: capelli colorati, anello al naso e tatuaggi molto visibili. C’è una spiegazione dietro tutto questo?
«La polarizzazione affettiva estrema rinvia esattamente al concetto di lotta tribale. E cos’hanno in comune le tribù? Le tribù, ogni tipo di tribù, hanno la necessità di mostrare agli altri quelli che sono i segni distintivi di chi a questi consessi orgogliosamente appartiene. È fondamentale. Sono i segni distintivi che permettono il riconoscimento immediato che tu appartieni alla mia stessa tribù. Nel momento stesso in cui questa polarizzazione affettiva è così forte, i segni tribali sul nostro corpo devono aumentare. E crescono d’importanza perché sono un segnale credibile del fatto che io appartengo a una tribù e non ad un’altra».