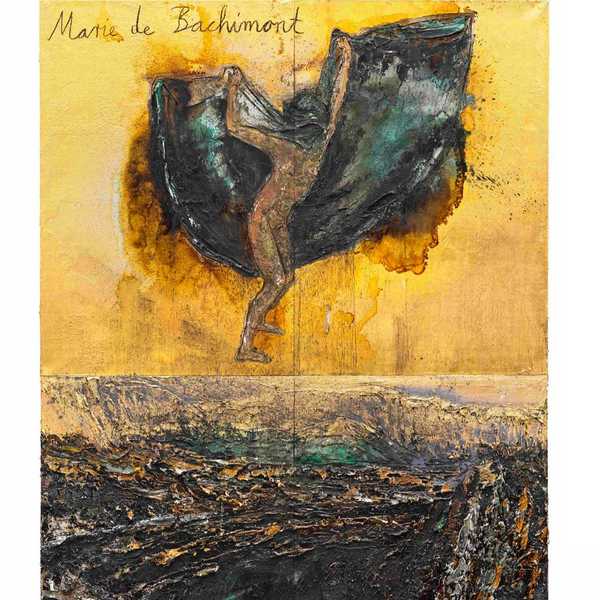Il Governo e la Ue balbettano. Londra tira fuori 170 miliardi

- Liz Truss annuncia le nuove misure anti crisi che prevedono tariffe massime per famiglie e aziende, trivellazioni e fracking. Obiettivo: esportare entro il 2040.
- Il tetto al gas russo è già sfondato. Ue divisa pure sugli extraprofitti. Al vertice di oggi intesa solo su aiuti alle aziende, razionamenti e limite ai ricavi dei produttori di elettricità. Gli Stati membri contestano un «price cap» circoscritto all’export da Mosca: il verdetto slitterà a ottobre.
Lo speciale comprende due articoli.
Per la seconda volta consecutiva (era già accaduto ai tempi della pandemia), la Gran Bretagna post Brexit dà una lezione all’Ue. Nel caso del Covid, il Regno Unito aveva opportunamente scelto di divergere dalla linea di Bruxelles: e così Londra ha trionfato, per un verso scegliendo la strada della libertà (chiusure limitatissime, riaperture anticipate e sistematiche, senza alcun obbligo vaccinale né green pass), e per altro verso - anche rispetto alla vaccinazione volontaria - vincendo la gara in termini di rapidità dell’approvvigionamento di dosi e di ritmo della campagna vaccinale.
Nel caso della crisi energetica, lo schema sembra ripetersi. Mentre l’Ue si accinge alle consuete e spossanti trattative tra i 27, la Gran Bretagna si muove con maggiore tempestività, e decide di stanziare somme di denaro non paragonabili rispetto a quanto fatto (o annunciato) dai maggiori Paesi dell’Europa continentale. Il tutto all’interno di una strategia convincente: senza ecofondamentalismi, puntando a un mix energetico in grado di garantire un’autonomia sempre maggiore, e proteggendo sia le famiglie sia il sistema produttivo.
La neo primo ministro Liz Truss è dunque partita con il piede giusto, pur in un quadro economicamente e socialmente difficile, e non ha avuto remore nel differenziarsi sensibilmente dalla linea di Boris Johnson, che aveva avuto il torto di esagerare sulla linea green, impegnando il Paese in una riduzione delle emissioni troppo rapida e rischiosa per il sistema produttivo.
«Ora è il momento di essere audaci: stiamo affrontando una crisi energetica globale e non ci sono opzioni a costo zero», ha detto la Truss, che per prima cosa ha fatto lievitare da 130 a 150 miliardi di sterline, ovvero oltre 170 miliardi di euro (tra aiuti e tagli di tasse) l’impatto del suo piano contro il caro energia. Naturalmente, nei prossimi giorni, toccherà al ministro delle Finanze Kwasi Kwarteng entrare nei dettagli, ma la Truss ha già fornito gli elementi essenziali.
Il piano si articola in sette punti fondamentali. Il primo è la protezione dei consumatori, attraverso la fissazione per due anni di un tetto massimo alle bollette: non più di 2.500 sterline l’anno (circa 3.000 euro, 250 al mese), proprio mentre si temeva (già da ottobre) un’impennata dei prezzi dell’80%. Secondo le stime, ogni utente risparmierà almeno 1.000 euro rispetto agli aumenti: e questo intervento si somma al bonus di 400 sterline per famiglie che era già scattato ai tempi di Johnson.
Il secondo punto è il congelamento per sei mesi del prezzo dell’energia per le imprese. Il terzo, quarto e quinto punto hanno a che fare con un massiccio via libera a tutte le altre attività che possano - in prospettiva - aumentare la produzione nazionale di energia e realizzare l’obiettivo strategico dell’autonomia energetica della Gran Bretagna. Dunque, sì alle estrazioni di petrolio e gas nel Mare del Nord (con oltre 100 nuove licenze di esplorazione ed eventualmente trivellazione ed estrazione); sì al nucleare; sì al fracking (su cui finora esisteva un bando), e cioè semaforo verde alla tecnica di estrazione di gas e petrolio dalle cosiddette rocce di scisto, naturalmente acquisendo il consenso delle comunità che vivono sui territori interessati.
Il sesto punto, come accennato, consiste nella revisione della linea di Boris Johnson: entro fine anno, Lizz Truss propone di ridiscutere l’obiettivo eccessivamente ambizioso della neutralità carbonica in Gran Bretagna entro il 2050.
Il settimo punto riguarda il no alla tassazione sui profitti in più delle compagnie energetiche (misura richiesta a gran voce dai laburisti: ma la Truss non intende aumentare la pressione fiscale in nessuna direzione). Non solo: anche rispetto al tema degli obiettivi ambientali più complessivi, tutto dovrà essere ripensato per non devastare le imprese e per non arrecare danni insanabili al tessuto produttivo britannico.
Su queste basi, l’obiettivo finale è non solo quello della agognata indipendenza energetica, ma addirittura quello di fare del Regno Unito un esportatore netto di energia da qui al 2040. Si tratterebbe di un’autentica rivoluzione, che porrebbe la Gran Bretagna in linea con quanto già accade negli Stati Uniti.
Nessuno si nasconde le difficoltà con cui la Truss dovrà inevitabilmente misurarsi, ma il suo preannuncio merita apprezzamento e incoraggiamento per svariate ragioni. Intanto, perché - pragmaticamente - unisce il realismo di un immenso e immediato stanziamento di denaro (per mitigare danni altrimenti devastanti) alla lungimiranza di chi non rinuncia a una strategia di lungo periodo (tagli di tasse, approccio pro impresa, e aspirazione all’indipendenza energetica). E poi perché mostra a tutti un’altra evidenza: qualunque cosa ciascuno pensi delle sanzioni alla Russia e della transizione green, non è possibile portare avanti insieme le due cose. La Truss, coerentemente con la sua impostazione politica, ha scelto di non rinunciare alle sanzioni: ma allora ha saggiamente tirato il freno rispetto all’ecofondamentalismo contro le fonti fossili.
Il tetto al gas russo è già sfondato. Ue divisa pure sugli extraprofitti
Saranno sul tavolo i cinque punti illustrati da Ursula von der Leyen nella conferenza stampa di mercoledì. Su tre di questi non dovrebbero esserci particolari difficoltà a trovare un accordo, fatta eccezione forse per qualche dettaglio. Il primo punto, le linee di credito urgenti per le compagnie del settore alle prese con una grave crisi di liquidità, che ha già portato a diversi salvataggi pubblici (la tedesca Uniper su tutte), è considerato essenziale praticamente da tutti i Paesi. Stessa cosa si può dire per il secondo punto, cioè la riduzione della domanda energetica attraverso tagli obbligatori dei consumi. Infine, la proposta relativa all’estrazione dei ricavi inframarginali dei produttori elettrici non a gas è già stata sdoganata da Olaf Scholz il giorno dell’annuncio del piano di aiuti tedesco da 65 miliardi di euro e dovrebbe passare, anche se ieri sono emersi i dubbi della Francia sull’entità del tetto ipotizzato dalla Commissione a 200 euro al MWh. Un valore che, in effetti, strozzerebbe i ricavi di EdF che invece necessita di prezzi alti per recuperare marginalità.
Divisioni e disaccordo, invece, sugli altri due temi caldissimi, ovvero la nuova tassa sugli extraprofitti per le compagnie del gas e l’ormai sforacchiato tetto al prezzo del gas russo, su cui la Commissione punta in maniera decisa.
L’idea italiana di un price cap su tutto il gas sul mercato europeo, attraverso un meccanismo di rimborso delle differenze a carico del bilancio Ue, è piaciuta a qualcuno, ma la Commissione sembra intenzionata a difendere la propria idea di tagliare le gambe alla Russia a qualsiasi costo. Di fronte alla rigidità della Commissione, ieri persino il ministro dell’energia belga, la mite Tinne Van der Straeten, ha avuto modo di affermare: «La nostra intenzione è innanzitutto quella di abbassare i prezzi. Un limite al solo gas russo non farà scendere i prezzi. Un limite al solo gas russo è puramente politico». La reazione di Mosca alla decisione europea sarebbe infatti scontata e porterebbe alla chiusura dei gasdotti. Ciò renderebbe i razionamenti ancora più rigidi e i prezzi del gas, per l’inverno, salirebbero anziché scendere. Dunque, il tetto al prezzo del solo gas russo avrebbe sì l’effetto di annullare una importante linea di ricavo per la Russia, ma avrebbe anche un impatto molto negativo sui prezzi.
Dopo sei mesi di discussioni su questo tema (del tutto inadatto rispetto all’obiettivo di abbassare i prezzi), l’elefantiaca Europa è ancora alla ricerca di un compromesso tra gli Stati, i quali hanno diversi rapporti storici e diplomatici con la Russia. Ad esempio, la Polonia e i tre Paesi baltici, che viaggiano a braccetto su tutto ciò che riguarda la Russia, più i Paesi che non dipendono minimamente dalla Russia per il gas, come il Portogallo, sono assai favorevoli all’impostazione data dalla Commissione.
Il Belgio invece preferirebbe un tetto massimo dinamico a livello Ue sul gas trattato al Ttf, collegandolo magari ai mercati asiatici del Lng, analogamente alla proposta italiana. Bulgaria d Ungheria si sfileranno dalla discussione, probabilmente, avendo la prima negoziato un nuovo contratto con la Russia e la seconda avviato una trattativa con Gazprom.
Sul tetto ai prezzi, da Francia e Germania sinora è arrivato solo silenzio. I due Paesi nei giorni scorsi hanno già trovato un accordo di mutuo soccorso e potrebbero presentarsi alla riunione con una posizione comune. Insomma, si procede in ordine sparso, anche per quanto riguarda lo strumento normativo da utilizzare. Un tetto al prezzo del gas nella forma di sanzione richiederebbe l’unanimità dei 27, sulla quale nessuno scommette un centesimo. Restano altri strumenti a maggioranza, ma è chiaro che l’assenza di unità politica su una materia così importante sarebbe un pessimo segnale per l’Unione.
In conclusione, come ha lasciato intendere anche un alto funzionario di Bruxelles che ha voluto restare anonimo, sul price cap non c’è un accordo tra i Paesi e oggi quindi non uscirà una posizione comune, neppure a maggioranza. Secondo fonti diplomatiche, anzi, la proposta non dovrebbe essere neppure discussa oggi dai ministri. Sarebbe tutto rinviato al vertice informale tra capi di Stato e di governo del 6-7 ottobre a Praga, seguito da quello del 20-21 ottobre a Bruxelles. Von der Leyen vorrebbe presentare il pacchetto di proposte legislative nel collegio dei commissari di martedì 13, prima del discorso sullo stato dell’Unione. Esso sarebbe meno pesante rispetto alle intenzioni e conterrà solo i tre argomenti su cui c’è l’accordo.
La piega politica punitiva che la Commissione intende dare alla questione del tetto al prezzo inficia gli sforzi più realistici per trovare una soluzione vera alla drammatica crisi energetica. Curiosa è la vicenda della proposta italiana, partita sei mesi fa da Mario Draghi come tetto sul gas russo, e arrivata con Roberto Cingolani come tetto al prezzo del gas europeo, con un meccanismo di rimborsi per le differenze coi prezzi reali. Volendo ricavarne qualcosa di utile, c’è da augurarsi, almeno, che la vicenda grottesca di questo sconfortante affaccendamento europeo su una questione totalmente superflua serva alla politica italiana per smettere di aspettarsi soluzioni da Bruxelles.