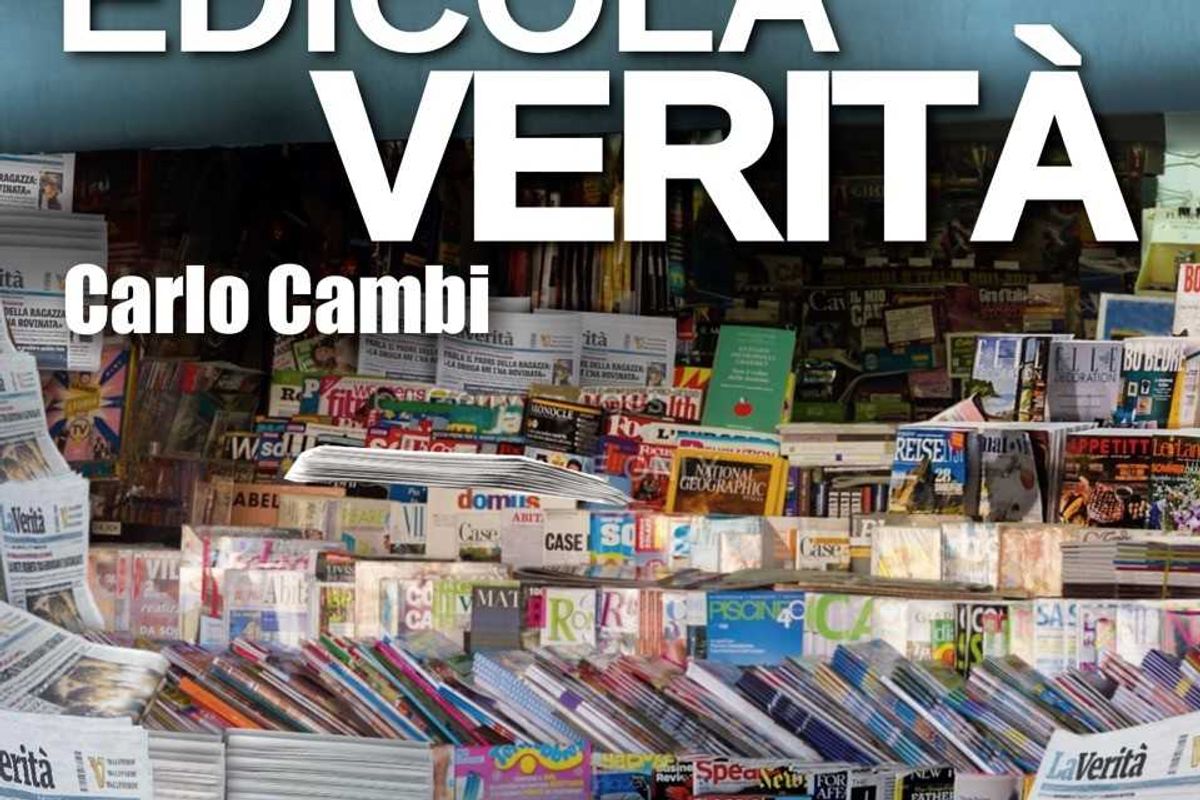Ormai anche gli europeisti più convinti ammettono che «questa» Unione, che poi è l'unica, è fatta di regole sbagliate applicate peggio. E l'Italia, per varie ragioni, esce penalizzata in economia, nella geopolitica, nella gestione dei fenomeni migratori, nelle norme per intervenire sulle banche. E pure il famoso Qe della Bce diventa un paradossale affare per Francoforte.
Germania padrona. Per lei le regole non valgono
In un'intervista al quotidiano Handelsblatt, Jean-Claude Juncker (proprio lui) ha affermato: «I tedeschi hanno violato il patto di stabilità 18 volte, le ho contate». Un esempio di questo doppiopesismo riguarda le banche. Perché si sono costrette quelle italiane a una svendita degli Npl (Non performing loans)? È stato stimato che, tra il 2017 e il 2018, la differenza tra quel che le banche hanno recuperato sui crediti deteriorati non ceduti (44%) e il prezzo di vendita di quelli che invece hanno ceduto (26%) sia stata del 18%. Applicando quel 18% alla massa di 164 miliardi, si arriva a una perdita di circa 30 miliardi.
Mentre sugli Npl (in pancia alle banche italiane) c'è stato uno sfrenato attivismo regolatorio della Vigilanza Bce (quando era guidata dalla francese Danièle Nouy), c'è invece stata disattenzione rispetto ai titoli «tossici» Level 2 e Level 3, che sono in quantità molto superiore (si stima 12 volte), e sono detenuti da banche tedesche e francesi. Questi titoli non hanno un mercato di riferimento e non si può dar loro un prezzo certo quando vengono iscritti a bilancio. Perché l'unico indice di pericolo per una banca sarebbero gli Npl? Si mira a un'unione bancaria con forte garanzia per le banche franco-tedesche e minor condivisione del rischio per le nostre? Solo un'omogeneità di trattamento può evitare che spread e tensioni inneschino una riduzione al minimo del valore delle azioni delle banche italiane.
Parametri intermittenti. Si applicano solo contro qualcuno
Per capire come le regole europee siano interpretate flessibilmente per gli «amici» e - invece - applicate ferocemente verso i «meno amici», basta considerare i Paesi dei due commissari economici più scatenati contro l'Italia, il lettone Valdis Dombrovskis e il francese Pierre Moscovici.
Quanto a Dombrovskis, la Lettonia riceve ogni anno dall'Ue 500 milioni, pari al 2% del Pil lettone. Per capirci, se l'Italia ricevesse altrettanto, avremmo ogni anno da Bruxelles 32-33 miliardi. Fantascienza pura.
Veniamo all'ineffabile Moscovici. Prima di diventare Commissario Ue nel 2014, Moscovici era stato ministro delle Finanze in Francia, sotto la presidenza Hollande. In quella veste, a metà 2012, si era impegnato davanti all'allora commissario economico Ue Olli Rehn a tornare sotto la soglia del 3% già nel 2013. Cosa che invece non accadde per dieci anni consecutivi, dal 2007 fino a tutto il 2016, inclusi i due anni di governo di Moscovici. L'Ue, però, fu ultraclemente con Parigi, a cui vennero dati altri 24 mesi per mettersi in regola: ma la Francia continuò a sforare, arrivando ben sopra il 4% nel 2014 e poco sotto il 4% nel 2015. E ovviamente anche quest'anno Emmanuel Macron ha sforato alla grande, senza che nessuno abbia sollevato obiezioni a Bruxelles. Peraltro, il debito pubblico francese non è affatto sotto controllo, essendo al 96-97% del Pil. Con queste «credenziali», Moscovici se la prende con l'Italia, Paese contribuente netto, visto che diamo ogni anno all'Ue molto più di quanto riceviamo (14 miliardi contro 11).
Favori alle banche. Così si massacrano interi Paesi
Inutile girarci intorno: c'è chi punta al completamento dell'unione bancaria come veicolo per mettere a carico dei contribuenti dei Paesi più deboli (cioè quelli mediterranei o comunque periferici) i salvataggi e la messa in sicurezza delle banche francesi e tedesche.
Un esempio lampante e inconfutabile si è verificato - anche per esplicita ammissione di economisti tedeschi - con il fondo salva Stati e gli interventi in Grecia degli anni passati: la stima è che, su 100 euro teoricamente destinati alla Grecia, solo 5 siano andati al governo di Atene, e ben 95 siano di fatto finiti alle banche creditrici (essenzialmente tedesche).
Questo ovviamente non cancella gli errori e le colpe dei governi greci, o la loro mala gestione: ma è paradossale aver parlato di maxi aiuti internazionali, che però da un lato prevedevano misure molto severe verso la Grecia dal punto di vista sociale e fiscale, e dall'altro garantivano essenzialmente le banche creditrici.
Come corollario tragicomico, vanno ricordate le recenti lacrime di coccodrillo del solito Jean-Claude Juncker, in occasione delle celebrazioni dei 20 anni dell'euro. In quell'occasione, il lussemburghese ha dichiarato: «C'è stata dell'austerità avventata. Mi rammarico di aver dato troppa importanza all'influenza del Fondo monetario internazionale. Non siamo stati sufficientemente solidali con la Grecia e con i greci» nel periodo più acuto della crisi. Insomma, prima ti massacro, e poi ti chiedo come stai.
Parigi privilegiata. I favori agli agricoltori francesi
La Politica agricola comune (nota con l'acronimo Pac) nacque (come sempre accade) con buone intenzioni: tutelare in tutta Europa gli agricoltori e il loro reddito, proteggere le produzioni, evitare squilibri. La realtà è che oggi la Pac è una voce abnorme per dimensioni nel bilancio Ue, con un'evidente distorsione a favore della Francia. La proposta della Commissione Ue per il bilancio del prossimo settennato 2021-2027 è quella di un taglio, di per sé oggetto di contestazioni, a partire dal governo italiano. Ma lo squilibrio pro Parigi resterebbe. Ecco alcune cifre.
La Commissione ha proposto una dotazione finanziaria di 365 miliardi di euro per la Pac nel periodo 2021-2027, corrispondenti più o meno al 28% del bilancio complessivo Ue. Nel settennato in corso 2014-2020, la Pac rappresenta invece circa il 37% del bilancio Ue, con una dotazione finanziaria leggermente superiore a 408 miliardi di euro.
L'Italia, secondo il nuovo schema, avrebbe una dotazione di circa 36 miliardi di euro. Si tratta di una riduzione rispetto agli oltre 41 miliardi del settennato che si sta per concludere. Diventeremmo quindi solo il quarto Paese beneficiario, staccatissimi dalla «medaglia d'oro» della Francia (62 miliardi), ma dietro anche all'«argento» della Spagna (43 miliardi) e al «bronzo» della Germania (poco meno di 41 miliardi). Insomma, si riducono un po' i numeri, ma rimane la posizione di privilegio riservata all'agricoltura transalpina (e non solo a quella).
L'Italia sempre bastonata. Immigrati e strane manovre
Tre esempi di uno stesso metodo. Primo, l'ultima manovra economica italiana (fine 2018), a cui il negoziato con Bruxelles ha imposto un netto peggioramento, con un taglio di 4 miliardi di investimenti, e un aumento a dismisura delle clausole di salvaguardia (che invece non sono state imposte alla Francia). La prima stesura della manovra prevedeva 13,7 miliardi di clausole nel 2020 e 15,6 nel 2021. L'ultima stesura, dopo l'accordo con Bruxelles, ha invece previsto 23,1 miliardi nel 2020 e 28,8 nel 2021. Come si vede, un aumento di ulteriori 9,4 miliardi nel 2020 e di altri 13,2 nel 2021. Uno sproposito.
Secondo, l'abitudine dei Commissari Ue di sparare dichiarazioni contro l'Italia a Borse aperte, per terremotare i mercati e creare destabilizzazione. In America, simili dichiarazioni, fatte da chiunque a mercati aperti, determinerebbero inevitabilmente inchieste della Sec o di qualche tribunale federale per svariati reati, dalla manipolazione del mercato all'aggiotaggio. Ma in Italia la magistratura non ha ritenuto di intervenire.
Terzo, l'immigrazione: l'Ue ci ha lasciato soli, tirando fuori somme irrisorie. Mentre l'Italia, ancora l'anno scorso, ha stanziato per l'accoglienza una somma enorme (4,6 miliardi), praticamente il gettito della vecchia tassa sulla prima casa. Ma ora Bruxelles recalcitra perfino a immaginare i fondi Ue per i rimpatri, condizione essenziale per stringere accordi con i Paesi africani, che vogliono denaro in cambio del massiccio rimpatrio dei loro connazionali.
Diplomazia zero. La politica estera non esiste
Il fallimento di Federica Mogherini, responsabile della politica estera Ue, è sotto gli occhi di tutti. Tanto quanto il suo doppiopesismo: sempre ostile agli Usa di Donald Trump e al governo israeliano di Benjamin Netanyahu, sempre pronta a inchinarsi (e a velarsi) di fronte agli ayatollah iraniani. Ma anche prescindendo dalla Mogherini (la sua nomina fu un altro «capolavoro» di Matteo Renzi), siamo proprio sicuri che sia una buona cosa spingere per una politica estera e di difesa comune Ue? Forse no, per due ragioni. Primo. Ci viene detto dagli «eurolirici»: esistono esigenze comuni europee. Ma questo è vero solo in parte, e diventa falso appena si scende sul terreno concreto. Si pensi alla Libia: chi può seriamente affermare che gli interessi francesi e quelli italiani siano convergenti? Semmai, confliggono, in termini di primazia nello sfruttamento delle risorse energetiche e di orientamento dei flussi migratori. Un'eventuale azione di politica estera (e di difesa) comune a quale priorità di interessi nazionali risponderebbe?
Secondo. Come si può concepire una difesa comune, se prima non si conosce la linea di politica internazionale al cui servizio lo strumento militare dovrebbe essere posto? In mancanza di questo, è evidente che l'eventuale esercito Ue sarebbe uno strumento nelle mani dei Paesi più forti: Germania e in subordine Francia, quest'ultima dotata anche del potere nucleare, e senza nemmeno il contrappeso britannico, vista la Brexit.