Le radici antiche dell’ambientalismo e le sfide di un futuro già alle porte
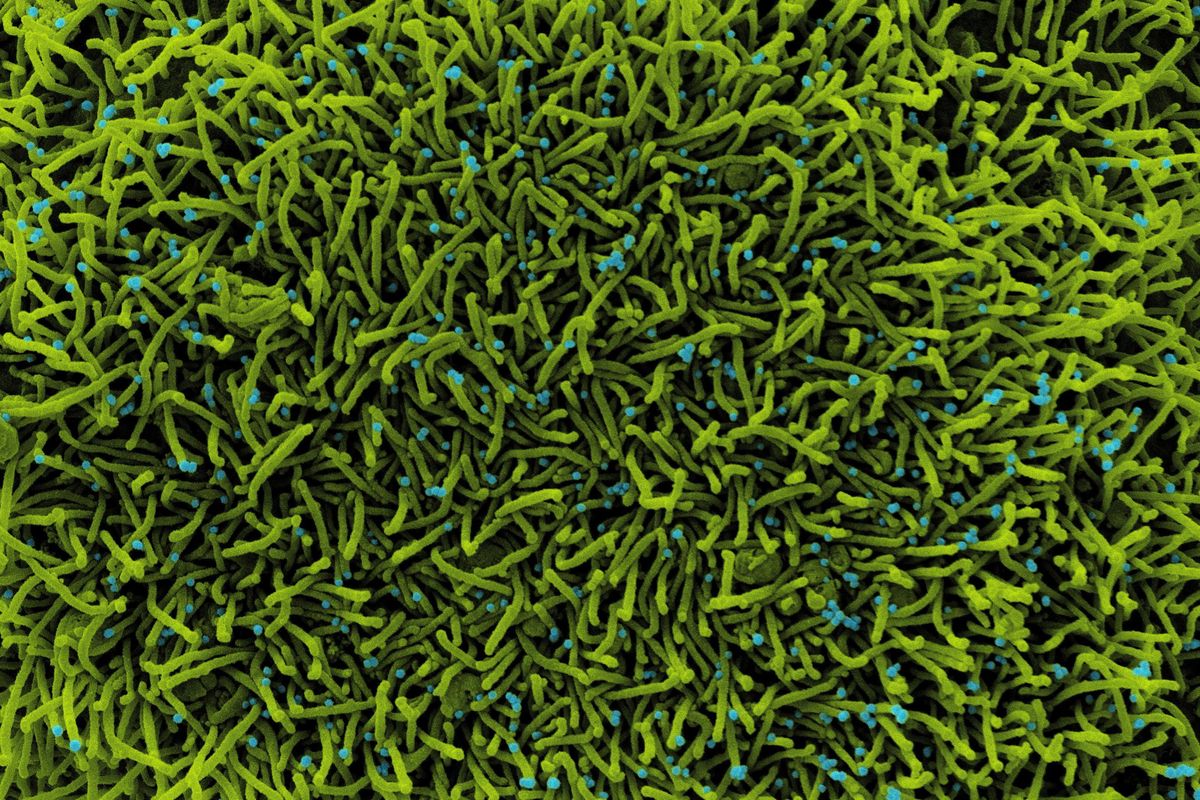
Nel 1977 l'editore Musumeci pubblicava Parchi nazionali e zone protette d'Italia, ne era autore l'allora quarantatreenne Fulco Pratesi, ambientalista già molto noto, fondatore e vice presidente del Wwf Italia, autore di saggi, pamphlet, e già coautore con Franco Tassi e Gianni Farneti della Guida alla natura d'Italia (Mondadori, 1974), nonché collaboratore L'Espresso e del Corriere della Sera. Ho la fortuna di conservare, non benissimo, entrambi i volumi, sono miniere di informazioni. Nonostante il nostro sia un mondo costantemente proiettato in avanti, e consunto dalla diatriba che si accende attorno alle notizie del giorno, riguardare un poco indietro e capire cosa di pensasse e facesse, o che cosa ci si aspettasse dal futuro che per noi è già diventato passato o sta per compiersi, è prezioso. Questa attenzione, questa curiosità probabilmente manca alle nuove leve dell'ambientalismo che si considerano l'anno zero di ogni cosa, attribuendo al passato un severo giudizio fallimentare. Ma così non è. Anzi, proprio navigando libri datati come questi ci si può rendere conto di quanto sia cambiato. Una volta incontrai in Toscana Fulco Pratesi, mi disse una frase che mi rimase in testa e alla quale ogni tanto torno: «Voi credete che sia stato tutto facile, ma le lotte noi le abbiamo combattute e non è mai stato facile». In effetti si crede sempre che quel che è stato fatto da altri sia stato in qualche modo facilitato, ma soltanto chi l'ha vissuto ne può adeguatamente parlare. Quando mi sono trovato a confrontarmi con alcuni giovani esponenti dei nuovi movimenti ambientalisti la posizione di partenza è più o meno sempre la stessa: le generazioni prima della nostra hanno portato il mondo sull'orlo della distruzione. Non avete fatto nulla. Siete responsabili e ci state togliendo il mondo. Ora, proprio pochi giorni fa rimuginavo sulla «grande paura» che aggrediva il mondo negli anni Settanta e nei primi anni Ottanta. Al tempo avevamo tutti paura che il mondo potesse essere devastato da una guerra termo-nucleare, sarebbero bastati due pulsanti schiacciati e saremmo andati al creatore per via direttissima. Noi, le nostre famiglie, i nostri amici, intere nazioni. Nelle scuole si mostravano film che parlavano delle centrali nucleari, come Silkwood, del pericolo atomico, come War Games o il terrorizzante The Day After nel quale si gettava un occhio nel mondo post-apocalittico. I ragazzi di oggi non lo possono sapere ma noi eravamo davvero spaventati, era questa la nostra più grande paura, in Italia, in Francia, in Nord America. Poi c'è stato la diffusione dell'Aids, poi c'è stato Cernobyl, la Perestrojka di Gorbaciov e la caduta del muro (Berlino), la guerra fratricida nell'ex Jugoslavia, l'11 Settembre 2001 e la caduta delle Torri Gemelle, il terrorismo internazionale e così via. Quant'acqua è passata sotto i ponti! Eppure si tratta di una manciata di decenni, nulla di che nel vasto respiro della storia umana, e meno di una goccia nel mare della storia naturale del pianeta.
Andiamo a sbirciare in quel che Pratesi scriveva nell'introduzione del libro del '77, quarantaquattro anni fa: «Fin dalle epoche più antiche l'esigenza di sottrarre porzioni del territorio alle distruttive attività umane era sentita: già nel 300 avanti Cristo nel codice Artha Shastra dell'imperatore indiano Kautilya, si parlava della protezione da accordare a certe foreste “con animali selvatici e aperte a tutti". In queste foreste vi era uno stretto controllo e certi mammiferi, uccelli e pesci erano totalmente protetti. Se qualche animale diventava nocivo e poteva “essere catturato o ucciso al di fuori della riserva, in maniera da non disturbare il resto. L'abbattimento degli alberi, la produzione di carbone vegetale, la raccolta di erbe, combustibile e foglie, il taglio delle canne di bambù, la cattura degli animali per la loro pelle, denti o ossa erano assolutamente vietati". In qualche modo, queste foreste, chiamate Abhayaranaya, possono essere considerate i precursori dei moderni parchi naturali». Pratesi ricorda l'istituzione del Parco di Yosemite nel 1872, i primi italiani - Gran Paradiso nel 1922, Abruzzo nel 1923, Circeo nel 1934 e Stelvio nel 1935. Cari ragazzi e cari scettici, ma quante cose sono poi mutate in pochi anni? I successivi tre decenni sono stati un fioriere senza precedenti di aree naturalistiche di ogni tipo e in ogni ambiente. Il libro di Pratesi è quasi un libro di archeologia ecologica. Sempre dall'introduzione: «Se in tutte (le riserve) saranno vietate la caccia, la distruzione della flora e della fauna, l'apertura di cave e miniere, nondimeno vi sarà una gradualità dei divieti tra zona e zona; nella zona A o di Riserva Integrale […] sarà vietato tutto, finanche l'accesso alle persone, tranne agli studiosi, alle guardie e ai visitatori autorizzati ed accompagnati. […] zona B o di Riserva Generale, l'accesso sarà consentito a tutti lungo sentieri tracciati, la pastorizia, l'agricoltura e l'utilizzo dei boschi ammessi con determinati limiti […] Nella zona C, o di Riserva Parziale, potranno insediarsi quelle strutture utili alla fruizione del parco (alberghi, rifugi, campeggi e parcheggi) mentre in quella D o di controllo urbanistico saranno ammesse anche le costruzioni private.» Buona parte di questi auspici si sono realizzati, eppure la massificazione del turismo domenicale e vacanziero ha fatto emergere quanto siano ampie le zone di fragilità. Oramai gli animali si sentono costantemente sotto assedio, anche nei propri territori, e cresce quella curiosa nuova specie di animali selvatici che si abituano all'umanità. Inoltre, la scorsa estate, la paralisi dei viaggi extranazionali ha proiettato il turista giornaliero nelle località di montagna, con esiti non sempre positivi. Certo, ristoranti pieni, chi lavora a contatto col turista ne ha beneficiato, ma le conseguenze sono state severe, come una difficoltà nella gestione del traffico, guadagni minori poiché il turista mordi e fuggi spende meno e meno bene le poche risorse che mette a disposizione. La natura che noi pensiamo è una soltanto ma quanto rapidamente può cambiare.






