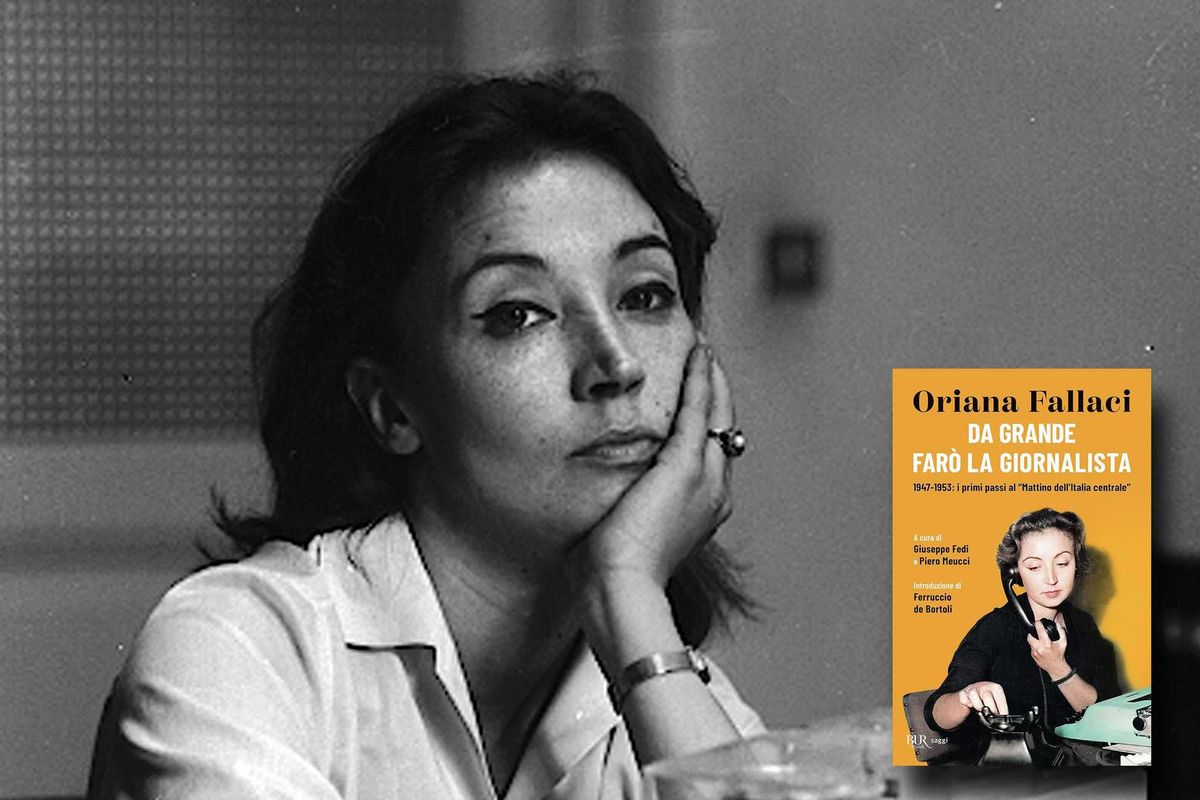Sbagliare è umano, perseverare è… Agcom. L'Agcom è l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, organo che secondo alcuni a volte sonnecchia davanti alla faziosità dell'informazione radiotelevisiva su cui sarebbe invece chiamata a vigilare. Eppure da qualche tempo - improvvisamente - appare desta, sveglissima, perfino scatenata: contro Internet, però, e con una linea che, più o meno consapevolmente, oscilla pericolosamente lungo il confine della censura.
Il presupposto non detto, forse inconfessabile, è quello proprio di un certo establishment politico e mediatico, non solo italiano. Queste élite smarrite ragionano più o meno così: ma come? Controlliamo il grosso della carta stampata, la gran parte delle radio e delle tv, eppure gli elettori continuano a sfuggirci, e noi proseguiamo a perdere, da Brexit a Donald Trump, da Jair Bolsonaro ai trionfi dei populisti europei… Di chi è la colpa? Dev'essere di Internet e dei social network, dove sempre più persone vanno a cercarsi informazione alternativa.
E allora ecco tante campagne per descrivere gli elettori come analfabeti funzionali, come razzisti e xenofobi di andata o di ritorno; ecco un'ondata di documenti e paper, in tutto l'Occidente, contro fake news e post truth online; ed ecco qua e là risorgenti tentazioni censorie. Siccome però la censura vera e propria nel 2019 è difficilmente praticabile, si ripiega sul tentativo di «dare pagelle», di affibbiare etichette di inaffidabilità, di squalificare chi appaia sgradito.
Torniamo all'Agcom, dunque. Già qualche mese fa, e La Verità se ne occupò ampiamente, un «tavolo tecnico» Agcom produsse un documento che distingueva «disinformazione online» (il caso più grave: notizie false diffuse dolosamente), «misinformazione online» (il caso più lieve: notizie non veritiere, ma diffuse senza intento doloso), e una stravagante via di mezzo, la cosiddetta «malainformazione online» (contenuti informativi fondati su fatti reali, ma - secondo i tecnici Agcom - divulgati e contestualizzati per danneggiare qualcuno o - tenetevi forte - per «affermare o screditare una tesi»). Capite bene che si tratta di un terreno minato: se perfino un contenuto informativo fondato su fatti reali non va bene a lorsignori, ai nuovi guardiani della Rete che si arrogano la pretesa di indagare sulle intenzioni di chi lo scrive o lo pubblica, si può tranquillamente prendere l'articolo 21 della Costituzione e cestinarlo («Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione»).
Ma l'Agcom non si è fermata. E questa settimana ha diffuso il primo numero del suo «Osservatorio sulla disinformazione online», con una sequenza di dati presentati come inquietanti. Riassumiamo la ricerca: «La disinformazione ha interessato l'8% dei contenuti informativi online prodotti mensilmente lo scorso anno e ha riguardato soprattutto argomenti di cronaca e politica (53% dei casi) e notizie di carattere scientifico (18% dei contenuti di disinformazione)». E ancora: «Nel 2018, il volume di disinformazione online ha raggiunto il livello massimo in corrispondenza delle elezioni del 4 marzo e della successiva formazione del governo». Secondo l'Agcom, «sia nel periodo elettorale che nei mesi successivi, le vicende politiche e di governo, la cronaca nera, le teorie pseudoscientifiche e la salute sono state tra le principali tematiche oggetto di disinformazione». E infine ecco i temi maggiormente oggetto di disinformazione: «Immigrazione e terrorismo hanno segnato la maggiore presenza di disinformazione sul totale dei contenuti online prodotti sui singoli argomenti, riportando quote rispettivamente pari al 15% e all'11%».
Ma a questo punto il lettore si chiederà: in base a quale criterio l'Agcom distingue buona e cattiva informazione? Lo spiega la nota metodologica in fondo al rapporto, e c'è da fare un salto sulla sedia: Agcom informa che «è stato analizzato l'intero contenuto testuale estrapolato da circa 15 milioni di documenti generati in Italia, nel 2018, da 1.800 fonti informative (canali radio tv nazionali, quotidiani, agenzie di stampa, siti Web di editori tradizionali, testate esclusivamente online, e relative pagine e account di social network), e fonti di disinformazione (siti Web e pagine/account social) individuate come tali da soggetti esterni specializzati in attività di debunking. Il volume di disinformazione online prodotto in Italia è stato quindi stimato con una metodologia di tipo soggettivo, ossia considerando il numero complessivo di documenti generati mensilmente dalle predette fonti di disinformazione».
Avete letto bene: «metodologia di tipo soggettivo», cioè hanno preventivamente stabilito chi fossero i cattivi, affidandosi alla valutazione di «soggetti esterni specializzati in attività di debunking» (espressione con cui in Rete si definisce la caccia alle bufale, lo smascheramento delle falsità).
Il primo a sollevare il caso è stato il sempre attentissimo e puntuale Benedetto Ponti, docente di diritto amministrativo all'università di Perugia, che ha messo in fila obiezioni assolutamente ficcanti contro l'iniziativa di Agcom. Insomma, l'Agcom pretende di stabilire lei chi siano quelli bravi, e di «appaltare» a soggetti esterni la definizione dei «cattivi». Peggio: dà per scontato (non si sa in base a quale logica) che tutto ciò che è prodotto da fonti «buone» sia affidabile, e tutto ciò che invece viene dai «cattivi» sia per ciò stesso inaffidabile. Di tutta evidenza, il ragionamento non tiene.
Occhio: Agcom presenta esplicitamente la sua iniziativa come l'avvio di «una sperimentazione di un sistema di monitoraggio in concomitanza del periodo che precede le prossime elezioni europee». A buon intenditor, poche parole: per «proteggerci», da qui alle europee, e lungo tutta la campagna elettorale, pretenderanno di spiegarci cosa possiamo o non possiamo leggere, dove dobbiamo o non dobbiamo cliccare.