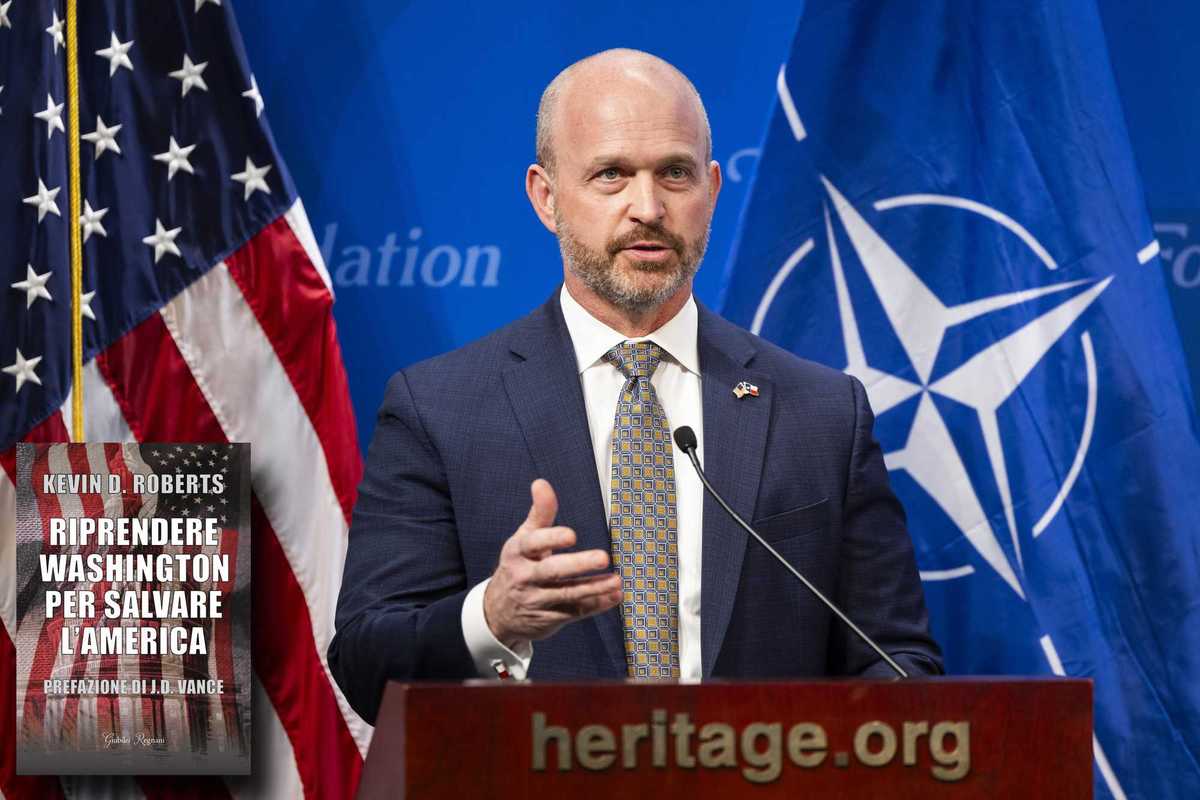La tragedia del Nagorno Karabakh. «Gli ambientalisti azeri bloccano viveri e medicinali»

Continua la crisi umanitaria in Nagorno Karabakh, la regione contesa tra Armenia e ’Azerbaigian. E peggiora ogni giorno che passa. Dal 12 dicembre i manifestanti azeri bloccano il corridoio di Lachin, una strada montuosa di 32 chilometri fondamentale per i collegamenti. Sono ambientalisti che, secondo il governo di Baku, chiedono le autorizzazioni per ispezionare le numerose miniere armene, considerate illegali, nella zona. Con il blocco del passaggio, però, i manifestanti stanno impedendo anche l’ingresso delle forniture di cibo e medicinali, causando una grave crisi umanitaria per gli oltre 120 mila residenti nella zona. A ricordarlo è stato 'ambasciatrice armena in Italia Tsovinar Hambardzumyan nel corso dell'audizione svolta martedì 24 presso la Commissione esteri della Camera dei deputati. Ormai la scarsità di beni di prima necessità, cibo e medicinali si fa sempre più evidente. Il pericolo della carestia è tangibile. 120.000 persone sono diventate di fatto prigioniere.
La situazione si è aggravata per il taglio del gas (in pieno inverno), della rete elettrica e della connessione a Internet operato dall’Azerbaigian. Asili nido e scuole sono chiuse, gli ospedali hanno sospeso le operazioni chirurgiche, non c’è più latte in polvere per i bimbi. «Gli Stati Uniti, l'Unione Europea, il Segretario generale delle Nazioni Unite e più di una dozzina di Paesi hanno già chiesto all'Azerbaigian di sbloccare la strada per il Nagorno Karabakh» ha ricordato l’ambasciatore. «Da ultimo il Parlamento europeo a larghissima maggioranza ha votato una risoluzione in tal senso. In risposta a queste sollecitazioni internazionali, il presidente azero non ha esitato a confermare che gli "attivisti" che hanno bloccato il collegamento lo hanno fatto su sua istruzione aggiungendo ironicamente che chi non vuole essere cittadino dell'Azerbaigian può tranquillamente andarsene e il blocco verrà aperto per loro». Solo la Croce Rossa è riuscita a entrare nel Nagorno-Karabakh per soccorrere una quarantina di cittadini che sono stati trasferiti negli ospedali di Erevan in gravi condizioni. Già a dicembre Human Rights Watch aveva avvertito che il blocco prolungato del corridoio di Lachin avrebbe potuto causare una crisi umanitaria disastrosa. Amnesty International ha chiesto che sia ripristinata la piena libertà di movimento. L’Onu ha lanciato un appello in cui chiede la riapertura del corridoio e così anche l’Istituto per la Prevenzione del Genocidio, che mette in guardia sul rischio di pulizia etnica nella regione.
Come ha ricordato Tsovinar Hambardzumyan, il conflitto del Nagorno Karabakh, da 30 anni costituisce la sfida principale per la sicurezza e per la stabilità della nostra regione e ora presenta una serie di minacce, di natura politica e militare per l'Armenia propria, per l’intera regione e di conseguenza per l’Europa e l’Italia stessa. Come noto, le radici di questo conflitto risalgono all'epoca sovietica. Il Nagorno Karabakh o Artsakh, storicamente armeno, fu incluso con la forza nella Repubblica dell’Azerbaigian come una regione autonoma, per decisione del dittatore sovietico Iosif Stalin nel 1921.
In questi 70 anni sovietici, l’unico lasso temporale in cui il Nagorno Karabakh ha fatto parte dell'Azerbaigian è stato segnato da massacri, deportazioni, discriminazioni e altre forme di intolleranza nei confronti degli armeni. «Basti solo pensare che nel 1920 nel Nagorno Karabakh abitavano circa 300 mila persone, oltre il 95% delle quali erano armeni; nel 1988 vi erano rimasti solo 140.000 armeni, e oggi ne sono rimasti solo 120.000». Nel 1988, nell’ultimo periodo dell’Unione Sovietica, gli armeni del Nagorno Karabakh iniziarono a protestare e a rivendicare i diritti che furono loro sempre negati. E «l'Azerbaigian» continua l’ambasciatrice «non gradendo quelle proteste pacifiche, rispose con massacri ai danni degli armeni che vivevano a Sumgait, e dopo a Baku e Kirovabad. Furono proprio i massacri di Sumgait ad avere un ruolo decisivo nello scoppio del conflitto del Nagorno Karabakh. Nel febbraio del 1988 bande armate degli azeri, in pieno giorno, sotto gli occhi delle autorità, inneggiando odio anti-armeno, fecero irruzione nelle case scatenando una "caccia all'uomo" per giorni. Un contesto che tristemente evocava il nostro passato segnato dal genocidio. Le atrocità commesse dagli azeri causarono decine di vittime innocenti, centinaia di feriti e disabili. Questi avvenimenti fecero crescere la tensione tra le due popolazioni e cambiarono la natura del conflitto».
Dopo la guerra dei 44 giorni nel 2020, quando furono usate armi di nuova generazione con il coinvolgimento della Turchia, era stata trovata un’intesa su una possibile pace. Ma l'Azerbaigian non ha rispettato gli accordi. «Le azioni dell'Azerbaigian sono diventate ancora più incontrollate a patire da febbraio 2022, quando tutta l'attenzione internazionale si è concentrata esclusivamente sulla guerra in Ucraina: così, sono passati quasi inosservati l’ennesima aggressione sul territorio sovrano della Repubblica di Armenia il 13 settembre e il blocco del corridoio di Lachin».