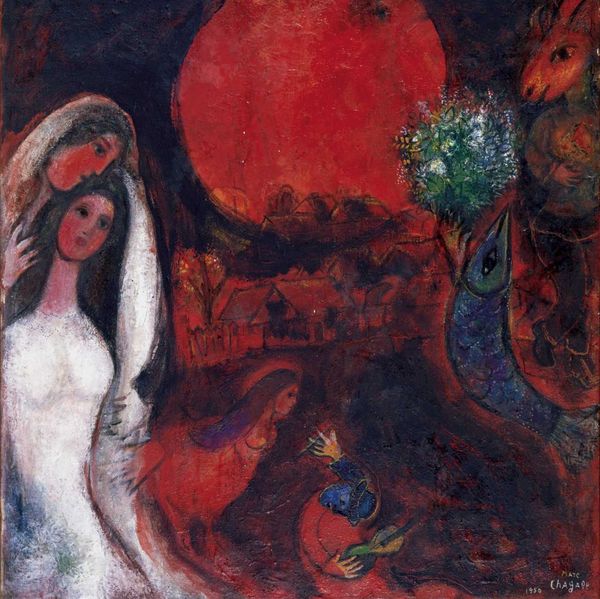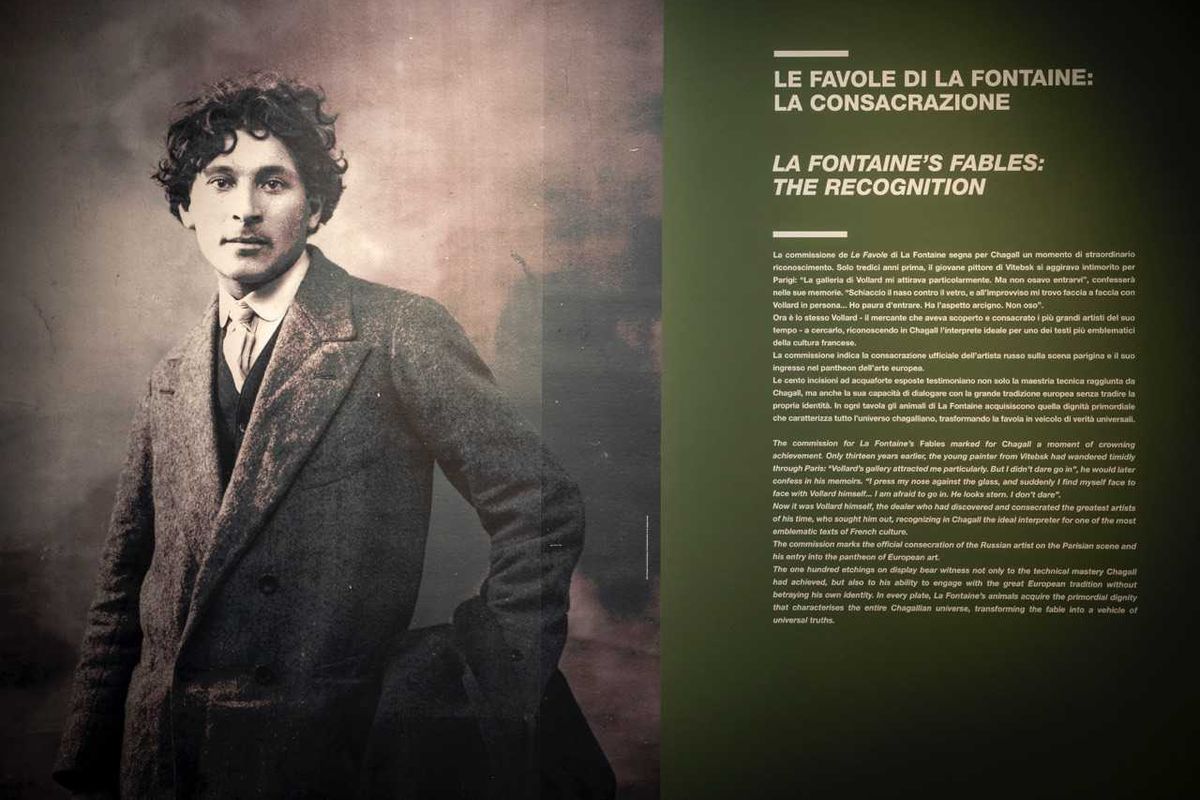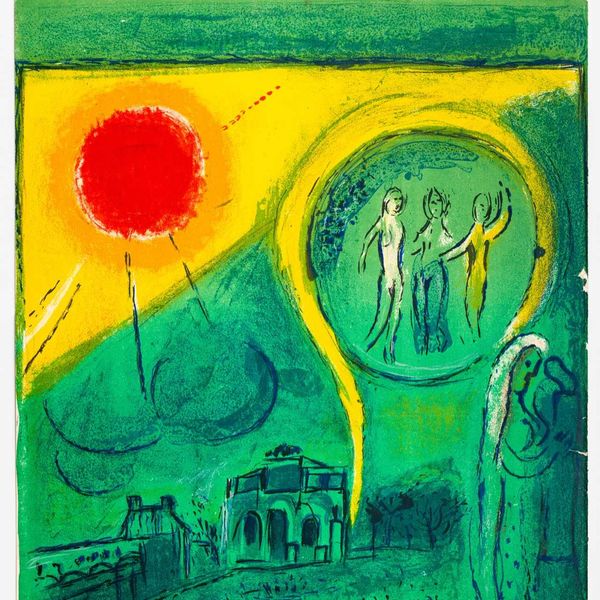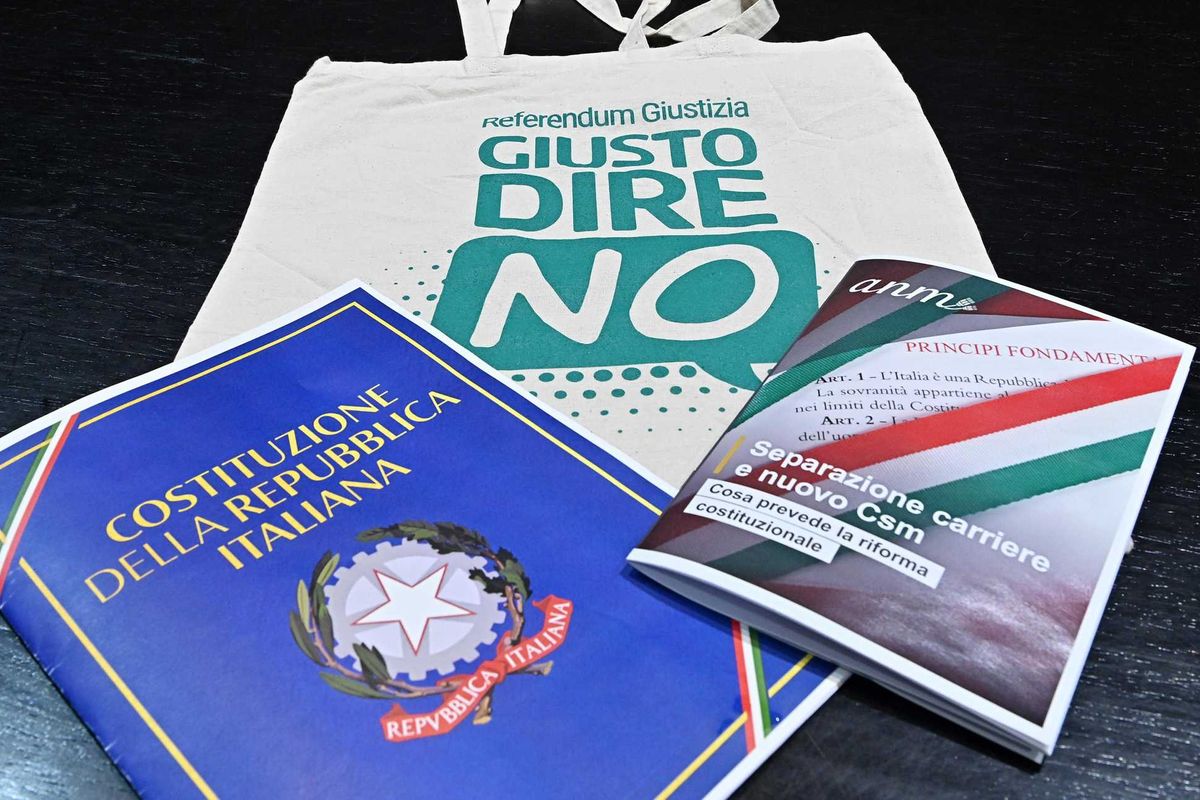Nella amplissima produzione pubblicistica e storiografica sulla Resistenza italiana per moltissimo tempo sono stati privilegiati i movimenti di sinistra, comunisti, socialisti e azionisti, come se l'apporto di altri gruppi fosse stato poco significativo o del tutto trascurabile. Questo tipo di narrazione della Resistenza l'ha esposta al rischio di venire travolta dal crollo del comunismo alla fine del XX secolo, facendo perdere valore a un periodo della storia d'Italia che ha avuto invece una importanza, soprattutto etica, di grande rilievo per un Paese che cercava di riscattarsi dal ventennio della dittatura fascista e che usciva da una guerra devastante.
Il pericolo era già stato segnalato da Ermanno Gorrieri, uno dei cattolici protagonisti della Resistenza in Emilia, quando auspicava il nascere di una storiografia che si proponesse «il duplice obiettivo di demistificare e di demitizzare» la storia della Resistenza. Demistificare, evitando «le strumentalizzazioni e gli esclusivismi», e demitizzare, depurando la Resistenza «dalle esaltazioni oleografiche, riscattarla nel suo significato più vero e più umano, non esente da ombre e da contrasti, per riproporne i valori civili e morali, che emergono intatti da un processo di rinnovamento critico». Inoltre, poiché la maggior parte degli studi ha per lungo tempo considerato la Resistenza solo o prevalentemente nel suo aspetto militare, e stato spesso sottovalutato l'apporto di chi, pur non prendendo le armi, ha svolto un ruolo non indifferente di supporto, proteggendo i combattenti, cercando di mettere in salvo i perseguitati per motivi politici o razziali, esercitando l'indispensabile funzione di raccordo tra i gruppi, di trasmissione di ordini o di preparazione di documenti falsi. E non si trattava certo di azioni di poco conto, la cui scoperta da parte dei nazifascisti poteva portare ad arresti, violenze, torture e, infine, alla condanna a morte.
rimozioni e agiografie
La Resistenza fu un fenomeno molto complesso, difficile da inquadrare in schemi precostituiti e spesso piegati a esigenze di politica contingente. Il modo tradizionale di raccontarne le vicende, non solo nella pubblicistica, ma anche nella storiografia, ha finito per mettere in secondo piano l'apporto della Chiesa e dei cattolici (ma anche, naturalmente, dei gruppi autonomi o apolitici), se non addirittura di trascurarlo del tutto, provocando talvolta una risposta cattolica agiografica e di ben scarso valore.
[…] Per analizzare il contributo del mondo cattolico alla Resistenza, occorre distinguere innanzitutto tra clero e laicato. All'interno del primo gruppo, inoltre, si tratta di analizzare le diverse posizioni assunte dal vertice della Chiesa, dai vescovi, dai parroci, dai religiosi e dalle religiose, queste ultime fino a tempi recentissimi ingiustamente trascurate dalla storiografia. L'ampia e accurata ricerca promossa in occasione del cinquantenario della fine della Seconda guerra mondiale dall'Istituto Luigi Sturzo di Roma su cattolici, Chiesa e Resistenza ha messo in luce il ruolo importante ricoperto dall'episcopato, dal clero, dai religiosi e dal laicato cattolico nel drammatico periodo tra il 1943 e il 1945, ma ha rilevato anche notevoli diversità di comportamento e non poche contraddizioni e lacerazioni.
Il papa e la Santa Sede agirono con estrema, caratteristica prudenza. Non vi fu un appoggio esplicito alla Resistenza, ma non ci fu neppure il riconoscimento diplomatico della Repubblica sociale italiana, malgrado le forti pressioni ricevute. […]
La posizione della Santa Sede fu fatta propria anche dall'episcopato lombardo, che, nel corso di una riunione collettiva il 21 ottobre 1943 ribadì che «un atto di riconoscimento del regime, al momento presente, non si deve fare». La Santa Sede, dunque, non solo non riconobbe la Rsi, ma evitò atteggiamenti che potessero apparire anche solo come una implicita accettazione del regime di Salò. Così non furono nominati i successori dei vescovi di Novara e di Vittorio Veneto per evitare di chiedere l'assenso del governo repubblichino e il successivo giuramento. […] La Santa Sede suggerì poi a padre Agostino Gemelli di trovare formule particolari per conferire le lauree dell'Università Cattolica per non richiamare neppure implicitamente i pubblici poteri repubblichini.
il ruolo di pio xii
Per diretto impulso del pontefice Pio XII, la Santa Sede eliminò le difficoltà di natura giuridica che avrebbero potuto impedire il soccorso ai ricercati per motivi politici o razziali. L'apertura dei conventi, delle case religiose, delle parrocchie, dei palazzi extraterritoriali di Roma permise il salvataggio di numerosi perseguitati, senza distinzione di fede o di appartenenza politica.
Così antifascisti di ogni ideologia trovarono rifugio in chiese e conventi. Pietro Nenni e Ivanoe Bonomi, e con loro molti altri, furono ospitati in San Giovanni in Laterano fino alla liberazione di Roma.
[…] Non si può quindi negare che le autorità della Rsi percepivano come sostanzialmente ostile nei loro confronti la posizione della maggioranza degli ordinari italiani. Le prudenze, le incertezze e le esitazioni dei vescovi italiani nei confronti del regime di Salò si riscontrano anche nel loro rapporto coi sacerdoti diocesani decisi a impegnarsi nell'attività resistenziale. Il cardinale Schuster, tramite il nunzio a Berna, monsignor Bernardini, nell'ottobre 1944 chiese istruzioni alla Santa Sede sulla possibilità di garantire alle formazioni partigiane assistenza spirituale, sia per motivi religiosi, ma anche per evidenti preoccupazioni di tipo politico: «Le truppe dei partigiani sono totalmente destituite di assistenza religiosa, e tra loro ha buon gioco il comunismo. Si domanda: è opportuno e come, concedere cappellani? In tal caso, siccome questi passano da un punto all'altro per varie diocesi, avrei bisogno di facoltà apostoliche per autorizzarli ovunque».
La Santa Sede rispose positivamente, lasciando ai singoli vescovi il compito di come realizzare concretamente l'assistenza religiosa ai partigiani. Di conseguenza quasi nessun vescovo si oppose a che i sacerdoti prestassero assistenza spirituale nelle formazioni. […]
l'azione di schuster
Ben più ardua fu per i vescovi la scelta di approvare una partecipazione attiva del clero ad azioni militari o che potessero provocare rappresaglie contro i civili. L'arcivescovo di Milano, il cardinale Schuster, invito i propri sacerdoti a «mantenersi fuori e al di sopra di tutte le diverse competizioni d'indole politica" e a non “piegare la Religione e il Divin Culto all'alea delle contingenze umane". Questo era uno dei numerosissimi appelli ufficiali dei vescovi alla prudenza, che tuttavia lasciavano talvolta trasparire una maggiore simpatia per i partigiani piuttosto che per i repubblichini […] Del resto, anche le autorità tedesche consideravano i sacerdoti, ma anche qualche vescovo, complessivamente ostili, come disse l'ambasciatore Ernst von Weizsaker nel marzo 1944 a monsignor Giuseppe Di Meglio della Segreteria di Stato. «Neppure può dirsi che in vari luoghi, il clero e anche qualche vescovo siano immuni da responsabilità nell'ostilità che le popolazioni dimostrano contro le truppe tedesche, la quale spesso si traduce in atti a mano armata».
nuovi santi
Per il clero che restava più vicino alle popolazioni civili, l'azione di aiuto, assistenza e soccorso fu pero l'attività resistenziale più congeniale e conforme alla propria missione. Non era certamente una scelta che non comportasse pericoli. Molti ecclesiastici pagarono infatti con la vita, con la deportazione in Germania (in genere nel lager di Dachau) o col carcere questa opera di misericordia, spesso rischiosa quanto l'azione armata diretta contro i nazifascisti. Molti sacerdoti, ma anche alcuni vescovi (a Casale Monferrato, a Trani, a Faenza, a Pescia, a Terni) non esitarono poi a offrire la loro vita in cambio di quella di ostaggi che i fascisti o i tedeschi stavano per fucilare per rappresaglia. Sono numerosi gli episodi di questo genere; oscuri, spesso dimenticati, ma che permisero di salvare numerosi ostaggi. […] Si potrebbe dire, come già altri hanno notato, che la Resistenza ha permesso alla Chiesa di sperimentare un nuovo tipo di santità.