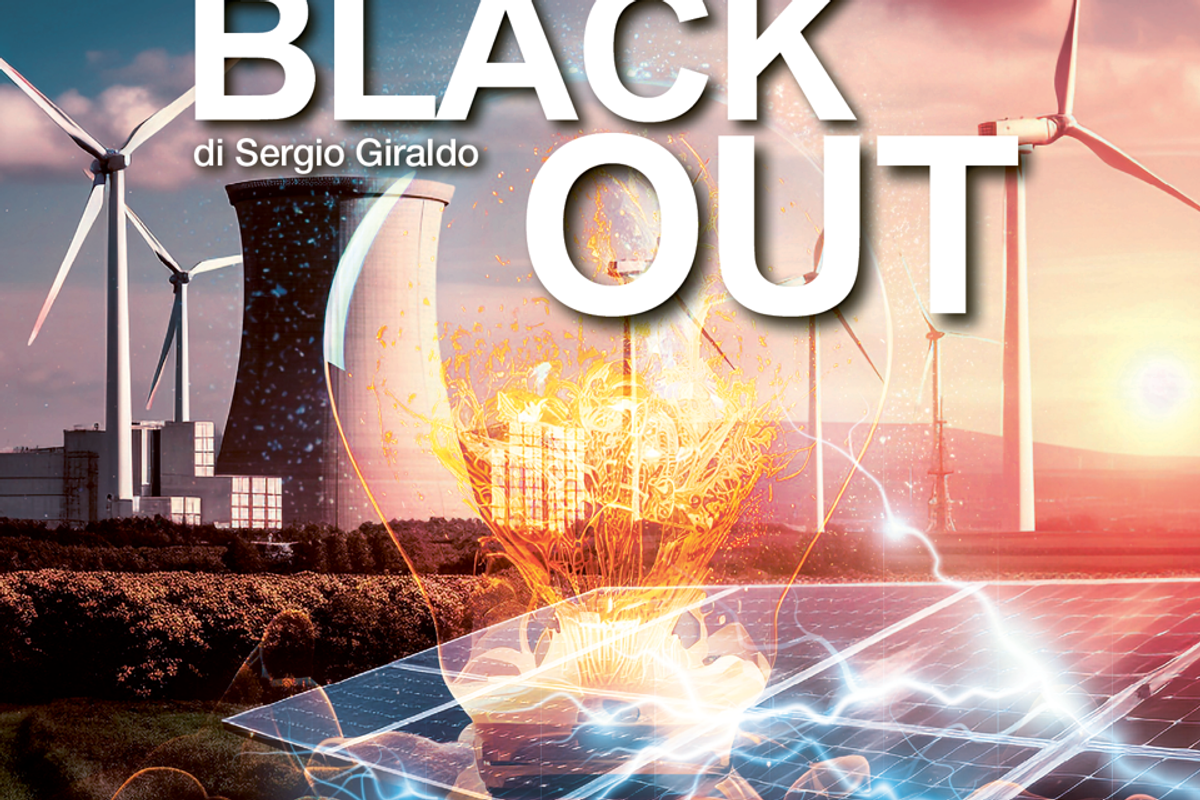Il Palazzo di Diocleziano è l’origine e il centro nevralgico di Spalato, seconda città della Croazia dopo la capitale Zagabria. Origine perché fu edificato, per volere del suo eponimo nato nelle vicinanze, in un luogo non ancora abitato; centro nevralgico perché, a differenza di tanti ruderi abbandonati e tante rovine conservate con una devozione degna di reliquie sacre, e altrettanto inconcludente, non gli è mai venuta meno la continuità funzionale e oggi, dopo 17 secoli di vicissitudini varie, è sede vivace di alberghi, ristoranti, eventi culturali e artistici. Nella camera che occupiamo, le pareti sono mura originarie, del quarto secolo.
Tanta attività è anche giustificata dalle dimensioni della struttura: nonostante il nome di palazzo, si tratta infatti di un borgo fortificato di forma approssimativamente quadrata, con lati di circa 200 metri e una superficie interna di circa quattro ettari, equivalente a quasi sei campi di calcio.
Quando fu costruito, nel corso di una decina d’anni, comprendeva ampi spazi per la servitù e le guardie, luoghi dove il suo padrone potesse dormire, mangiare, passeggiare e onorare gli dei, due piscine (una di acqua calda termale) e un mausoleo. Era decorato, fra l’altro, con colonne e sfingi trasportate dall’Egitto.
Chi era il suo padrone? O, per dirla alla Manzoni: Diocleziano, chi era costui? Dalla morte di Alessandro Severo, trucidato dai suoi soldati nel 235 insieme con la madre Giulia Mamea, l’Impero romano fu preda, per mezzo secolo, di un susseguirsi feroce di tumulti noto come anarchia militare, in cui si contesero il trono anche due o tre sovrani contemporaneamente e nessuno durò più di un paio d’anni.
Gli ultimi della serie furono Marco Aurelio Caro e i figli Numeriano e Carino. Morto Caro in guerra e liquidato Numeriano dalle guardie pretoriane che dovevano proteggerlo, fu eletto imperatore Diocle, che assunse il nome di Diocleziano e si pose il problema non solo di come sopravvivere lui stesso, a differenza di tanti predecessori, ma anche di come far sopravvivere l’immensa struttura di cui era diventato unico monarca, dopo aver sconfitto e ucciso anche Carino.
L’idea guida di Diocleziano era che l’impero fosse diventato troppo grande per essere governato da un uomo solo. Un’idea aristotelica, anche se lui probabilmente non lo sapeva: ragionando da biologo, Aristotele sosteneva che una città (e, per analogia, uno Stato) potesse vivere e prosperare solo entro un certo ambito di dimensioni. Diocleziano fece dunque, innanzitutto, un passo inedito: ridusse, cioè, il proprio potere e decise di condividerlo. Elaborò una complessa struttura detta tetrarchia in cui due Augusti, lui e il collega Massimiano, governassero rispettivamente l’Oriente e l’Occidente, e due Cesari loro luogotenenti, Galerio e Costanzo Cloro, li assistessero governando pure delle regioni. Dopo vent’anni gli Augusti si sarebbero dimessi e sarebbero succeduti i Cesari, che avrebbero nominato nuovi Cesari. A questa riforma politica si accompagnarono sue riforme amministrative, giuridiche, economiche e militari, intese a restituire Roma alla sua forza di un tempo; e si accompagnò anche, in modo naturale per un imperatore così legato alle tradizioni e alle glorie del passato, l’ultima grande persecuzione dei cristiani.
Nel mezzo di tanto lavoro di riforma e di guerre continue, con germani e sarmati, con persiani e britanni, nel 293 Diocleziano diede inizio ai lavori del suo palazzo, nel quale voleva ritirarsi. Nel 305 la reggia era pronta e lui, fedele alle regole, si ritirò, esigendo che lo facesse anche Massimiano. E a quel punto successe l’inferno.
Fu una guerra di tutti contro tutti, cui partecipò anche Massimiano immemore delle promesse fatte e in cui si misero in luce Costantino figlio di Costanzo Cloro e Massenzio figlio di Massimiano. Alla battaglia di Ponte Milvio del 312 il primo sconfisse e uccise il secondo; poi, sconfitto nel 324 anche l’ultimo rivale in Oriente, rimase solo dominatore dell’impero. Che da quel momento in avanti non avrebbe più arrestato la sua decadenza. Intanto, nel 308, a un convegno nell’odierna località austriaca di Petronell, molti avevano pregato Diocleziano di tornare in gioco per risolvere il pasticcio, ma lui, a quel che ci racconta lo storico Aurelio Vittore, avrebbe risposto: «Se voi poteste mostrare il cavolo che ho piantato con le mie stesse mani al vostro imperatore, egli non avrebbe mai osato di suggerire di rimpiazzare la pace e la felicità di questo posto con i temporali di un’avidità mai soddisfatta». Sarebbe così rimasto, nel mezzo millennio di durata dell’Impero romano, l’unico imperatore ad andarsene di sua spontanea volontà.
Questa storia mi suggerisce due considerazioni, di natura contrastante. Da un lato, alla mia veneranda età ho ricoperto numerosi ruoli istituzionali, con l’idea che l’istituzione dovesse prevalere sull’individuo e con l’intento, quindi, di lasciare il posto al mio successore in condizioni migliori di quelle in cui lo avevo trovato. In ciascun caso, e fatte le debite proporzioni, ho poi assistito, a distanza, a disastri del tipo di quelli osservati da Diocleziano.
Non ho cambiato idea sul piano del dover essere: il piano di quel che è nostro compito morale fare. Se avessi altre opportunità, mi comporterei esattamente allo stesso modo. Ma ne ho anche tratto una riflessione sconsolata di carattere fattuale, sul piano dell’essere, di ciò che (di solito) capita davvero. È questa: nel mondo fallace e imperfetto in cui viviamo, esuli dagli ideali che dovrebbero ispirarci, sono gli individui a contare, non le istituzioni. La tetrarchia di Diocleziano era, sulla carta, un sistema di perfetta razionalità; ma non durò lo spazio di un mattino quando a farla funzionare non fu più l’uomo straordinario che l’aveva creata.