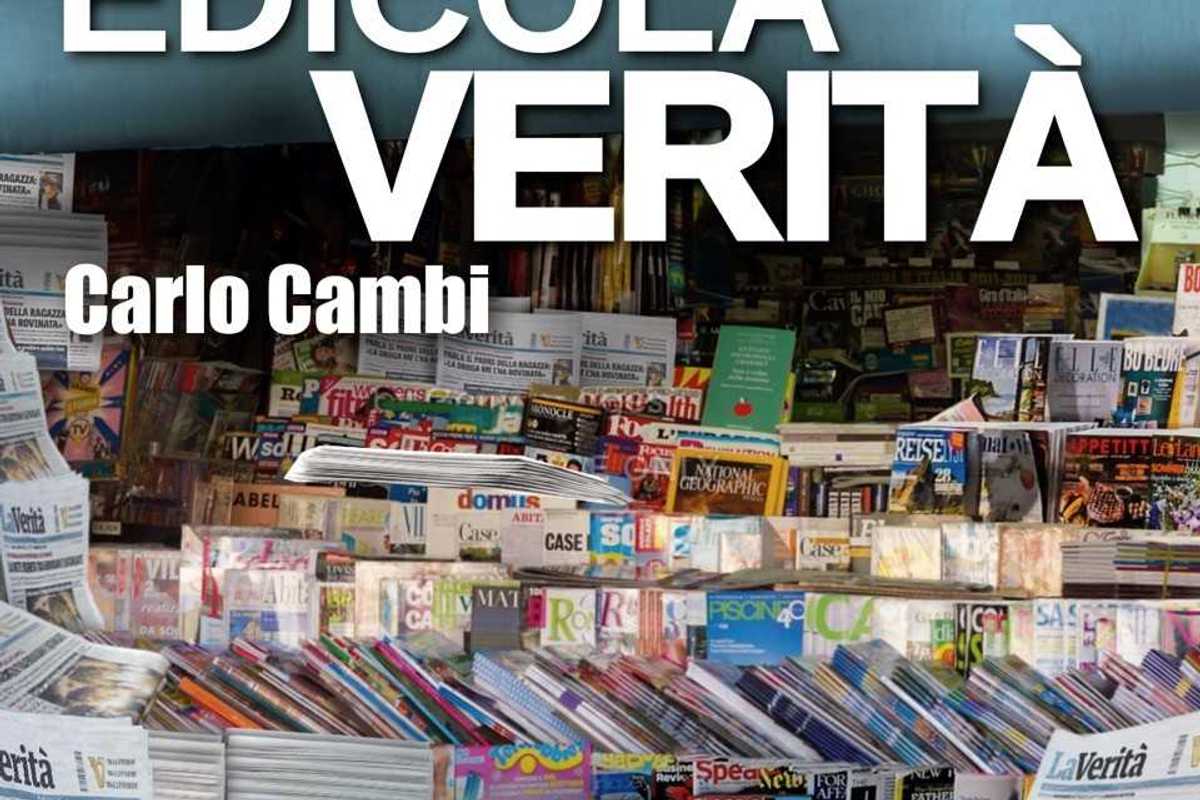«Io volli almeno acquistare la completa indipendenza delle mie azioni e del mio vivere, e potermi dire: “Io appartengo a me medesima, e solo io voglio essere giudice del mio operare"». Parole tanto assertive sembrerebbero uscite dalla penna di una femminista del Novecento, o di una libera e anticonformista intellettuale dei nostri giorni. Invece, sono state scritte dalla contessina Clara Maffei, la minuscola, riservata e graziosa animatrice di uno dei più celebri salotti del Risorgimento.
Elena Chiara - detta Chiarina, o Clara - nasce a Bergamo nel marzo 1814. Suo padre è il conte Giovanni Battista Carrara Spinelli, sua madre Ottavia Gambara, che vanta fra i suoi antenati la poetessa rinascimentale Veronica. L'infanzia serena della bambina viene bruscamente interrotta dalla fuga della madre, che va a vivere con un altro uomo.
Il conte si trasferisce a Milano, mentre Clara, che ha otto anni, viene mandata a studiare in un collegio di suore a Verona. Dopo qualche tempo, Ottavia muore e lei va nella capitale lombarda per perfezione gli studi in una scuola laica alla moda. È il padre a presentarle un uomo più grande di lei di sedici anni, fascinoso, manierato e con gli occhi azzurri. Si chiama Andrea Maffei e proviene dalla piccola nobiltà: ha una passione per i caffè e il gioco d'azzardo, ma se la cava piuttosto bene anche con la penna. Ottimo verseggiatore, traduce opere straniere e sarà librettista di Giuseppe Verdi (preparerà il libretto dei Masnadieri). Clara lo sposa il 10 marzo 1832.
Il matrimonio comincia subito a mostrare le prime crepe, perché Maffei non interrompe la sua movimentata e autonoma vita mondana, né smette di giocare. Ad aggravare le cose si aggiunge il fatto che la bambina della coppia, Ottavia, muore a 9 mesi.
Clara inizia a scivolare in una tetra malinconia. Per distrarla, il marito prende a invitare letterati e artisti di fama in casa. Si apre così, nel 1835, il «salotto Maffei», destinato a divenire un modello in tutta la penisola. La cosiddetta «civiltà della conversazione» era nata in Francia nel Seicento, nell'hotel particulier della Marchesa di Rambouillet, nella famosa Chambre bleu, la Sala azzurra. I salotti - detti allora Bureaux d'ésprit - avevano quindi conosciuto grande successo e diffusione, dato che vi si riunivano tutti gli spiriti eletti del tempo, sotto l'egida della padrona di casa di turno. Il successivo Secolo dei lumi deve molto alle salonnières, le gentildonne colte e raffinate che riuniscono nei loro palazzi artisti, letterati, filosofi, musicisti, intellettuali, uomini politici, diplomatici. L'effervescenza del conversare, l'abilità nel mescolare talenti diversi, l'interesse degli scambi culturali, la circolazione di idee nuove rende i salon dei luoghi fondamentali per innescare il cambio epocale che porta alla Rivoluzione francese. Nei loro palazzi, le signore regnano incontrastate e godono di una inedita libertà e autonomia.
In Italia, la moda dei salotti arriva dopo e riveste una rilevanza minore, perché si affermano le Accademie, di stampo maschile. Comunque a Venezia, Torino, Genova, Firenze e in Lombardia si aprono molte case aristocratiche e dell'alta borghesia, sotto l'egida di celebri dame. Anche in città del Sud come Napoli si cerca di dare nuovo impulso alla vita culturale, benché gli animatori siano più spesso maschili.
Il salotto Maffei conosce un «crescendo» di importanza e notorietà. Dall'Album delle dediche, che Clara - come ogni padrona di casa - conserva gelosamente, si può constatare il livello degli ospiti. Si alternano infatti, negli anni, Massimo d'Azeglio, Carlo Cattaneo, Honoré de Balzac, Giuseppe Verdi, Franz Liszt, il pittore veneziano Francesco Hayez e molti altri. Balzac resta colpito dalla contessina, tanto che scrive: «La prima volta che la vidi mi sentii attratto verso di lei da un fascino irresistibile... Avrei dato dieci anni della mia vita per essere amato da lei per tre mesi. Eppure, a quell'epoca della mia vita, avevo già viaggiato molto, vissuto con donne di quasi tutti i Paesi d'Europa, ma nessuna aveva prodotto su di me un'impressione altrettanto viva, profonda, istantanea».
Pur tuttavia, Clara non è bella. Piccolina, minuta, con un viso particolare e grandi occhi profondi; ha in compenso molta grazia, è un'ottima ascoltatrice, un'amica buona, generosa e devota, una donna colta e intelligente. Molto legata ad Alessandro Manzoni, lo va sempre a trovare la domenica, dopo aver assistito alla messa.
Il suo salotto, nel quale nascono tanti incontri, tanti scambi culturali, non serve a salvare il matrimonio. Mentre ovunque aumenta l'ostilità contro il dominio austriaco, mentre si fondano testate giornalistiche con indirizzo liberale, i Maffei si avviano alla separazione, che avviene per volontà di lei nel 1846. Giuseppe Verdi è di grande sostegno, tanto da essere chiamato come testimone all'Atto di separazione.
Nel frattempo, nella vita di Clara è entrato un giovane giornalista di nome Carlo Tenca, che viene invitato nella villa di Clusone, dove lei trascorre l'estate - «un Eden», a sentire Verdi. Tenca diverrà il compagno della Maffei, che però rifiuterà di andare a vivere con lui, sia per evitare pettegolezzi, sia perché preferisce l'autonomia.
Tornata a Milano, la contessina si stabilisce da sola in una casa di corsia dei Giardini (oggi via Manzoni). Lì il suo salotto rinasce con vigore, anche grazie all'apporto di Carlo Tenca, che vi conduce molti intellettuali. Le frequentazioni, oramai, non sono solo artistiche e intellettuali, ma politiche. L'avvento al soglio di Pio IX nel 1847 ha suscitato grandi aspettative, ovunque i patrioti danno vita a nuovi progetti. Nei teatri c'è enorme fervore, le rappresentazioni di Verdi sono applauditissime.
Le Cinque giornate, la fuga di Radetzky provocano entusiasmo e speranza. Tutta la città si unisce contro il nemico, non si fanno più distinzioni fra aristocratici e popolani, ricchi e poveri. Clara è al centro degli eventi e, insieme ad altre signore, si occupa dei feriti e li ospita nei palazzi aviti. Inoltre, riceve giorno e notte: fra le sue invitate, ci sono patriote, cantanti, attrici, poetesse (passerà anche George Sand).
Il ritorno degli austriaci obbliga parecchie persone a emigrare in Svizzera, in particolare a Lugano, dove si trova Giuseppe Mazzini. Carlo Tenca, invece, va a Locarno, raggiunto dalla stessa Clara. Quando la situazione si normalizza, la coppia torna nella capitale lombarda e Tenca fonda il giornale Il Crepuscolo, che offre un grande contributo alla diffusione del pensiero risorgimentale.
Clara, nel frattempo, si sposta a vivere in via Bigli, rilancia il proprio salotto, invita persone nuove, fra cui Giovanni Visconti Venosta e suo fratello Emilio. Molte sono le testimonianze sul ruolo centrale della sua casa, un vero polo di resistenza agli austriaci. «Uno dei ritrovi ove più gagliardamente ed efficacemente si preparava e si dirigeva la lotta contro l'Arciduca (d'Austria, ndr) era il salotto della contessa Maffei», scrive appunto Visconti Venosta. «Casa Maffei voleva dire in Milano una società politica e battagliera».
Delusa da Mazzini, Clara comincia a volgere le proprie speranze politiche verso Camillo Cavour e il «re Galantuomo», Vittorio Emanuele. Fra fughe, cospirazioni, sconfitte e successi, si giunge all'ingresso di Vittorio Emanuele e Napoleone III a Milano, nel giugno 1859. La celebrità della Maffei, l'importanza riconosciuta al suo ruolo di patriota sono tali che l'imperatore francese le manda la sua foto autografata. Nel salotto di lei, gli ufficiali alleati vengono accolti con La Marsigliese. Si arriva quindi al Plebiscito di unione al Piemonte, poi alle elezioni del 1860. Carlo Tenca viene eletto deputato e inizia a far la spola con Torino (in seguito Firenze, quindi Roma), pur continuando il sodalizio con la Maffei.
L'unificazione entusiasma la contessina, che esclama «Com'è tutta bella la nostra Italia!». Poco dopo, diviene amica della compagna di Verdi, Giuseppina Strepponi. Benché la sua salute inizi a declinare, riceve molto, amplia il giro di amicizie, rimane affascinata dal movimento detto La Scapigliatura e ne invita gli esponenti. Si ammala di meningite nel 1886 e muore quasi subito, compianta da tutti e soprattutto da Verdi, che corre al suo capezzale singhiozzando. Come scrive l'allora sindaco Gaetano Negri: «Tutta l'arte che gli altri mettono nel fare il male e dire il male, la contessa Maffei la spese nel fare il bene e dire il bene».