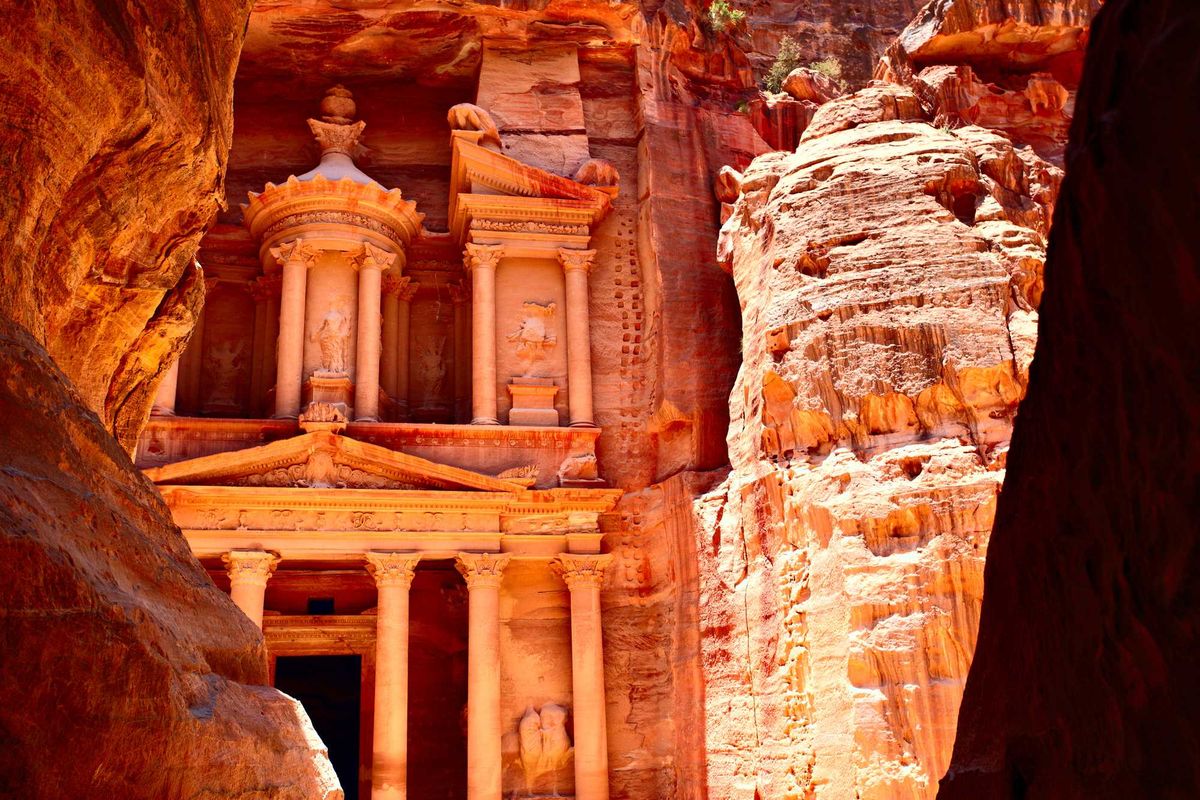La Bce ha in pancia bond Aspi. L’accordo con i Benetton non può deludere la Lagarde

- Oltre al sostegno della Banca centrale europea, Autostrade gode di un finanziamento della Bei. L'esecutivo minaccia la revoca, ma rischia di danneggiare istituzioni amiche.
- A Roberto Gualtieri servono altri 25 miliardi. Sul tavolo un taglio alle detrazioni. L'obiettivo del Mef sarebbe una manovra senza deficit: dietro l'artificio lessicale si nasconde un aumento della pressione fiscale. E intanto Ernesto Maria Ruffini (Entrate) anticipa una super riforma delle tasse con 5 testi unici...
Lo speciale comprende due articoli.
«Noi pretendiamo che vengano rispettati gli accordi del 14 luglio, e riteniamo di avere anche gli argomenti e le modalità corrette per far rispettare quegli accordi». Con queste parole giovedì scorso il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Paola De Micheli, ha commentato lo stallo delle trattative con il gruppo Atlantia della famiglia Benetton per definire il passaggio della società controllata Autostrade per l'Italia (Aspi) a favore della Cassa depositi e prestiti (Cdp) e di altri investitori istituzionali graditi.
Dopo il Consiglio dei ministri della notte del 14 luglio, il cui esito fu salutato dal Fatto Quotidiano con il titolo «Autostrade libere, i Benetton in fuga», sembrava tutto risolto. Ma la fuga non è nemmeno cominciata, perché la definizione dei decisivi dettagli negoziali, attesa per lo scorso 27 luglio, stenta ancora a vedere la luce.
Anzi, siamo in presenza di una controproposta di Atlantia che ribalta completamente tutti i capisaldi negoziali annunciati dal governo e fa ripartire da zero tutto il complesso meccanismo che dovrebbe disciplinare l'uscita dei Benetton dal controllo di Aspi. Non annoieremo il lettore con i dettagli di finanza e diritto societario che differenziano quanto deciso in Cdm da quanto controproposto da Atlantia. È invece più interessante spostare l'attenzione su altri due aspetti.
Il primo: in Aspi gli unici interessi non sono solo quelli dei Benetton, ma anche degli altri detentori di obbligazioni ed azioni, dalla Bce, alla Bei, ai tedeschi di Allianz per finire ai cinesi del fondo Silk road.
Il secondo: la Cdp è fuori dal perimetro dell'amministrazione pubblica e fa operazioni a condizioni di mercato, avendo anche la responsabilità dell'impiego oculato di decine di miliardi di risparmio postale. E questo mette in discreta difficoltà chi crede (in molti nel M5s) che il controllo di Cdp preluda alla decisione di ridurre i pedaggi autostradali.
Esaminando in dettaglio il primo aspetto, emerge che Bce ha acquistato nell'ambito del programma Cspp ben nove obbligazioni di Aspi e due della controllante Atlantia, la Bei ha erogato ad Aspi un finanziamento di 1,3 miliardi e il gruppo tedesco Allianz, quello francese Edf, quello olandese Dif e il fondo governativo cinese Silk road insieme detengono l'11,94% di Autostrade. La revoca della concessione avrebbe esposto questi titoli a un grave rischio e non è una cosa tanto saggia far perdere soldi alla Bce. Ma neppure agli altri «pesi massimi» prima elencati. Anche perché, indipendentemente dalla Banca centrale nazionale che ha eseguito quegli acquisti, le perdite vengono condivise da tutte le 19 banche centrali dell'Eurosistema. C'è un solo precedente: quello delle obbligazioni emesse dal gruppo sudafricano della grande distribuzione Steinhoff, con solide radici in Germania. In quel caso la Bce vendette nel 2018 i titoli del gruppo coinvolto in problemi contabili e finanziari, accantonando la somma di circa 69 milioni di euro, presumibilmente destinata a coprire proprio tali perdite.
Questi acquisti della Bce ci spingono a esaminare a fondo un aspetto molto discutibile che caratterizza il programma di acquisti partito nel marzo 2015 sotto la presidenza di Mario Draghi. Da allora, la Bce ha acquistato (al netto dei rimborsi) con il programma Cspp circa 224 miliardi di obbligazioni di società private, di cui, evidenziando una discreta accelerazione, ben 30 miliardi nel periodo marzo-luglio. Il fenomeno è ancora più evidente osservando l'altro programma, il Pepp, partito a marzo 2020: fino a luglio sono stati acquistati 18 miliardi di bond societari e 35 miliardi di «commercial paper» (strumenti di debito a breve termine). In tutto sommano, in soli cinque mesi, 83 miliardi di acquisti. Il diavolo si nasconde in due dettagli: il 22% circa dei titoli del Cspp sono acquistati dalla Bce direttamente all'emissione, quindi sul mercato primario, cosa non possibile per i titoli di Stato. Senz'altro un rilevante aiuto per gli emittenti, ritrovarsi direttamente con la Bce tra i compratori senza farsi intermediare da nessuno. Inoltre, ben il 60% dei bond acquistabili è emesso da imprese francesi e tedesche, con Italia e Spagna ridotte all'8% ciascuna; e gli acquisti effettivi si discostano poco da queste percentuali. Questi numeri e la loro recente accelerazione avvalorano la tesi che, a partire da marzo, la Bce, oltre a tonificare il mercato dei nostri Btp, abbia anche assorbito il debito di qualche gigante bancario (e non) d'Oltralpe traballante.
Osservando il secondo aspetto, qualunque sia il modo in cui Cdp prenderà il controllo di Autostrade, resta ancora da sciogliere un nodo essenziale: il prezzo di Autostrade. La tecnica aziendale ci dice in modo chiaro che esso è legato ai flussi di cassa futuri che a loro volta dipendono dai ricavi da pedaggi (al netto dei costi operativi), dagli investimenti e dalle manutenzioni e dal relativo costo del capitale. Non se ne esce: se si vuole una rete autostradale efficiente, bisogna pagarla, sia con i Benetton che con Cdp. Ma quanto? Finora quegli investimenti erano remunerati a un tasso relativamente alto del 10% circa, che ha fatto di Aspi la gallina dalle uova d'oro per tutti: Benetton in primis, ma non solo. Ora dovrebbe scendere al 7% circa, abbattendo in questo modo il prezzo di cessione di Aspi, a meno che non si riducano gli investimenti o si aumentino i pedaggi. Un triangolo delle Bermuda.
Si giunge così al nodo finale: esiste un livello di compromesso del prezzo di cessione di Aspi che sia accettabile da Atlantia e soci (abituati molto bene e non disposti a subire perdite), Cdp (che deve remunerare a livelli di mercato il proprio investimento) e il governo (che si attende investimenti sulla rete e diminuzione dei pedaggi)? Fino a che punto è reale lo spauracchio della revoca ancora agitato dal governo, quando provocherebbe diversi miliardi di perdite agli «amici degli amici», che è bene non indispettire?
A Gualtieri servono altri 25 miliardi. Sul tavolo un taglio alle detrazioni
«Il coraggio, uno, se non ce l'ha, mica se lo può dare» è la celebre frase che Alessandro Manzoni appiccica sulle labbra di don Abbondio al capitolo XXV dei Promessi sposi, in risposta al cardinale Borromeo che chiedeva per quale motivo il curato si fosse rifiutato di sposare Renzo e Lucia. I Promessi sposi vivono e lottano insieme a noi ancora oggi. Quanto meno, uno dei personaggi. Il pavido don Abbondio, che prende possesso del corpo del ministro Roberto Gualtieri sempre succube al don Rodrigo di turno. Ora l'erede di Giovanni Tria fa trapelare che ha un bisogno matto di 25 miliardi, e qualche idea - pericolosa - su dove trovarli.
E come don Abbondio, che di fronte ai bravi di don Rodrigo non vede alternativa che accelerare il cammino, il suo sguardo cerca ossessivamente quello del direttore generale del ministero. Al secolo Rivera Alessandro, per il quale Gualtieri nutre una soggezione paragonabile a quella del curato del Manzoni per qualsiasi cosa si avvicinasse intorno a lui. Guai a pronunciare una parola fuori posto: Rivera potrebbe arrabbiarsi. E se gli arriva una domanda non prevista dai parlamentari, i tecnici di Via XX Settembre sono pronti con il messaggino di Whatsapp. Gualtieri legge senza mai staccare lo sguardo dallo smartphone, incurante - spesso e volentieri - di rivelare verità scomode che mai si sarebbe sognato di dire forse perché a lui ignote: come ad esempio che i prestiti del Recovery fund hanno le stesse caratteristiche del Mes. Un credito privilegiato che trasforma in subordinati tutti i Btp in circolazione.
Alla paura Gualtieri unisce l'ingenua inconsapevolezza dell'importanza del ruolo che ricopre. Mai al punto giusto ma sempre una curva indietro. Come i piloti di Formula 1 che secondo Enzo Ferrari perdono un secondo a giro ogni volta che nasce loro un figlio. «Spenderemo 3,6 miliardi per affrontare la crisi. E l'Ue ci darà via libera». Così don Abbondio Gualtieri mostrava di padroneggiare la situazione lo scorso 29 febbraio, in un'intervista a Repubblica. Pochi giorni dopo un respiro profondo, tanto training autogeno e il nostro curato prende carta e penna per scrivere all'Unione europea: «Chiediamo al Parlamento e alla Commissione europea di considerare il pacchetto di emergenza in misura pari allo 0,3% del Pil come una voce di bilancio una tantum che non si ripresenterà una volta che l'Italia avrà superato l'epidemia di Covid-19 e le sue ricadute economiche». La sua comprensione della situazione di grave drammaticità era tale da fargli ritenere che 6 miliardi una tantum sarebbero stati più che sufficienti. E che questa spesa non si ripetesse mai più. Dura la vita del don Abbondio alla guida dell'Economia. Neppure quando il presidente della Repubblica Sergio Mattarella rampogna severamente Christine Lagarde, rea di aver gettato nel panico i mercati dichiarando «la Bce non è qui per chiudere gli spread», il nostro Gualtieri riesce a prendere il coraggio a due mani. E fa filtrare alle agenzie di aver «accolto con favore l'opportuna precisazione della presidente della Bce, Christine Lagarde, che, chiarendo il contenuto delle sue dichiarazioni, ha sottolineato che non consentirà che lo shock derivante dalla diffusione del Covid-19 possa provocare una frammentazione del sistema finanziario dell'area euro». Quando in realtà la Lagarde non aveva ancora corretto un bel nulla. Dodici giorni dopo, il 24 marzo, di nuovo in audizione. Don Abbondio Gualtieri dimostra di avere bene in testa il quadro della situazione parlando di «elevata contrazione del Pil» che porterebbe a fine anno a una contrazione «nel 2020 di qualche punto percentuale, grave ma gestibile e recuperabile». «Questo è il grafico più deprimente che abbia mai mostrato in vita mia» commenterà su Twitter l'economista francese Frederik Ducrozet il 31 luglio mostrando la caduta del Pil del nostro Paese. Un catastrofico -21% rispetto ai dati del 2008, il picco di reddito mai più toccato dall'Italia. In pratica abbiamo il reddito che avevamo nel 1993.
L'Istituto turboeurepista Bruegel rivela il 5 agosto che lo stimolo fiscale italiano in risposta alla crisi è stato pari al 3,4% contro l'8,3% della Germania. In pratica mancano all'appello almeno 80 miliardi per fare una manovra paragonabile a quella di Berlino oltre a quanto già malamente speso. Ma sebbene il Fiscal compact sia stato sospeso, Gualtieri ci dice - anzi, ci sussurra secondo un retroscena di Repubblica - che non ci sono più soldi. Si abbasseranno le tasse per 25 miliardi autofinanziando l'operazione. Vale a dire aumentandole da qualche altra parte tagliando deduzioni, detrazioni, esenzioni varie. E lascia l'incarico di rivelarne i dettagli al capo dell'Agenzia delle entrate Ernesto Maria Ruffini. Tocca a lui (?) disegnare la portata della manovra: cinque testi unici per riunire una mole intensa di norme e fare una riforma come quella del 1969. Meglio non fare gaffe, pensa Gualtieri. Lasciamo che sia il tecnico Ruffini a parlare. Del resto «uno se il coraggio non ce l'ha non se lo può dare».