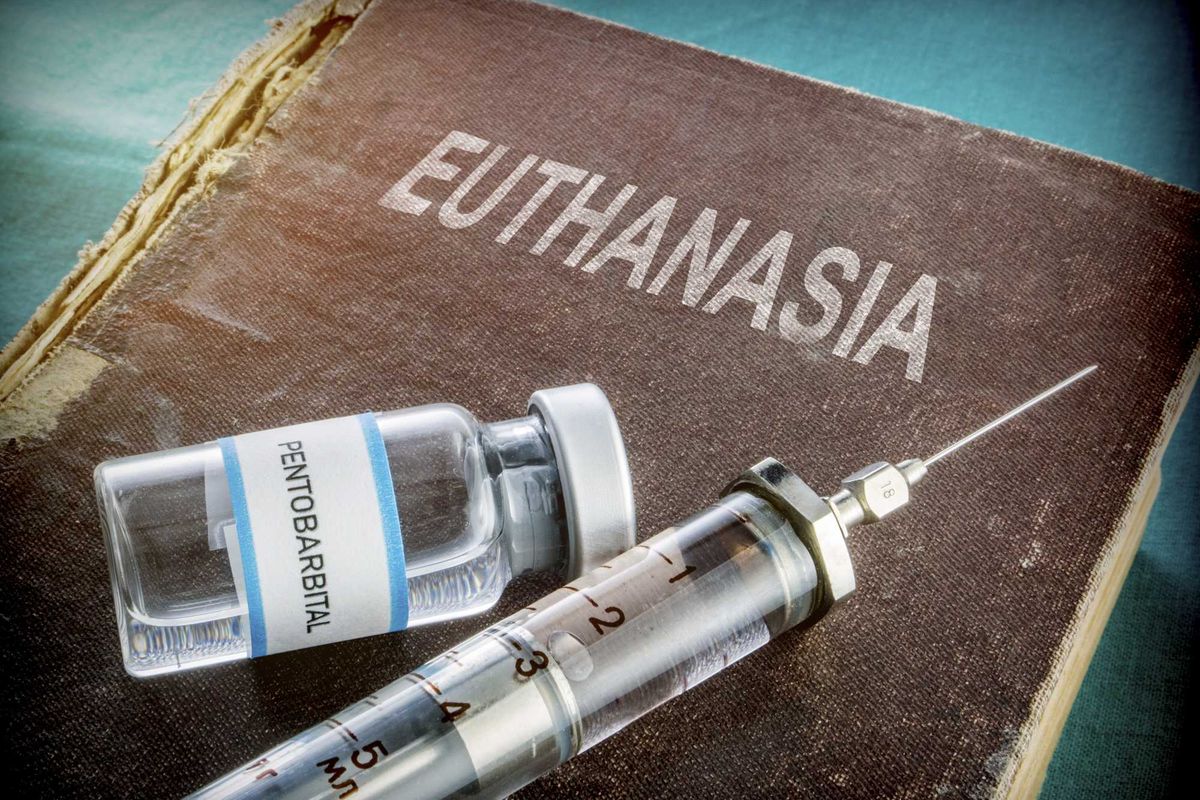Anche se l’Ue ci affossa l’industria, per ora va meglio di Berlino e Parigi
A novembre 2023 la produzione industriale in Italia arranca e delude anche le aspettative. È questa la sintesi che si trae dai dati pubblicati ieri dall’Istat. A novembre 2023, la variazione dell’indice rispetto al mese precedente è del -1,5%. Il trimestre settembre-novembre peggiora del 0,8% rispetto a giugno-agosto. Decisamente negativo anche il confronto rispetto al 2022: -3,1% per il mese e -2,5% per i primi 11 mesi. In arretramento tutti i comparti, inclusi i beni di consumo, con la punta negativa della produzione di energia (-4%) e con l’eccezione della sostanziale tenuta dei beni strumentali (-0,2%). In particolare, rispetto a novembre scorso, il calo peggiore si registra nell’industria del legno, carta e stampa, nel tessile-abbigliamento, e nella gomma-materie plastiche. Mentre la fabbricazione di coke e petroliferi raffinati e dei mezzi di trasporto fanno segnare significativi incrementi.
Però i dati sulla produzione industriale vanno messi in prospettiva, spostando in secondo piano le variazioni congiunturali e cercando le tendenze più consolidate. Tuttavia il quadro che se ne trae non è meno preoccupante. Come si osserva nel grafico in pagina, a novembre abbiamo osservato solo l’ultimo episodio di una lenta crisi che ha eroso la produzione industriale rispetto al picco di fine 2021. Quando avevamo finalmente recuperato il livello pre-pandemia ed eravamo su un discreto trend ascendente. Da allora, hanno prevalso i segni negativi.
La nostra industria è stata seriamente danneggiata dal repentino aumento dei costi di energia e gas partito già nell’estate-autunno 2021. Una crescita che ha un solo colpevole: le scelte della Commissione a favore della transizione energetica che hanno disincentivato gli investimenti nelle fonti fossili a favore di fonti energetiche rinnovabili, con il programma «Fit for 55» (riduzione delle emissioni nette di gas serra di almeno il 55% entro il 2030), asse portante del Green Deal europeo. Il dogma imperante è che l’energia deve costare molto per consumarne meno e impiegarla in modo più efficiente. A Bruxelles si sono preoccupati di fissare l’obiettivo finale, ma hanno considerato trascurabili i danni collaterali. Il risultato finale, ma il trend discendente è destinato a continuare, è quello del lento declino dei settori industriali più energivori.
Ma l’industria italiana sta riuscendo a contenere i danni, al confronto con quanto sta contemporaneamente accadendo in Francia e, soprattutto, in Germania. In entrambi i Paesi la produzione industriale è al di sotto del livello del 2015, mentre in Italia è ancora lievemente al di sopra. A scanso di equivoci, non parliamo delle dimensioni assolute della produzione, ma qui ci interessano ed osserviamo le variazioni rispetto ad un livello di partenza, definito uguale per tutti. E il trend discendente della Germania negli ultimi 12 mesi è impressionante, con una ripidità ben superiore a quella italiana. L’andamento della Francia è sostanzialmente stabile, proprio a confermare che la disponibilità di fonti di energia a basso costo - Parigi dispone di energia nucleare ed ha adottato importanti rimedi per mitigare l’impatto dell’aumento dei prezzi energetici – ha fatto la differenza nel determinare la direzione di marcia dell’output industriale.
Ma se Bruxelles ha la colpa di aver avviato il declino, minando la competitività di rilevanti settori industriali italiani ed europei, a Francoforte hanno la colpa di averlo almeno accelerato e di continuare a deprimere l’economia con un livello di tassi di interesse ormai disallineato rispetto alla realtà ed alle prospettive.
Dopo i dati della produzione industriale tedesca e italiana, non sappiamo quanti altri dati Christine Lagarde dovrà attendere per comprendere che - aumentando i tassi di 450 punti in 14 mesi - ha usato la bomba atomica per demolire un’ala di un edificio. Col risultato di devastare l’intera città. Tale è infatti l’effetto dell’uso della leva del tasso di interesse per affrontare un’inflazione che trova tra le sue prevalenti determinanti lo shock dei prezzi energetici e le strozzature nelle catene di fornitura. La domanda non è mai stata particolarmente vivace, al contrario di quanto accaduto negli Usa.
I prezzi caleranno, come stanno calando, ma prevalentemente per dinamiche loro proprie. Il contributo dell’azione della Bce appare marginale, nel senso che ha spinto in discesa qualcosa che già rotola. Tutto questo appare ancora più grave alla luce dei noti effetti, molto variabili e diluiti nel tempo, dei rialzi dei tassi. Sono passati 18 mesi dal primo rialzo dei tassi di luglio 2022 ed esiste un generale consenso che i rialzi riescano a frenare i prezzi con un ritardo di 18-24 mesi. Quindi la valanga dell’effetto restrittivo delle decisioni della Bce ha appena cominciato a scendere e l’inflazione è già al 2,9% (in Eurozona, in Italia al 0,6%) e la produzione industriale continua a frenare.
Ove tutto ciò non bastasse, la Commissione ha imposto che anche la politica di bilancio degli Stati membri assuma un’impostazione restrittiva, a prescindere dal Patto di Stabilità. Allacciamo le cinture.