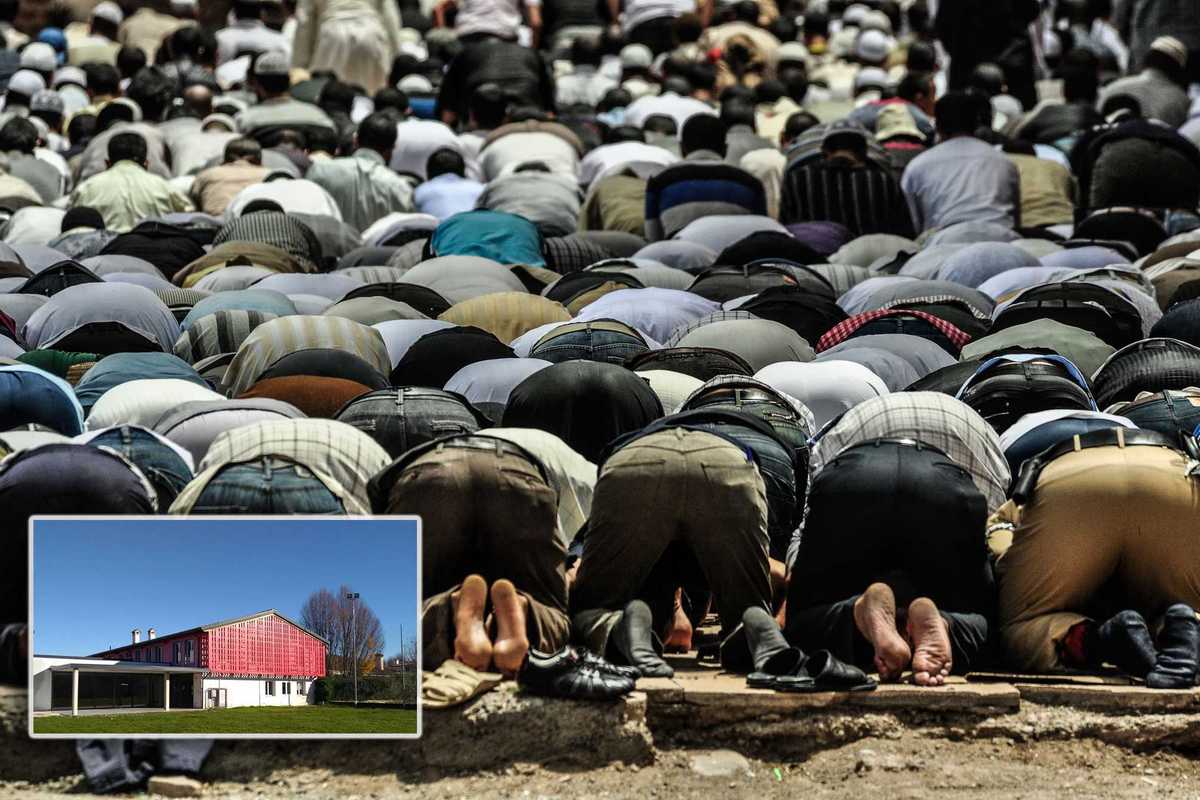Il Perù in crisi profonda. Trionfano solo i cartelli della droga
- Il Paese attraversa una grave crisi politica, sfiancato dalle continue crisi di governo. Anche la Presidenza da quasi un decennio è falcidiata dagli impeachment anche se il Pil è salito del 3,3% nel 2024. Trionfano i cartelli della droga, che hanno portato il Perù ad essere il primo produttore al mondo di cocaina.
- Il Perù è stato il primo Stato del Sudamerica a riconoscere l'Impero del Sol Levante post-isolazionista già nel 1873. Per questo è stato oggetto di un forte flusso di immigrati dal Giappone sin dal 1899. La parabola dei Nikkei Perujin, dal lavoro nelle piantagioni al successo in città, alla deportazione nei campi di prigionia negli Usa.
Lo speciale contiene due articoli.
L’instabilità politica è ormai un problema endemico della Repubblica del Perù che da anni non ha più un governo o un presidente che possano dire di avere la fiducia del popolo. L’ultima crisi di governo era stata a maggio scorso quando il Primo ministro Gustavo Adrianzen si è dimesso per evitare la sfiducia che lo avrebbe fatto cadere. Da allora il paese andino è guidato dal tecnico Eduardo Arana Ysa, ma il ritorno alle urne appare sempre incombente. La presidenza è in una situazione ancora peggiore in una nazione che è una Repubblica Presidenziale e che ha storicamente avuto dei presidenti che hanno tenuto il paese con il pugno di ferro. Dal 2016 nessuno è riuscito a terminare un mandato tra inchieste della magistratura e vari tentativi di impeachment, a volte riusciti e a volte no, da parte del parlamento. Il presidente Pedro Pablo Kuczynski eletto nel 2016 si è dimesso nel 2018 per le accuse di voto di scambio con i deputati fujimoristi, seguaci di Keiko Fujimori, figlia dell’ex presidente Alberto, che per 10 anni ha dominato il Perù per poi essere condannato a 25 anni di carcere per crimini contro l’umanità. Kuczynski è stato accusato di aver concesso la grazia a Fujimori nel 2017 in cambio di una votazione a proprio favore, quando era incriminato per corruzione. Nel 2019 l’ormai ex presidente è stato arrestato per corruzione e riciclaggio di denaro e si trova ancora ai domiciliari. Il suo successore Martin Vizcarra è rimasto in carica fino al novembre del 2020 per poi essere destituito da un nuovo impeachment del parlamento, nonostante le forti proteste popolari a suo sostegno. Il presidente seguente, Manuel Merino, è rimasto in carica meno di una settimana, sostenuto soltanto dai militari, ma le violenze della polizia sui manifestanti lo hanno costretto alle dimissioni. Il presidente Francisco Sagasti si è limitato a traghettare il Perù alle elezioni del 2021, in un’atmosfera sempre più tesa. Il sindacalista Pedro Castillo, leader delle proteste di piazza, aveva trionfato sconfiggendo al secondo turno la solita Keiko Fujimori, eterna candidata per tre volte consecutive. Anche il “regno” di Pedro Castillo è durato appena un anno e mezzo quando al terzo tentativo di impeachment da parte del parlamento, dominato dai partiti conservatori, per la sua politica fortemente socialista, Castillo ha cercato di sciogliere il parlamento imponendo il coprifuoco. Quello che è stato definito come un colpo di Stato istituzionale è stato fermato ancora una volta dal parlamento che questa volta è riuscito ad ottenere le dimissioni il 7 dicembre del 2022, passando i poteri alla vicepresidente Dina Boularte. Pedro Castillo, dopo aver cercato di raggiungere l’ambasciata messicana e chiedere asilo politico è stato arrestato e si trova tuttora in carcere. Ma la situazione peruviana non è migliorata e stando ai sondaggi oggi la presidente Dina Boularte ha un gradimento di appena il 2%. Sia Adrianzen che la presidente sono accusati di non aver fatto abbastanza per contrastare la criminalità organizzata che sta dilagando nel paese, nonostante la recente decisione di schierare l’esercito nelle strade. La Boularte sta tentando con tutte le sue forze di restare al potere e nel maggio scorso ha anche annunciato una serie di misure d’emergenza nella provincia di Pataz, nel nord-ovest dello stato sudamericano, dopo il ritrovamento dei corpi di tredici impiegati di un’azienda mineraria che erano stati rapiti. L’attività mineraria, autentico motore dell’economia peruviana, è al centro di forti tensioni nella provincia, dove dal febbraio 2024 è in vigore uno stato d’eccezione per le violenze legate all’estrazione illegale dell’oro. Ma è indubbiamente la lotta al narcotraffico il primo punto di tutte le agende politiche peruviane. Lima si colloca infatti al primo posto a livello mondiale come produttore di cocaina e nel 2024 ha segnato il record di sequestri di sostanze stupefacenti con centosettanta tonnellate tra cocaina e marijuana. Sono state individuate oltre 100 piste di atterraggio clandestine, cinquanta approdi costieri e più di mille laboratori impiegati nella produzione e raffinazione di cocaina, con un aumento del 200% del territorio utilizzato per le piantagioni di coca. Il Perù si sta trasformando in un vero e proprio narco-stato, con legami con i cartelli della droga colombiani. Con la droga è esplosa la violenza con il numero di omicidi che è aumentato vertiginosamente, soprattutto nella capitale e nelle grandi città della costa pacifica con più di duemila omicidi l’anno. Il traffico di sostanze stupefacenti è in continuo aumento ed è destinato per l'80% al mercato europeo, per il 10% agli Stati Uniti e per il restante 10% ad altri Paesi latino-americani, al Sud Africa e all'Asia. I governi che si sono susseguiti sono apparsi inermi e la presidente Boularte ha proposto di reintrodurre la pena di morte per il narcotraffico. Ma la sfiducia della popolazione è totale e considerano i parlamentari responsabili della crescita della criminalità organizzata con metà del parlamento sotto inchiesta per corruzione. Nonostante gli enormi problemi interni, l’economia peruviana ha registrato la crescita più rapida del continente sudamericano nell’ultima decade. Lima possiede le maggiori riserve di argento del mondo, nonché le più ampie riserve d’oro, piombo e zinco del Sud America. La costa del Perù ha un grande potenziale grazie alle sue risorse marittime, mentre l’industria agricola esporta asparagi, mirtilli, uva da tavola, avocado, banane, paprika. L’Amazzonia, inoltre, ospita ricchi giacimenti di petrolio e gas naturali, oltre alle sue imponenti risorse forestali. Una situazione complicata in un paese allo sbando che avrebbe notevoli potenzialità, ma la corruzione e la criminalità lo stanno spengendo verso il baratro.
I Nikkei Perujin, da «campesinos» a imprenditori a nemici: la storia dell'emigrazione giapponese in Perù
Il Sol Levante e il Perù hanno un rapporto diplomatico nato sin dalle origini del Giappone moderno (coincidente con l’inizio dell’era Meiji nel 1868). Le prime relazioni ufficiali risalgono al 1873, in seguito a quello che è noto come un incidente diplomatico. Il 9 luglio 1872 la nave peruviana Maria Luz, carica di lavoratori cinesi in semi schiavitù, entrò nel porto franco di Yokohama per effettuare riparazioni dopo i danni subiti da una tempesta. Nel porto alcuni cinesi riuscirono a fuggire chiedendo asilo ai giapponesi. Ne nacque un caso diplomatico e giudiziario che travalicò i confini del Paese asiatico. Il Giappone, desideroso di dimostrare l’apertura al mondo, portò a casa la vittoria arbitrata dallo zar Alessandro II di Russia, dando il via ad una serie di riforme sociali che caratterizzeranno gli anni successivi. Il 21 agosto 1873 le relazioni tra Tokyo e Lima furono formalizzate nel Trattato di Pace, Amicizia, Commercio e Navigazione. Il Perù era la prima nazione latinoamericana a riconoscere il Giappone come Stato indipendente e cooperante. Nelle clausole, oltre all’equità commerciale, erano ratificate la libertà di movimento e di impresa dei cittadini di entrambi i Paesi.
Fu un’altra nave, questa volta seguendo una rotta inversa rispetto alla Maria Luz, a segnare l’inizio dell’emigrazione nipponica in Perù. Dal 3 aprile al 9 maggio 1899 la Sakura Maru (letteralmente la nave dei ciliegi in fiore) navigò il Pacifico portando i primi 790 emigranti giapponesi che avevano siglato un contratto con i proprietari peruviani di piantagioni di canna da zucchero, dopo che la fine del flusso di lavoranti forzati cinesi si era interrotto negli ultimi decenni del secolo XIX, generando una preoccupante mancanza di forza lavoro. Nei campi, la vita dei giapponesi si mostrò da subito durissima. Nei primi anni del nuovo secolo i migranti cominciarono a spostarsi nelle aree urbane allora in crescita, ed in particolare nella capitale Lima. Qui si specializzarono come barbieri (l’espressione El barbero japonès divenne diffusissima nella capitale), titolari di piccoli negozi e lavanderie, oltre che importatori di generi vari dalla madrepatria e, nel nord del Perù, pescatori. Negli anni tra le due guerre i Nikkei Perūjin (o giappo-peruviani) mantennero vive le tradizioni delle loro origini con la fondazione di scuole e centri religiosi, mentre crescevano le seconde e terze generazioni (in giapponese Nisei e Sansei) ormai peruviane ma molto legate alla cultura dei padri.
La rottura drammatica tra il Perù e la popolazione di origini giapponesi avvenne all’indomani dell’attacco giapponese a Pearl Harbour del 7 dicembre 1941, che determinò l’ingresso in guerra degli Stati Uniti, principale alleato del Perù allora guidato dal presidente Manuel Prado y Ugarteche. Lo scoppio della guerra fornì l’occasione per l’esplosione di episodi xenofobi nei confronti dei giappo-peruviani. La nuova condizione di «alieni nemici» portò a gravi episodi di violenza e saccheggio (600 casi nella sola Lima) contro le proprietà degli stranieri colpevoli di aver fatto fortuna in terra peruviana. Ad aggravare la situazione la posizione antigiapponese del presidente Prado, che appoggiò in toto la richiesta di Washington relativa alla deportazione dei giapponesi del Perù, nonostante Lima non fosse formalmente in guerra con il Sol Levante, cosa che avverrà soltanto verso la fine della guerra nel 1945. La maggior parte dei prigionieri fu deportata in campi di detenzione in Texas, mentre i beni materiali dei proprietari venivano sequestrati dalle autorità peruviane. In totale tra il 1941 e il 1945, i cittadini peruviani di origine nipponica espulsi dal Paese nel quale molti di loro erano nati furono circa 1.800, in maggioranza uomini. Durante il periodo bellico, l’ostilità verso i giapponesi fu alimentata anche da un falso memoriale del 1927, il cosiddetto Tanaka Memorial. Il documento, che più tardi fu considerato un falso redatto dalla propaganda cinese durante la guerra degli anni ’30 contro l’Impero giapponese, sarebbe stato concepito e presentato all’imperatore Hirohito dal premier Giichi Tanaka. Nel memoriale erano elencati immaginari piani di conquista del mondo, a partire dal Sudest asiatico per terminare con gli Stati Uniti passando dal Sudamerica compreso il Perù. Naturalmente, il falso fu usato dalla propaganda peruviana per giustificare le deportazioni dal periodo bellico e agitare lo spettro di una «quinta colonna» giapponese che nei fatti non vi fu mai. Il destino dei Nikkei Perūjin fu doppiamente amaro dopo il 1945. Alla maggior parte di questi, alla fine della guerra, fu impedito di rientrare in Perù, divieto che fu prolungato anche nel decennio successivo. Solo 80 cittadini peruviani di origine giapponese poterono tornare a ridosso della fine del conflitto, ma trovarono un ambiente alquanto ostile. Il resto dei prigionieri, tra cui molti nati in Perù e di lingua spagnola, fu rimpatriato forzatamente nel Giappone distrutto dalle atomiche e dalla depressione postbellica. Quelli che erano rimasti in Perù dovettero ricominciare tutto da capo, come ai tempi della prima immigrazione a bordo della Sakura Maru, partendo nuovamente dai lavori più umili nei campi. Soltanto tra gli anni ’60 e ’70 la comunità fu in grado di ritrovare spazi e relativa fortuna imprenditoriale. Oggi la comunità nippo-peruviana è la seconda più grande dopo quella degli Stati Uniti e conta circa 80-100.000 cittadini.