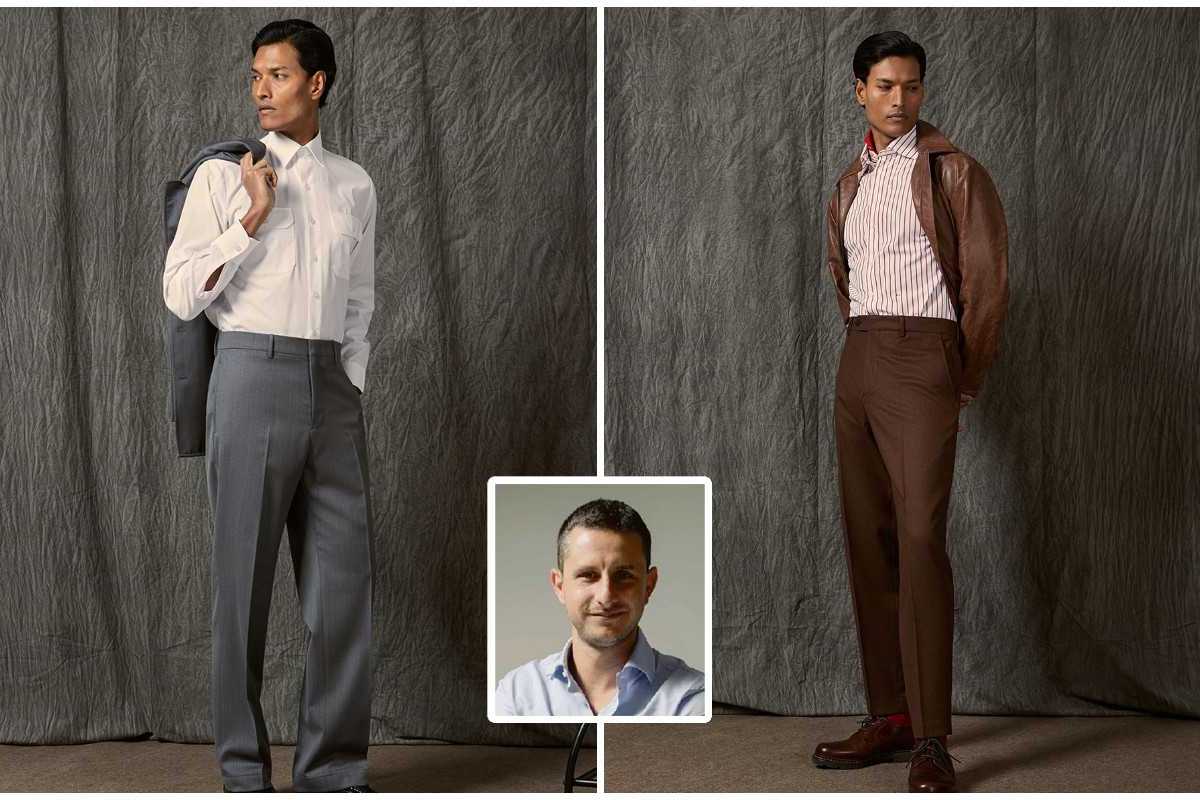- La legge del 1996 che regola il Web dà mano libera ai proprietari delle reti sociali. Che oggi sono diventati dei giganti incontrollabili. Sfuggono alle regole e possono censurare chi vogliono.
- Boom di cancellazioni dalle piattaforme censorie e di iscrizioni alle chat alternative.
Lo speciale contiene due articoli
Per capire come è stato possibile che il patron di Facebook, Mark Zuckerberg, abbia potuto oscurare l'account di Donald Trump, bisogna risalire a quella che è ancora l'unica norma che regola il mercato di Internet. Più che una legge sono 26 parole. Le parole di un comma inserito nella Sezione 230 del Communications Decency Act del 1996, che recita così: «Nessun fornitore e nessun utilizzatore di servizi Internet può essere considerato responsabile come editore o autore, di una qualsiasi informazione fornita da terzi». Su questa frase, i padroni delle reti sociali hanno costruito la loro fortuna e i loro business miliardari. La Sezione 230, oltre a sancire che le piattaforme non sono responsabili per ciò che viene pubblicato, dà anche ampia libertà alle società che le gestiscono di moderare i post e i contenuti in generale. Quindi, se un utente dice qualcosa di diffamatorio su una piattaforma, questa non è responsabile e non sarà perseguibile, ma può rimuovere il contenuto o filtrarlo perché in base alla legge ha la facoltà di gestire il servizio come vuole.
Quando Zuckerberg dice che si sente responsabile per quello che accade sulla sua piattaforma, dice qualcosa di non vero, perché la legge dispone diversamente, ma può intervenire a gestire la piattaforma come più gli piace. Il patron di Facebook in uno degli ultimi interventi pubblici ha ammesso che i social network sono in un terreno ancora da regolamentare, a metà strada tra una società editrice e una di telecomunicazioni. Vivono in una zona franca in cui ciò che conta è solo il denaro; più il proprietario è potente e già può condizionare il mercato e ora, la politica, in modo spregiudicato. Nel 2016, durante la campagna per le presidenziali Usa, quando si affacciò l'ipotesi che interferenze russe sui social fossero in grado di condizionare le elezioni, sia i senatori democratici sia quelli repubblicani avevano sollevato il problema di riformare la Sezione 230. Non se ne è fatto nulla.
L'assenza di regole, da una parte è condannata, ma dall'altra è ampiamente sfruttata dalla politica che ha sempre più affidato al Web la costruzione del consenso e del successo. Il presidente Barack Obama è stato il primo a usare i social in modo massiccio, il che lo ha fatto apparire nuovo, moderno, in sintonia con i tempi e con un elettorato iperconnesso. Poi è arrivato Donald Trump che ha attivato una campagna infuocata, mai vista prima, a colpi di tweet e post su Facebook a ripetizione. È stato lo stesso organizzatore della sua campagna elettorale, Steve Bannon, a rivelare che il segreto del successo virale sui social è nell'uso di toni forti con un crescendo che crea una sorta di dipendenza negli utenti. La grammatica esplosiva usata da Trump dello scontro estremo con gli avversari ha prodotto anche il risultato di costringere i media tradizionali, che pure gli erano ostili, a stargli dietro offrendogli spazi, altrimenti impensabili.
Perché allora, nella sua ascesa, Facebook non ha fermato Trump? Proprio in virtù della legge 230, che solleva il proprietario da qualsiasi responsabilità, ma soprattutto perché il climax dello scontro politico aveva concentrato l'attenzione sui social. E più tempo gli utenti passano sulle piattaforme, maggiore è la raccolta pubblicitaria, quindi il business. La rivista Fortune ha riportato la testimonianza di un ex direttore di Facebook, Tim Kendall, che ha illustrato la strategia usata dal social per creare la dipendenza ai suoi utenti. Una strategia ispirata dalle multinazionali del tabacco che sembra anticipare quello che è successo a Washington.
«Permettere a disinformazione, teorie cospirazioniste e fake news di fiorire», sostiene Kendall, «era come i broncodilatatori delle Big Tobacco, che permettono al fumo delle sigarette di coprire maggior superficie dei polmoni. Ma i contenuti incendiari non erano abbastanza. Per continuare a crescere il numero di utenti, e soprattutto il tempo e l'attenzione data a Facebook, si fece di più. Le aziende di tabacco aggiunsero ammoniaca alle sigarette per aumentare la velocità con cui la nicotina arrivava al cervello. Contenuti estremi, incendiari, immagini scioccanti, video, e titolazione che incitavano indignazione, seminavano tribalismi e divisione. Queste scelte di contenuti risultarono un ingaggio e profitto senza precedenti».
Google deve il suo successo alla libertà concessa agli utenti di scrivere qualsiasi cosa anche falsa e violenta,indicizzata dal motore di ricerca senza che Google possa essere considerato responsabile. Ora però Facebook e Twitter hanno fatto un altro passo in avanti, si sono comportati come se fossero garanti, responsabili giuridicamente dei contenuti. Sospendere a tempo indeterminato l'account del presidente degli Stati Uniti è la rivendicazione di un potere illimitato e incontrastato. La Sezione 230 è stata al centro di una serrata offensiva di Trump che ha minacciato di abolirla scagliandosi contro le piattaforme, colpevoli, a suo dire, di avere un pregiudizio contro i politici repubblicani.
Un'altra azione dura messa in campo in questi giorni è stata quella di Amazon che ha rimosso il social Parler, punto di riferimento del pensiero conservatore, dal suo cloud, con la motivazione di voler ostacolare i discorsi aggressivi veicolati. Parler è stato privato dello spazio per archiviare i dati, e di fatto è stato spento dal colosso di Jeff Bezos. Si è messo in moto un meccanismo a catena. A ruota Apple e Google hanno confermato la rimozione di Parler dai loro store mentre anche Twitch e Snapchat hanno disattivato l'account di Trump. Tutto questo mentre su Youtube, di proprietà di Google, e sul social Reddit continuano a circolare voci di violenza. Un social «punito» dai big del Web potrà comunque rivolgersi a un tribunale e far valere le proprie ragioni: ma nel frattempo è stato silenziato il che equivale, per il popolo del Web, a una condanna a morte.
Quando si dice che Zuckerberg ha il monopolio della Rete, è perché le alternative sono marginali. Gli utenti mensili attivi di Facebook sono 2,6 miliardi. Ogni giorno si collegano a questo social 1,73 miliardi di persone e vi trascorrono in media 58,5 minuti. In Italia lo usano circa 1 italiano su 2. È la piattaforma più popolare con il 60,6% degli utenti Internet. Nonostante diversi forti competitor, come Instagram, Snapchat o Twitter, Facebook resta in testa alle preferenze degli utenti. Nel primo quadrimestre del 2020 ha generato 17,44 miliardi di dollari grazie alle inserzioni.
Uno scossone allo strapotere di Zuckerberg è arrivato negli ultimi giorni quando il magnate ha obbligato gli utenti di Whatsapp a cedere i dati a Facebook contraddicendo quanto aveva assicurato nel momento di acquisire l'applicazione di messaggistica. Chi non accetta le nuove regole della privacy non potrà più usare l'app: inizialmente la scadenza era l'8 febbraio, poi slittata di 3 mesi sotto la pressione delle polemiche. L'operazione consente una maggiore integrazione tra il servizio di messaggistica e la casa madre, con una crescita importante di influenza e di business. Ma per l'utente significa consegnare, per di più gratuitamente, i propri dati a qualcuno che può farne ciò che vuole. Ed esporsi alla possibilità di essere condizionato da chi ha profilato i dati passando ai raggi X abitudini, consumi, salute e orientamento politico. Di fronte a questa ennesima prova di forza, molti utenti hanno lasciato Whatsapp scoprendo chat come Telegram e Signal. In 72 ore, Telegram ha registrato 25 milioni di nuovi iscritti e Signal 7,5 milioni. E la politica, davanti all'avanzata dei nuovi padroni della democrazia e del dibattito pubblico, che fa? Tace.
Boomerang per Facebook e Twitter. Crescono gli iscritti dei concorrenti
Lo strapotere di Facebook, l'indifferenza a qualsiasi regola e la trasmissione di contenuti con forte carica violenta sono da tempo sotto l'attenzione di istituti internazionali. Le Nazioni Unite hanno rilevato l'influenza che il social di Mark Zuckerberg ha avuto in Myanmar come contributo determinante alla diffusione degli attacchi alla minoranza Rohingya. La scorsa estate alcuni investitori pubblicitari di Facebook hanno avviato una campagna dal titolo «Stop hate for profit» in cui si denunciava la piattaforma di avere avuto un ruolo importante nella diffusione di sentimenti razzisti e di incitare alla violenza. Alla campagna è seguita la sospensione degli investimenti pubblicitari da parte di alcuni partecipanti. Chi quindi si arroga il potere di togliere la parola social al presidente degli Stati Uniti perché colpevole di incitare all'odio ha dietro di sé una lunga scia di eventi simili.
Le polemiche che hanno investito Facebook stanno spostando milioni di utenti verso altre piattaforme, oltre a terremotare il titolo a Piazza Affari. Ma probabilmente Zuckerberg lo ha messo in conto, consapevole che la posizione monopolista difficilmente sarà scalfita a meno di un intervento legislativo mirato. Al momento però il presidente eletto Joe Biden non ha inserito questo tema nell'agenda di governo e non ha neppure preso posizione sulle conseguenze che la censura effettuata da Facebook sul suo avversario potrebbe avere per la libertà di opinione.
Alla condanna del bavaglio a Donald Trump si sono aggiunte le critiche per la nuova politica di trattamento dei dati personali decisa da Zuckerberg. Gli utenti di WhatsApp saranno obbligati a condividere le informazioni personali con Facebook. Chi rifiuta sarà tagliato fuori dal sistema di messaggistica. Questo meccanismo pone una serie di interrogativi sull'uso commerciale di tali dati e soprattutto sulla violazione della segretezza.
L'uso autoritario dei social ha scatenato un'ondata di riprovazione di cui si stanno avvantaggiando i competitor di Zuckerberg. Soprattutto quelli che si pongono come un'alternativa in quanto garanti della trasparenza e della sicurezza. Le due applicazioni Telegram e Signal sono state prese d'assalto da milioni di utenti desiderosi di abbandonare Whatsapp. Telegram, sviluppata in Russia, è una realtà consolidata, da tempo in concorrenza con la chat di Zuckerberg. In meno di tre giorni ha conquistato 25 milioni di nuovi utenti e superato i 500 milioni di utenti attivi.
Signal è relativamente più giovane (nata nel 2014) ha guadagnato dal 6 al 10 gennaio circa 7,5 milioni di utenti. Fondamentale è stato l'appoggio esplicito del suo finanziatore Elon Musk, il fondatore di Tesla e SpaceX, che l'ha indicata come la vera alternativa a Whatsapp e la sola in grado di garantire la sicurezza. Gli unici dati degli utenti che vengono conservati sono quelli relativi al momento di creazione dell'account e dell'ultimo accesso. Quindi niente messaggi, foto, posizioni e nemmeno le immagini del profilo. È la chat ideale per chi ha interesse a mantenere riservate le proprie conversazioni. Signal è usata dal Senato americano e dalla Comunità europea nelle comunicazioni interne, ma anche dalla malavita e da chi vuole essere sicuro di non essere tracciato dalla polizia.
Il passaggio da Whatsapp a Signal è veloce e facile purché tutti gli utenti interessati abbiano un account Signal. Funziona come una normale chat, ma i messaggi si possono far scomparire o appena aperti o dopo un certo tempo che va da 5 secondi a una settimana. Difficile prevedere come evolverà il mercato. Al momento i 25 milioni di utenti in più di Telegram e i 7,5 milioni di Signal sono una briciola rispetto agli oltre 2 miliardi di utenti attivi della chat di Zuckerberg. Una breccia è stata aperta nel monopolio di Facebook, la parola ora passa ai governi.