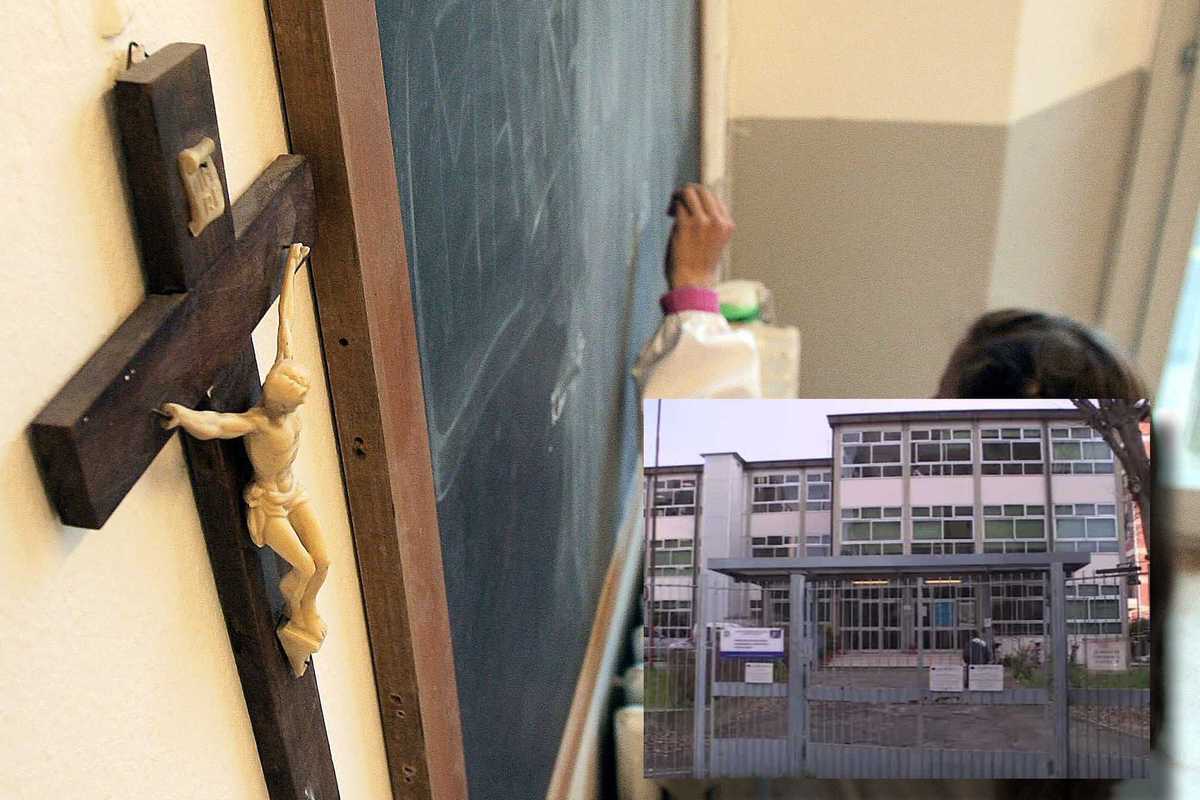Michele Geraci: «Ho voluto io il patto con la Cina. È un modello, ce lo copieranno»

Michele Geraci è sottosegretario allo Sviluppo e gran tessitore dell'intesa che probabilmente sarà siglata tra governo italiano e Cina. Gli estimatori ne sottolineano la competenza. I maligni dicono che ha lavorato più per Pechino che per Roma. Ha accettato con fair play una conversazione senza esclusione di colpi, offrendo la sua versione dei fatti.
Sottosegretario, è preparato per un eventuale tweet di Donald Trump in persona, in cui vi e ci manda tutti a quel paese?
«Non facciamo commenti su tweet provenienti da autorità politiche di altri Paesi. Quando arriveranno, e se arriveranno, risponderemo nel modo opportuno».
Intanto ci hanno «avvisato» il National security council (e non si ricorda una simile uscita verso un Paese amico) e il Segretario di Stato Pompeo. Era necessario prenderci queste rampogne?
«Guardi, siamo sempre stati in contatto con gli alleati americani (tengo a sottolineare: alleati) e anche con i partner Ue. Dopo di che, questa intesa penso faccia parte di ciò che un Paese come l'Italia possa scegliere. Poi gli amici, com'è giusto, possono esprimere dissenso. L'importante è risolvere e chiarire, come stiamo facendo».
La vostra linea di dire agli Usa: «Tranquilli, è solo un accordo commerciale» rischia di sembrare un po' una presa in giro. Come si fa a negare la valenza geopolitica?
«Ha ragione. Però oggi in epoca di globalizzazione si tende sempre a dare una valenza geopolitica anche dove non c'è. I Paesi con cui fai un accordo, i Paesi con cui non ne fai: tutto può essere letto in chiave geopolitica. Ma le ribadisco che per noi la motivazione è esclusivamente commerciale».
Ma sta per arrivare Xi in persona, uno che non si sposta per prendere un caffè. Nella logica cinese, il messaggio a Trump è: «Guarda Donald, sono qui a fare shopping da quelli che ritenevi tuoi amici»
«Attenzione: ci sono 14 Paesi europei che hanno stretto accordi con la Cina e 133 in tutto il mondo. Non c'è un'Europa di serie A e una di serie B».
Ma noi non dovremmo essere quelli più amici di Trump?
«Anche il Portogallo, la Grecia e la Polonia sono ugualmente amici degli Usa. E se l'Europa è una, non dimentichiamoci della Asian infrastructure investment bank (è la mega istituzione finanziaria che Pechino vede come un'alternativa asiatica e sinocentrica rispetto alla Banca mondiale più legata a Washington, ndr) alla quale hanno aderito tutti i paesi dell'Ue, mica solo l'Italia, e la banca è il vero braccio finanziario della Belt and road initiative».
Ma la portata simbolica prevarrà su tutto. Come se Pechino, in mondovisione, dicesse all'Occidente: «Vi ho scippato un membro del G7».
«No, non penso. Quando in Inghilterra è arrivato Xi, allora? Qualcuno ha polemizzato, ma dopo un po' la discussione è finita. Anzi, penso che altri Paesi europei ci seguiranno in questa intesa. Il nostro Mou (Memorandum of understanding, ndr) sarà usato come “template", come modello, dagli altri».
In queste settimane, Trump spera di trovare un compromesso commerciale con Pechino, e lo fa tenendo una linea durissima. Se ci riesce, è cosa buona anche per noi, metterebbe un freno alle pratiche scorrette cinesi. Non valeva la pena di aspettare e dare l'idea di un nostro maggiore gioco di squadra con Washington?
«È normale che questi accordi si firmino quando una visita come quella di Xi è calendarizzata. Dopo di che, è grazie all'Italia che, sia pure in questo momento di incertezza, si sta finalmente iniziando a discutere del tema Cina. Per noi questo è già un risultato positivo».
Le è stata attribuita la frase: «Non siamo noi a essere attratti dall'orbita cinese, ma sono loro che si avvicinano a noi». Non le pare un po' esagerato?
«Mi riferivo agli standard commerciali: con questo MoU portiamo la Cina più vicina al livello europeo».
Luttwak dice che è da analfabeti illudersi che i cinesi importino di più. Vogliono solo esportare.
«Luttwak, che pure rispetto, dovrebbe aggiornarsi. Vede, io ho vissuto molti anni in Cina, non l'ho studiata da lontano ma sul campo: ho insegnato, ho girato, ne ho conosciuto le zone rurali. Oggi esporta - in proporzione al suo Pil - meno dell'Italia. Occorre uscire dalla leggenda secondo cui la loro economia sia basata sull'export: era vero nel 1980, nel 1990, quando la Cina era “piccola" e il mondo era “grande". Ma ora che la Cina è “grande" e il mondo è “piccolo", sanno di aver bisogno delle nostre merci. Hanno bisogno anche di capitale intellettuale, di professori e di studenti, oltre che di prodotti, di made in Italy e moda…».
Veniamo a questo Memorandum. Da una settimana, è tutta una corsa (da Conte a Mattarella, da Salvini a Giorgetti a Di Maio) a circoscriverne la portata. Vi siete spaventati?
«Ma no, la loro è un'operazione per comunicare bene a chi aveva frainteso. E giustamente sottolineano il valore dei paletti, e cioè che l'accordo si firmi solo per aiutare le imprese italiane, e firmiamo solo se non mette a rischio la sicurezza nazionale».
Ma davvero il volume degli accordi è sui 2 miliardi? Per una cifra così piccola scateniamo questo casino?
«Questa cifra non mi risulta: l'accordo non ha una stima quantitativa o un riscontro numerico immediato. È l'inizio di un processo. Semmai le dico che, siccome l'Italia esporta in Cina circa 13 miliardi e la Francia circa 20, a me piacerebbe che l'export italiano arrivasse a quel livello, quindi iniziamo da +7 miliardi».
Dopo molte domande spigolose, ho il dovere di essere fair con lei, e di ricordare che quelli che strepitano - a sinistra - aprirono le porte 5 anni fa a un gigante di stato cinese (China State Grid) nel settore delicatissimo di rete gas e rete elettrica (Cdp Reti). All'epoca c'erano Prodi e Padoan, con Bassanini gran cerimoniere. Non fu una mossa rischiosa pure allora?
«A me in generale non piacciono le acquisizioni di aziende esistenti. Mi piacciano i terreni vergini, i “greenfield", non importa da dove provengano. Punto a situazioni in cui gli investitori aprano nuovi centri di ricerca, assumano ingegneri, i nostri giovani, o - nel caso di un porto - costruiscano un molo che non c'era. Altrimenti, è come nel mercato azionario: un passaggio di azioni e denaro da una mano all'altra senza iniezioni di capitali. Quindi sono scettico rispetto a quel tipo di accordi: non portano grande valore aggiunto ai territori».
Non c'è rischio che la banda larga finisca in quella «scatola»?
«No, voglio rassicurare. Per tutto ciò che ha a che fare con le comunicazioni, abbiamo lo strumento del golden power, con una delle normative più rigorose in Europa».
Torniamo ai porti e ai cinesi. Anche lì, da dichiarazioni di Gentiloni nel 2017, la sinistra c'entra eccome.
«Non faccio polemica sul passato. Però il tema non è la vendita, e meno che mai la svendita, dei porti: vorremmo che i cinesi mettessero mano al portafogli e investissero».
Diciamolo, la sinistra ha praticato un fastidioso doppio standard.
«Forse perché allora erano al governo e ora no. Devono sempre essere in disaccordo con qualcuno, visto che non gli basta esserlo con sé stessi».
Ha sentito ciò che hanno detto Pompeo e Marquis, e cioè che materiale Usa sensibile potrebbe non arrivare più nei porti italiani?
«Beh, la Cina ha già il 35% del porto di Rotterdam, e poi il Pireo, e investimenti a Zerbrugge, Malta, Le Havre, Bilbao. Ha già il 15% della capacità portuale europea».
Appunto, il problema è questo. Anche Giorgetti ammette che la Cina vuole occupare i porti europei.
«La preoccupazione ce l'ho anch'io. Ma non è che possiamo preoccuparci solo quando la cosa riguarda l'Italia».
Ma Giorgetti lo vogliamo rassicurare?
«Giorgetti ha ragione. Staremo attenti a che gli investimenti cinesi o di altri Paesi non abbiano carattere predatorio».
Parliamo di lei. Nel 2008 si è trasferito in Cina. Quando si chiuderà la sua esperienza politica, conta di tornare lì?
«Le rispondo con la citazione del fisico danese Niels Bohr: “È molto difficile fare previsioni, specie riguardo al futuro"».
Cosa risponde a chi dice che lei ha lavorato più per Pechino che per Roma? Sono malignità?
«È una falsità. Ho lavorato per 20 anni a Londra, ho studiato in America che mi ha dato tanto, e “solo" 10 anni in Cina: quindi due terzi a Londra, e un terzo in Cina. E poi io sono della Lega, sovranista, “prima gli italiani". Sono tornato per aiutare il nostro Paese».
E a chi dice che, pur indicato dalla Lega, ora lei sia più vicino a Di Maio?
«Fake news. Certo, ci frequentiamo: lavoriamo nello stesso edificio. Ma sarebbe come dire che, siccome Salvini vede spesso Di Maio, allora è passato ai 5 stelle. Non ha proprio senso».
E a chi dice che, nel famigerato viaggio con Di Maio a Pechino (quello del caso mediatico che si scatenò sul volo economy), vi impegnaste senza che altri membri del governo fossero ben consapevoli della portata dell'operazione?
«Ma no, siamo ben coordinati a tutti i livelli, il governo è compatto. E abbiamo agito in accordo con tutti i ministeri. Lo testimonia la lettera di Di Maio a tutti i ministri per costituire una “task force Cina" già a settembre, uno strumento per informare e aiutare le aziende italiane su opportunità di fare business in Cina, che ho l'onore di coordinare ».
Ultima cosa. Si hanno notizie del ministero degli Esteri, che dovrebbe essere competente su questa materia? O è sede vacante?
«Il ministero degli Esteri è il soggetto decisionale finale su questo MoU. Noi diamo l'input, e loro decidono. Siamo in contatto costante».