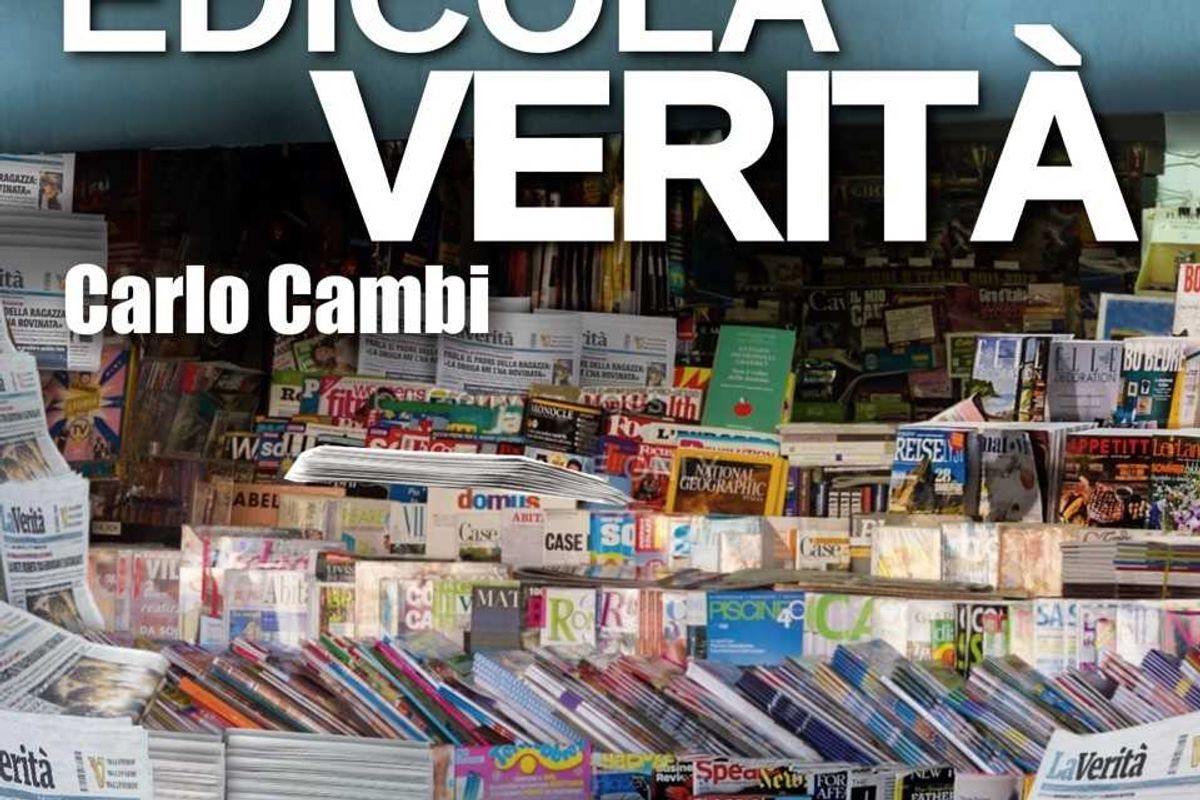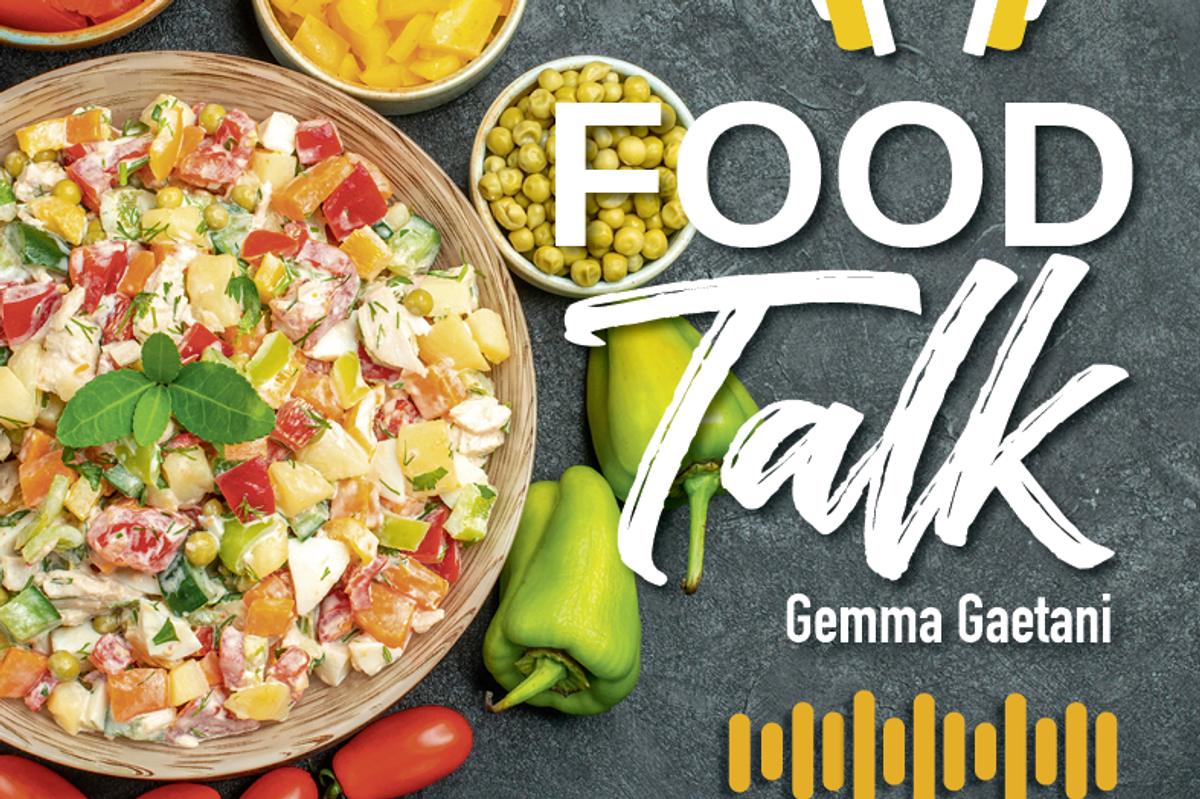«La lezione dimenticata di Silvestrov: i russi e gli ucraini sono nati fratelli»

Che suono ha il silenzio? Meglio sventolare bandiera bianca che provare a rispondere a parole. Ancora meglio chiedere consiglio a 12 arie di ingannevole semplicità, al pianoforte di Hélène Grimaud e alla voce del baritono tedesco-romeno Konstantin Krimmel. È appena uscito infatti (per Deutsche Grammophon) l’ultimo album della pianista francese, che esplora le Silent Songs di Valentin Silvestrov.
Stiamo parlando del più grande compositore ucraino vivente, rifugiatosi a Berlino a 85 anni, a causa dell’invasione russa. Ma chi volesse pensar male - immaginando scaltre operazioni di marketing - stavolta farebbe davvero peccato: il colpo di fulmine tra la Grimaud e il mondo sonoro di Silvestrov non è recente. Una notevole mole di concerti e il disco del 2020 (The Messenger), che affiancava brani strumentali di Wolfgang Amadeus Mozart a quelli del compositore di Kiev, spazzano via ogni dubbio. Proprio quell’abbinamento inconsueto aggiunge un’altra tessera al mosaico: «Non scrivo nuova musica», ha più volte spiegato il maestro, «ma una risposta a ciò che già esiste e ne è un’eco». Una concezione che fa intuire lo spirito di queste canzoni, che appartengono alla seconda vita dell’artista. Se il primo Silvestrov era infatti un pezzo grosso dell’avanguardia sovietica (un ascolto della Sinfonia n.1 rende l’idea), dalle Silent Songs in poi (eseguite per la prima volta a Kiev nel 1977 e - altri tempi! - nel 1985 a Mosca) l’autore ucraino torna alla melodia, alla tonalità e ai materiali primari (in estrema sintesi al minimalismo, senza evocare certo minimo sindacale musicale che va forte negli aeroporti).
Per quanto riguarda Hélène Grimaud, invece, non basterebbe un libro per raccontarla. Tanto è vero che pure lei ne ha già scritti tre (Variazioni selvagge, Lezioni private e Ritorno a Salem, edizioni Bollati Boringhieri), senza esaurire l’argomento. Alcuni flash: indomabile fin dall’infanzia, trascorsa come in gabbia ad Aix-en-Provence - quando solo il pianoforte riusciva a incanalare il suo bisogno di superare i limiti del corpo («sognavo di straripare», scrive) - da musicista affermata ha avuto un rapporto burrascoso con l’accademia e con alcuni mostri sacri come Daniel Barenboim e Claudio Abbado. Le sue scelte radicali - a volte incomprensibili da fuori - seguono una bussola interiore: la certezza quasi fanatica che «si deve diventare ciò che si è», al di là di quello che pensa il mondo («Non mi avranno», è la citazione preferita del compaesano Paul Cézanne). L’esempio più eclatante? Abbandonare tutto per andare a vivere con i lupi in una distesa gelata e selvaggia come South Salem (New York). Ma di questo parliamo dopo.
Per la prima incisione della sua carriera, a 15 anni, ha voluto a tutti costi Rachmaninoff. Con Brahms ha un legame viscerale, nei confronti di Bach quasi una devozione. Silvestrov invece come l’ha scoperto?
«Si è trattato di un incontro fortunato, avvenuto circa 20 anni fa, grazie a un regalo di compleanno. Il dono di Mainfred Eicher (patron della Ecm, ndr) era proprio un album con le Silent Songs. E sono stata immediatamente trafitta. La musica di oggi - mi son detta meravigliata - è ancora in grado di stabilire una connessione profonda con l’anima, riscoprendo la melodia e l’armonia. Ho avvertito una grande purezza e un’estrema varietà di colori. Come un sussurro capace di arrivare direttamente al cuore, senza bisogno d’altro».
Cosa intende dire?
«Ricordo di aver inserito il cd nel lettore senza avere la minima idea di ciò che avrei ascoltato. Solo alla fine ho divorato i testi, le traduzioni, la storia del compositore... Ma più mi informavo e più capivo che la musica aveva già espresso tutto nella sua forma più vera. Ogni dato intellettuale era superfluo».
L’autore definisce queste canzoni «silenzio messo in musica». Nel suo primo libro lei scrive: «La musica si è impadronita di me perché è l’estensione del silenzio. Una via d’accesso a un altrove della parola, a quello che la parola non può dire e che il silenzio, tacendolo, dice». Coincidenze?
«Il silenzio mi ha sempre affascinato, è alla base di tutto. Senza di esso non saremmo nemmeno in grado di distinguere i suoni. È lo spazio all’interno della musica, ma ne è anche la sua fonte primordiale. E non si tratta solo di assenza di suono: pensiamo a quegli attimi magici in teatro, a quanto il silenzio possa diventare pregnante…».
Se Silvestrov concepisce la sua produzione artistica come eco di qualcos’altro, cosa risuona in queste arie? I lied di Schubert o di Brahms, l’essenzialità di Arvo Pärt?
«Il legame con i giganti che hanno portato questa forma ai suoi massimi livelli c’è, anche se trascende il linguaggio: direi, la musica che diventa espressione poetica. Per quanto riguarda Pärt, trovo in Silvestrov la stessa profondità e lo stesso senso del mistero. A livello personale, incidere le opere di questi due artisti prodigiosi, potendomi confrontare con loro, è stato un immenso privilegio».
Prova la stessa attrazione anche per il Silvestrov degli inizi, quello legato all’avanguardia?
«Credo che la decostruzione degli elementi sia stata una parte inevitabile del processo che lo ha condotto al punto in cui si trova ora. Nel suo linguaggio apparentemente semplice oggi infatti c’è qualcosa di estremamente avanzato. Il ritorno alle radici e ai materiali primari di Silvestrov sembrerebbe - come in Pärt - un viaggio all’indietro. In realtà è grazie alla sua onestà, e a questa trasparenza faticosamente conquistata, che oggi riesce a parlare alle persone così nel profondo».
Un’altra nota molto presente nelle pagine del maestro di Kiev è quella del dolore.
«È così. La sua scrittura lascia trasparire una ferita profonda, esistenziale. Fin da subito ho percepito quella che io chiamo l’adrenalina della sofferenza. I segni sono impressi nella sua esperienza umana, dalle tribolazioni ai tempi dell’Unione sovietica, alla morte della moglie Larissa…».
Oggi a questi tormenti si aggiunge la tragedia della guerra. Fa un certo effetto ascoltare la musica del più grande compositore ucraino vivente che ridona vita alle poesie del padre della letteratura russa, Aleksandr Puškin, e a quelli di altri suoi connazionali.
«Dialogando con Silvestrov colpisce che continui, anche in queste ore terribili, a sottolineare l’importanza della cultura russa e di quella ucraina. E il fatto che i due popoli siano sempre stati fratelli. Ovviamente giudica inaccettabile e terribile l’invasione di Vladimir Putin, ma è convinto che l’arte non debba essere trascinata in questa catastrofe, causata dalla follia del potere».
La stessa lucidità è mancata all’Occidente, che troppo spesso ha considerato tutti gli artisti russi servi del Cremlino, fino a prova contraria. Arrivando persino alla folle censura di Ciajkovskij e Dostoevskij. Sembra incredibile, ma il sovrintendente del Teatro alla Scala, Dominique Meyer, ha dovuto spiegare la differenza tra Puškin e Putin per difendere il Boris Godunov...
«C’è un’ipocrisia inaccettabile. Non mi risulta che i politici occidentali, che fino al giorno prima dell’invasione avevano fatto accordi con lo zar, abbiano dovuto dimettersi in massa o siano stati screditati com’è accaduto invece ai musicisti che in Russia hanno famiglie, parenti, amici... Qual è la loro colpa? Questa caccia alle streghe è un insulto all’umanità e alla cultura. Condannare l’invasione russa è sacrosanto. Cancellare la storia, l’arte e l’anima di un popolo non ha alcun senso».
I versi di Puškin trasformati in musica da Silvestrov sono un inno alla speranza in un momento in cui nessuno crede più nemmeno al cessate il fuoco?
«Teniamola viva la speranza, è l’unico modo di onorare le vite che abbiamo perso».
Prima di lasciarci, le chiedo un ricordo di Claudio Abbado. Qualche anno prima della morte del maestro, a quanto si è detto, il vostro sodalizio artistico si ruppe per un diverbio su una cadenza di Mozart.
«Il fatto che le nostre strade si siano divise dopo un percorso artistico così intenso ha più a che fare con la natura umana che con la musica. Si tratta di circostanze inevitabili che non toglieranno nulla alla bellezza che abbiamo condiviso. Restano le tracce (alcune incise, altre no) di quegli anni, dei quali sarò sempre grata».
Prima che nascessero i social e che si riempissero di paladini dell’ambiente a colpi di like, lei ha comprato una tenuta immensa in mezzo al nulla ed è andata a viverci con i lupi. Ha trasportato carriole piene di terra (a dir poco inusuale per una pianista), ha modificato le pendenze del terreno, ha piantato alberi. Oggi vive sull’altra costa degli Stati Uniti ma quella casa è ancora lì e si chiama New York Wolf Center. Guardandosi indietro, perché l’ha fatto?
«I lupi mi hanno insegnato l’amore incondizionato e la disciplina: non puoi entrare in rapporto con loro se non sei al cento per cento presente nell’istante. Ed è un insegnamento fondamentale anche per la musica. Il mio impegno per la loro salvaguardia, che è cruciale per l’equilibrio del pianeta, è rimasto lo stesso, anche se posso vederli meno frequentemente. Con gli anni ho imparato a essere meno radicale, per comunicare meglio con chi ha opinioni diverse. La mia sfida è, come diciamo in Francia, mettre de l’eau dans son vin senza perdere lo sguardo che avevo da bambina».