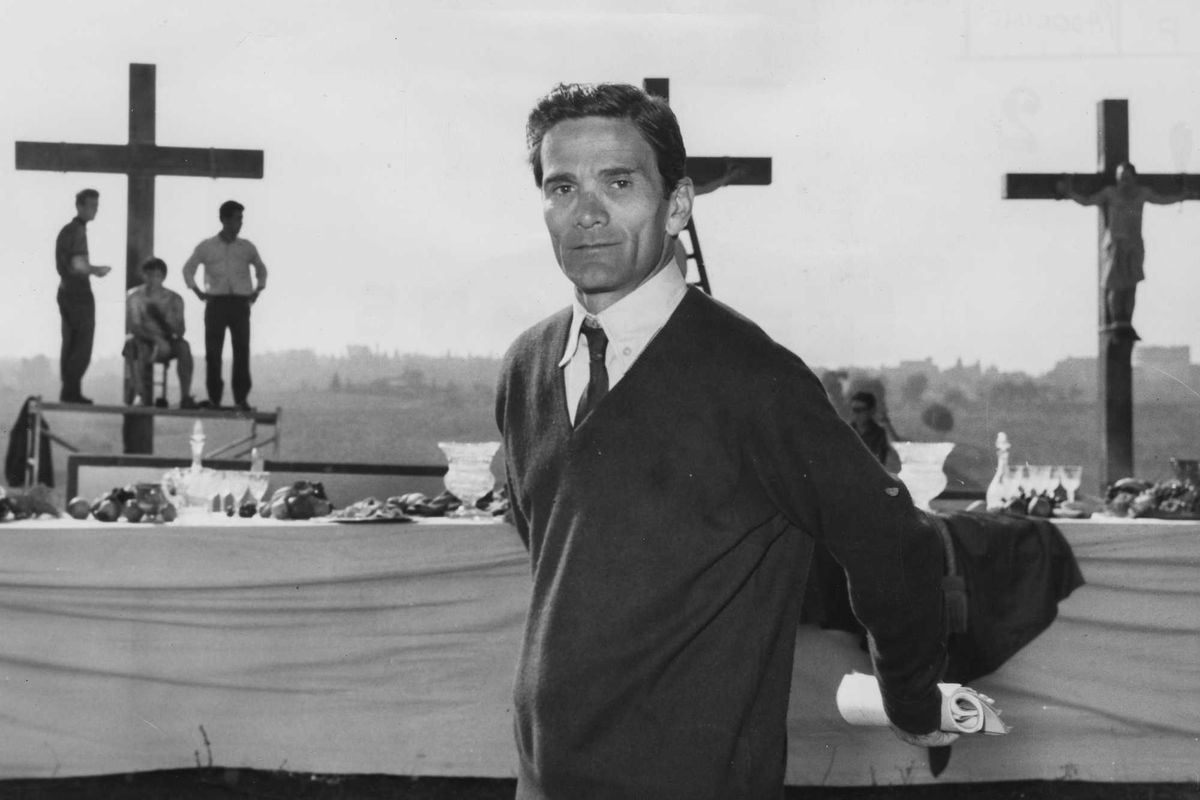2021-03-07
Giardino Valsanzibio, l’eden degli uomini alla continua ricerca di un mondo perfetto
Giardino Valsanzibio (Wikipedia)
Nelle campagne a Sud di Padova uno splendore creato dai nobili veneziani Barbarigo come voto per essere scampati alla pesteUna traccia, o forse sarebbe meglio dire, una radice della cultura quattro e cinquecentesca ha impresso un modo di approcciarsi alla conoscenza totalizzante, nel quale cultura e vita reale non sono separate, distinte, così come avviene al contrario oggi. Discutendo con autori, poeti, pittori, video artisti, molti si pongono l’obiettivo non tanto di fare il proprio meglio, di vivere l’arte in quanto uomini o donne, ma in quanto artisti che lasciano, necessariamente, un segno, un solco nella Storia con la esse maiuscola. Non ci importa della persona, ci importa soltanto dell’opera d’arte, dicono. Quante volte l’ho sentito ripetere. Sinceramente non li capisco, cari miei, non vi capisco: come potete pensare che la vita sia inferiore all’arte? Come potete credere che Gandhi sia stato meno importante delle sue idee e delle sue azioni politiche e civili? Come potete credere che Michelangelo Merisi da Caravaggio, Leonardo Da Vinci, o Umberto Saba, La Monte Young, Dante Alighieri siano stati al limite insignificanti rispetto a quel che hanno scolpito, disegnato, poetato o composto? Una visione così declassata e presuntuosa dell’uomo rispetto all’artista, ovvero di colui o di colei che giacciono al di sopra dell’umana media, si sarebbe semplicemente guadagnata lo scherno dell’uomo di lettere e arti rinascimentale. Ogni essere umano è la complessità, è l’ampiezza, è la persona in todo che conta, che va coltivata, che matura conoscenza ed esperienza. Ecco perché s’immaginavano, quando la cultura era una ricerca costante, in ogni direzione, tanti viaggi di formazione, ecco perché si andava da un mondo all’altro, dal reale all’ipotetico, all’onirico al mistico, e si ritornava «aumentati», come diremo attualmente, esposti al sacro, all’infinito, al finito che tenta la fusione col mai finito. E i giardini che per secoli sono stati spettacolari marchingegni di giochi d’acqua, musica, sorprese architettoniche, stupefazioni artigianali, grotte ricoperte di spugne strappate ai fondali dei mari, sculture classiche e monumentali, finte cascate dipinte o scroscianti, visi di animali che sputano zampilli, e piramidi, archi, finte o vere rovine antiche, scene mitologiche, tentativi di trasformazione. Spettacolari mondi perfetti catapultati in paesaggi sempre più vasti e geometrici, e così, dalle minime dimensioni dei giardini pensili, dei giardini all’italiana, dei giardini alla francese si è abbracciato il mondo là fuori proiettando luci e rette, guadagnando prospettive sempre più remote, inventando il giardino all’inglese che ha superato confini, ha occupato campagne, ha eroso natura naturans, spontanea, eterna, rigeneratrice infinita ed emanazione prima del divino principio, e modellato natura naturata, ovvero natura prodotta, seminata, camuffata, abbozzata, ammaestrata, antropica. Ma queste categorie spinoziane sono ancora valide? Non sempre lo credo.Il giardino dunque formativo, educativo, concepito dall’architetto, dal proprietario, dalle mani di coloro che lo realizzano, quale viaggio esplorativo. In Italia conserviamo ancora giardini simili, si pensi ad esempio a quel che resta delle ville di Tivoli, alla via d’acque della Reggia di Caserta, allo splendido Bosco Sacro di Bomarzo, e forse ancor meglio al giardino monumentale di Valsanzibio, nelle piane campagne a sud di Padova, oltre il castello di Battaglia Terme, alla fine di una lunga strada accompagnata da un inesausto filare di alberi. Ci siete mai stati? Consiglio di pianificare una visita nell’estate che ci attende, quando probabilmente la presa della pandemia sarà più debole. Chi arriva nell’abitato di Galzignano Terme, comune di 4.300 abitanti, non può immaginare che alla fine, alla base di due colline circondate dai boschi, si presenti una facciata monumentale, un portale del tempo in marmo che accoglie il turista dei nostri anni così come il viaggiatore ardito di due o tre secoli addietro. Al tempo qui si arrivava addirittura in chiatta, magari dopo esser partiti in battello dalla laguna veneziana, così come facevano i membri della famiglia che questo angolo di paradiso avevano voluto e finanziato, i Barbarigo, ereditando un possedimento ameno che era stato già dei Contarini e prima ancora degli Scrovegni. Qui si navigava fra acquitrini, sostituiti da campi, canali, caseggiati e cascinali. La storia ha inizio nelle stagioni dolorose della peste nera che decima l’Europa e la città a forma di pesce, Venezia. Francesco Zuane Barbarigo fa un voto: se i suoi cari supereranno incolumi l’epidemia realizzeranno qualcosa di importante e così è, si avviano i lavori di costruzione di una grande villa alla veneziana, non dimentichiamo che la famiglia dei Barbarigo possedeva un magnifico edificio con affaccio sul Canal Grande, a Dorsoduro; affida ad un artista visionario il concepimento di un giardino magnifico, Luigi Bernini, fontaniere vaticano e fratello del più celebre Gian Lorenzo. Fra il 1665 e la fine del secolo vengono realizzati il giardino e l’edificio, per un’estensione totale di dieci ettari, otto e mezzo del giardino e uno e mezzo del bosco circostante. Il monumentale Portale di Diana ci accoglie proprio come trecento anni fa, dominato da Artemide o Diana, la dea della caccia, protettrice di questa come di altre residenze agresti in giro per le campagne italiane, non diversamente ad esempio avveniva per talune residenze signorili di Casa Savoia. L’acqua inizia così un pellegrinaggio nelle peschiere alle spalle del portale, costellate di simboli mitologici, i fiumi, i venti, Mercurio e Giove o Ercole e Apollo. Il decumano tracciato dalla via d’acqua interseca la Prospettiva del Cardo, costeggiata e protetta da alte pareti vegetali fino alla facciata della villa.Finita la prima purificazione dell’anima che dal mondo esterno ha fatto ingresso in questo luogo di delizie, di riposo e rigenerazione, si inizia la vera e propria immersione spirituale, visitando l’arboreto, attraversando un magnifico labirinto, fra i meglio conservati d’Italia, quindi la grotta dell’eremita, luogo di riposo e contemplazione, l’isola dei conigli, la vita che ritorna dopo la meditazione; una statua di Cronos, il Tempo, solitaria, sostiene sopra il peso di un dodecaedro che simboleggia i dodici mesi; in mano tiene una clessidra. Alfine si supera una scalinata con un sonetto scolpito sui gradini: «Curioso viator che in questa parte / Giungi e credi mirar vaghezze rare / Quanto di bel, quanto di buon qui appare / Tutto deesi a Natura e nulla ad Arte […] Qui non ha loco il Pianto, ha sede il Riso, / Della Corte il fulmine qui non s’ode / Ivi è l’Inferno e qui il Paradiso». A Venezia, la città tentacolare, il bordello, il triste inferno, l’immondo gioco di potere, e qui, a Valsanzibio, l’eden degli uomini, un paradiso in terra, luogo dunque di pace e purificazione.
Nel riquadro la produttrice Giulia Maria Belluco (iStock)
Gaia Zazzaretti prima e dopo il vaccino (iStock)