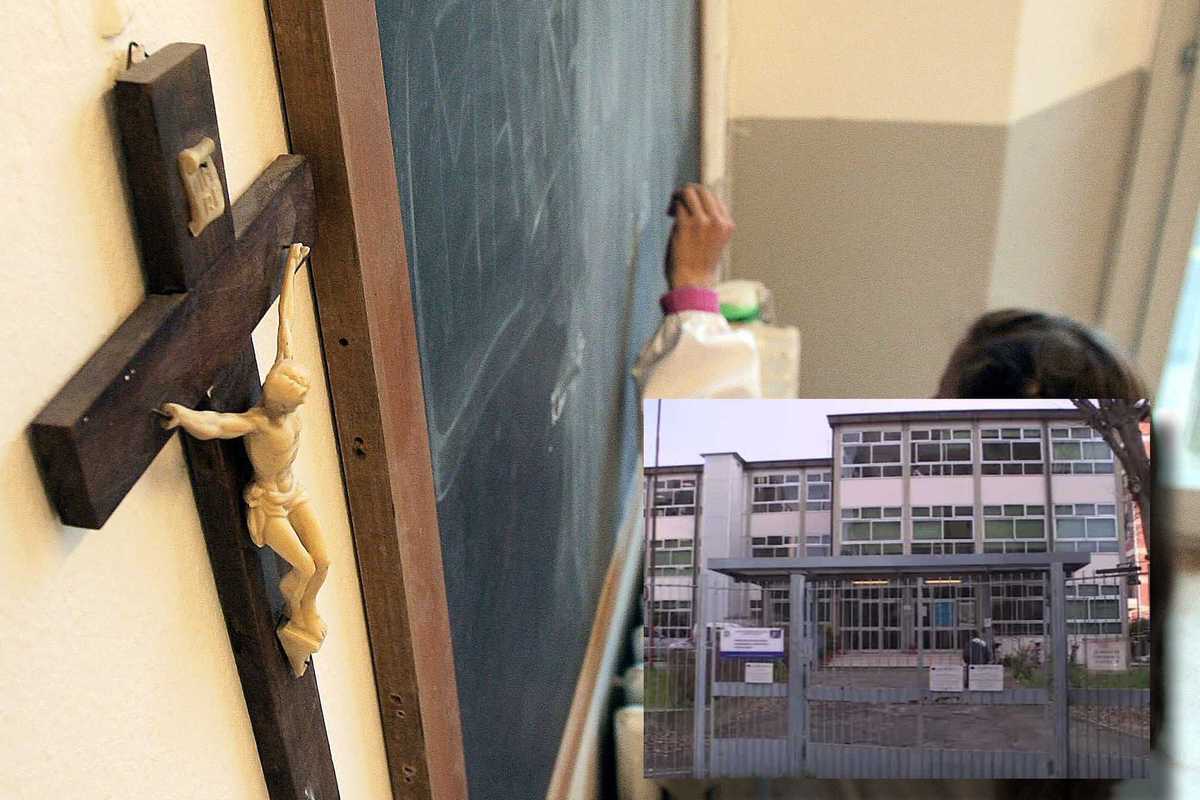In Germania salta il gigante immobiliare. Rischio contagio del settore bancario

- Secondo indiscrezioni sarebbe esposta pure Unicredit. La crisi spiega il pressing sull’Italia per la ratifica della riforma del Mes.
- Il produttore tedesco di motorini elettrici Unu ha depositato domanda di insolvenza: costi troppo alti e poca domanda. Intanto da noi lascia il servizio di sharing Cityscoot.
Lo speciale contiene due articoli.
Quando sabato abbiamo titolato che «servono soldi per il salva banche, ecco perché hanno fretta sul Mes» avevamo fatto un ragionamento in una prospettiva di medio periodo. I timori sollevati dalla Bce sulla bolla immobiliare nel Nord Europa (Germania in testa) erano là a ricordarci che le banche più esposte in quel settore avrebbero potuto avere difficoltà e quindi richiedere l’intervento del Fondo per la gestione delle crisi bancarie (Srf) che avrebbe potuto a sua volta avere bisogno del puntello del Mes (riformato).
Non è la prima volta che anche le nostre ipotesi più ardite vengono confermate dalla realtà, ma non immaginavamo che accadesse così in fretta. Infatti, venerdì scorso una società del gruppo immobiliare Signa controllato dal magnate austriaco René Benko ha presentato istanza di fallimento presso il Tribunale di Berlino e si teme che proprio oggi altre società del gruppo potrebbero fare altrettanto. Sono quelle dove è concentrata l’attività immobiliare, mentre la società berlinese è una scatola pressoché vuota, occupandosi solo dei servizi di progettazione e sviluppo. Parliamo di un gruppo societario estremamente articolato che è stato protagonista delle maggiori operazioni di sviluppo immobiliare negli ultimi anni in Germania e, da ultimo, sta costruendo ad Amburgo l’Elbtower, un grattacielo dalla forma avveniristica alto 254 metri. A Benko piace vantarsi che solo la Chiesa cattolica e la Casa reale inglese possiedono immobili comparabili per pregio e collocazione. Le attività del gruppo sono pari a 27 miliardi - tra cui la catena di grandi magazzini Selfridges a Londra, il Chrysler building a New York e il Kadewe a Berlino - ma se in pochi giorni non trova almeno 600 milioni di liquidità aggiuntiva rischia il collasso totale.
Un evento gravido di conseguenze sotto diversi aspetti, perché l’esposizione totale di Signa verso i creditori è pari a circa 13 miliardi, secondo una ricostruzione di Bloomberg. Benko è riuscito ad attrarre capitale azionario dai più blasonati e potenti gruppi imprenditoriali europei, come ad esempio la famiglia Peugeot che detiene il 4,6% di una società del gruppo. Investitori che hanno creduto ciecamente nelle sue iniziative, al punto da sottoscrivere un recente aumento di capitale per 1 miliardo.
Ma dopo gli azionisti, ci sono le banche, la cui esposizione verso Signa lascia intendere che la lezione della crisi 2008-2009 non sia stata sufficiente. La banca svizzera Julius Baer è esposta per circa 600 milioni, che però costituiscono ben il 40% del portafoglio crediti più rischiosi. Una concentrazione inaudita. Secondo indiscrezioni non confermate, Unicredit e l’austriaca Raffeisen bank international sarebbero esposte per circa 1,5 miliardi, di cui 755 milioni attribuiti a quest’ultima. Poi seguono tre Landesbanken come Helaba, Nordlb e Bayernlb (banche regionali di proprietà pubblica situate nelle ricche regioni della Baviera e dell’Assia) a cui Bloomberg attribuisce un’esposizione che si misura in centinaia di milioni. Le quotazioni dei bond sono già ridotte a poche decine di centesimi.
Benko sta manovrando da alcune settimane per trovare soci disposti a finanziarlo e già all’inizio del mese ha ceduto l’11,5% delle sue azioni al gruppo svizzero guidato da Arthur Eugster (macchine da caffè). Da ultimo, si parla di trattative in corso anche col gruppo americano Elliot management di Paul Singer e altri fondi arabi. Per contribuire alla causa, è in vendita anche il mega yacht Roma di 62 metri per la «modica» cifra di 40 milioni. In ogni caso una goccia d’acqua nel mare dei debiti.
Signa è l’ennesimo classico esempio di crescita finanziata a debito finita in difficoltà. La duplice tenaglia costituita da un lato dall’aumento dei tassi di interesse e, dall’altro, dall’aumento dei costi di costruzione (materie prime in particolare) ha in breve tempo ridotto in carta straccia i business plan del magnate austriaco. I suoi progetti erano fondati su un fondamentale assunto: che i valori degli immobili crescessero sempre. Ma 450 punti di aumento dei tassi in 12 mesi sono stati il pungiglione che ha fatto scoppiare la bolla.
Il caso Signa - i cui effetti sul sistema bancario potrebbero ancora essere contenuti - costituisce però il primo (importante) scricchiolio in un settore che è già sotto i riflettori della Bce. Risale infatti a martedì scorso un intervento del membro del comitato direttivo, Isabel Schnabel, all’università di Würzburg in cui è stato posto l’accento sulla repentina crescita dei prezzi degli immobili residenziali in Olanda, Germania e Francia. Rispetto al dicembre 2019, in Germania l’aumento è arrivato poco sopra il 30%, per attestarsi attualmente ancora al di sopra del 20%. In Italia siamo inchiodati intorno al 5%. Se le difficoltà di Signa dovessero allargarsi a macchia d’olio a tutto il settore, coinvolgerebbero un quinto del Pil tedesco e un decimo dei posti di lavoro. E la prospettiva, avanzata sabato su queste colonne, di un rapido coinvolgimento del Srf diventerebbe concreta. Con la conseguenza che saranno i contributi delle nostre banche a quel fondo a salvare quelle tedesche e austriache e i contributi della Repubblica italiana al Mes (14 miliardi) a consentirgli di erogare quel prestito paracadute al Srf per non farlo restare a secco. Dopo 12 anni, «Fate presto» potrebbe essere il titolo di qualche quotidiano tedesco per chiedere la ratifica della riforma del trattato del Mes.
Crac anche degli scooter verdi Unu
Con l’aumento dei costi delle materie prime e dell’energia, la mobilità elettrica diventa sempre meno sostenibile. A saltare, ad esempio, venerdì scorso è stato il produttore tedesco di scooter elettrici Unu, che ha presentato istanza di fallimento al tribunale distrettuale di Berlino Charlottenburg. «Le ragioni dell’insolvenza sono l’aumento dei costi dei materiali e dei trasporti, i maggiori costi operativi e il forte calo della domanda dovuto all’inflazione», ha dichiarato l’azienda. Le operazioni commerciali continueranno nell’ambito della procedura di insolvenza. Nel frattempo, la compagnia sta cercando di ristrutturarsi.
Il gruppo tedesco è stato fondato dieci anni fa nella capitale e aveva circa 50 dipendenti. Unu commercializzava i suoi ciclomotori a batteria in Germania, Francia, Austria e Paesi Bassi. Certo, i problemi negli anni non sono mancati. Nel corso della pandemia, la compagnia ha dichiarato di aver dovuto interrompere la produzione per diversi mesi. Successivamente sono arrivati i problemi di fornitura dei chip e, più di recente, la scarsa fiducia dei consumatori ha causato non pochi problemi ai fornitori.
«Nel 2023, l’azienda ha rinnovato radicalmente l’abbonamento agli scooter e ha anche ampliato la sua presenza offline con partner di vendita al dettaglio», ha spiegato in una nota Unu. «Per questo motivo, vediamo buone possibilità di raggiungere una soluzione di riorganizzazione e di continuare la vendita e l’assistenza degli scooter», ha concluso il curatore fallimentare Gordon Geiser.
Del resto, quella di Unu è solo l’ultima caduta nel mondo della mobilità elettrica. La settimana scorsa ha abbassato la serranda in Italia Cityscoot, piattaforma francese di scooter sharing che operava in diverse città italiane. Già in passato l’azienda aveva smesso di operare a Roma e di recente ha comunicato l’interruzione del servizio anche a Torino e Milano.
«Nonostante i nostri numerosi sforzi per restare aperti, le nostre energie non sono bastate», ha reso noto l’azienda in un comunicato. «Pertanto, con estremo rammarico, siamo costretti a sospendere il servizio a Torino e a Milano dal 30 novembre a tempo indeterminato. Abbiamo un solo obiettivo: tornare. Faremo tutto il possibile per mantenere questa promessa», fa sapere ancora la società. «Se hai minuti accreditati sul tuo conto, potrai utilizzarli fino al 30 novembre compreso. Vi ringraziamo per la fiducia accordataci in tutti questi anni. Siamo particolarmente orgogliosi di aver potuto contribuire fattivamente a questa piccola rivoluzione che è la mobilità dolce nelle nostre città. Dal 2018 Cityscoot Italia ha gestito più di 3 milioni di viaggi per un totale di 150.000 utenti e 12 milioni di chilometri percorsi», ha concluso il gruppo.
Cityscoot ora è stata posta in amministrazione controllata e sta cercando nuovi investitori. La società francese, che nel Paese vanta 168 dipendenti, è alla ricerca di «partner finanziari per cambiare il suo modello economico e implementare la sua nuova flotta di scooter» meno costosi da gestire, a partire dal 2024.
Fatto sta che la mobilità elettrica si sta dimostrando sempre più difficoltosa sotto il profilo finanziario. In Italia, prima di Cityscoot hanno messo in pausa il servizio di scooter in condivisione Zig Zag e Acciona. Persino i grandi nomi dell’automotive come Daimler e Bmw che avevano iniziato il loro servizio di car sharing con Car2go e Drive now ci hanno rinunciato, prima fondendo i due servizi in Sharenow per poi cedere tutto a Stellantis nel 2022 all’interno del servizio Free2move.
Per non parlare, poi, dei 20 operatori di monopattini in condivisione che erano sul mercato prima del Covid e che oggi sono solo sette anche per motivi regolamentari e di sicurezza.