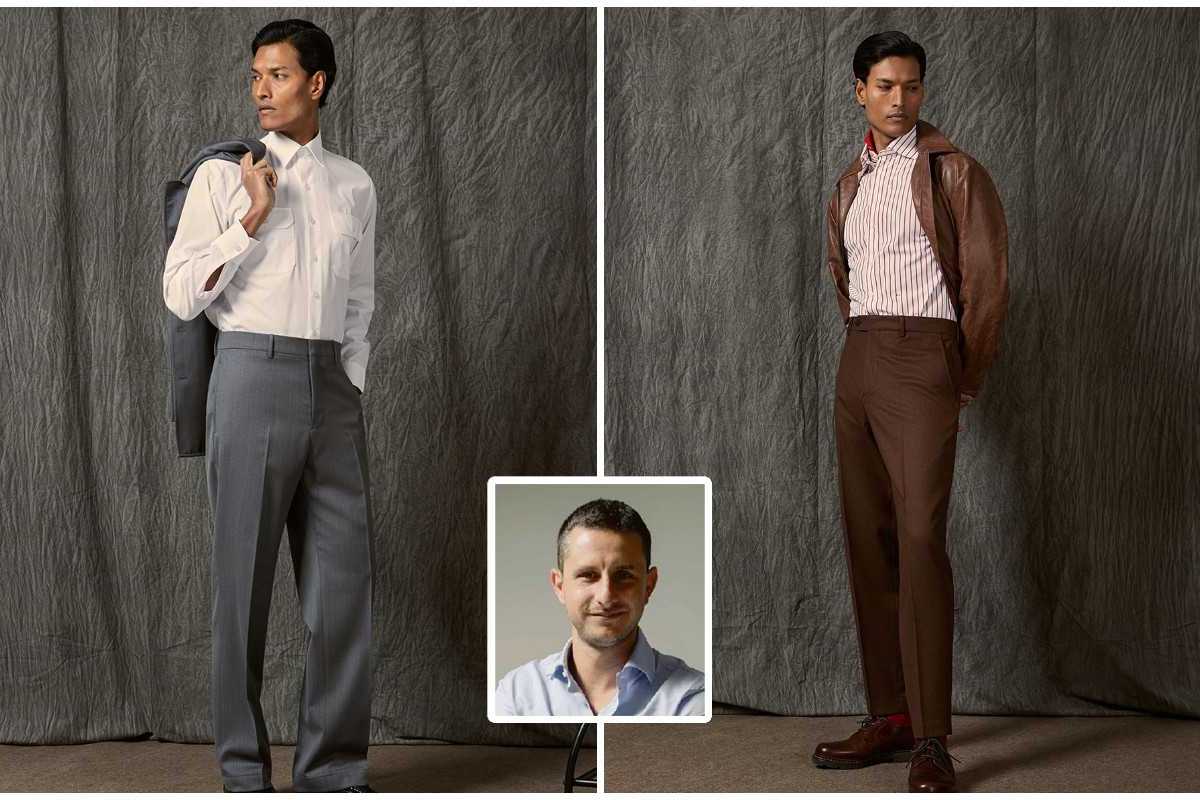Viaggio quaresimale tra antichi, ma sempre attuali e buoni, piatti di magro. Partiamo da Cetara dove opera Pasquale Torrente, uno dei cuochi più celebri d’Italia. Cetara, piccolo reame marinaro della Costiera Amalfitana, è celebre per la produzione della colatura di alici, salsa che ricorda il garum di Marco Gavio Apicio, collega di Torrente di un paio di migliaia d’anni fa. Nato Torrente, Pasquale è diventato mare. Sulla Costiera c’è nato, cresciuto, ha un ristorante, Al Convento, che è diventato un punto di riferimento mondiale per la cucina di pesce.
Il pesce, soprattutto quello azzurro del suo Tirreno, non ha segreti per lui. Tanto è vero che Pasquale alle alici parla, anzi, sussurra. Cosa bisbigli nelle loro minuscole branchie non è un segreto. Lo ha scritto qualche anno fa nel libro: L’uomo che sussurra alle alici. Racconti di vita e di cucina nel quale Pasquale Torrente confida episodi della sua vita e propone 32 ricette al lettore affamato di apprendere l’abc di alici, acciughe e parenti vari e di come cuocerli. Ecco una sua facile ricetta per santificare uno dei nostri giorni d’astinenza È vero che le gioie più grandi della quaresima sono quelle spirituali, ma per i bravi credenti è ammessa anche qualche piccola gioia per il palato. Se poi è procacciata da un pesce povero e ricco di omega 3, non può far che bene ai penitenti: più che un peccatuccio di gola è un fioretto.
Spaghetti con colatura tradizionale di alici di Cetrara. Ingredienti per quattro persone: 400 gr. di spaghetti; colatura di alici tradizionale di Cetara (si trova in molti supermercati e in internet); uno spicchio d’aglio; prezzemolo q.b.; peperoncino piccante q.b.; olio extravegine di oliva q.b. Mettere in una insalatiera l’aglio, il prezzemolo e il peperoncino tritati; con olio extravergine di oliva e un mestolo di acqua di cottura. Cuocere la pasta in acqua senza sale alla fine aggiustare con colatura di alici.
Rimaniamo in Campania spostandoci a Napoli dove sulle mense di magro trionfa la frittata di scammaro. È un piatto povero. I giorni dello scammaro, o scammaru, nel Regno delle Due Sicilie, erano quelli della quaresima e quelli in cui, ci si doveva astenere dalle carni per precetto religioso. Vietate anche le uova, concesse dalla Chiesa solo all’inizio del Novecento. Si chiama frittata perché deriva da quella dei maccheroni, assai più ricca e grassa. Nello scammaro si versa la pasta (vermicelli, spaghetti, maccheroni) in una padella nella quale è stato preparato un soffritto con olio, aglio, acciughe, uvetta, pinoli, olive denocciolate e prezzemolo.
È la ricetta classica creata da Ippolito Cavalcanti, duca di Buonvicino, nel 1837. A lui che aveva fama di essere un gastronomo avveduto (scrisse un libro in dialetto napoletano sulla vera cucina casareccia partenopea) si rivolsero alcuni importanti porporati del regno borbonico preoccupati che il periodo penitenziale che precede la Pasqua non fosse contaminato dai piaceri della carne. E siccome l’unico alimento di provenienza animale che il popolo poteva permettersi erano le uova, i porporati suggerirono al Cavalcanti di toglierle dalla popolare frittata di maccheroni. Cosa che Ippolito fece, ma con maestria, dando sapore allo scammaro. Oggidì che non comandano più i Borboni, e quasi più nessuno osserva i precetti quaresimali o i giorni di magro, a Napoli, la frittata di scammaro, viene preparata con le uova, il pomodoro, la pancetta, il prosciutto, il formaggio o con qualsiasi altro ingrediente si desidera. È diventata una sorta di pizza quattro stagioni.
In Veneto fino al boom economico i tradizionali cibi della quaresima erano la renga (aringa), lo scopeton (sardella), le rane e il baccalà. A Parona, alla periferia di Verona il mercoledì delle Ceneri, primo giorno di quaresima la Festa di Polenta e Renga richiama migliaia di gioiosi penitenti. In Emilia Romagna i tradizionali cappelletti perdono la farcitura di carne e sono promossi alla quaresima con un ripieno di raviggiolo (formaggio fresco) e un condimento di burro, salvia e parmigiano eggiano. Alla faccia dell’astinenza. Sugli Appennini sopravvive la tradizionale buzega, zuppa di fagioli, castagne secche, patate, cipolle e passata di pomodoro. Anche Pellegrino Artusi si era preoccupato di suggerire ne La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene gli Spaghetti da Quaresima (ricetta 103) conditi con zucchero, noci, pan grattato e spezie: «Molti leggendo questa ricetta diranno: Oh che ridicola. Eppure a me non dispiace».
Il Concilio Vaticano II cancella molte limitazioni nei giorni di magro, ma sono in molti a rispettare le regole, più quelle dell’astinenza dalle carni che del digiuno al quale viene messo un limite d’età, come ai film: possono parteciparvi dai 18 anni ai 60 anni.
La Toscana per la quaresima, fa molto uso di zuppe vegetali. A Lucca l’Accademia della zuppa lucchese di magro ha varato un disciplinare più rigido dell’Accademia militare di Modena. Specifica quali sono le erbe selvatiche da raccogliere, quali fagioli da usare: borlotti e rossi di Lucca, quando vadano messi in ammollo e quando ci devono stare. Naturalmente ci vuole olio d’oliva buono e croste di pane. Ottima anche la minestra di pane pratese. Tradizionale a Firenze è il pane di ramerino (rosmarino), un dolce di farina, olio, rosmarino, uva passa carico di valori simbolici legati al Giovedì Santo. Paolo Petroni, presidente dell’Accademia italiana della cucina detta la ricetta originale ne Il libro della vera cucina fiorentina.
Piatto antico, ma sempre moderno è il cappon magro ligure, ammesso in quaresima perché fatto solo con verdure e pesce. Anticamente era un piatto povero, consumato dai pescatori in barca con i pesci meno pregiati, poi, con il passare del tempo è diventato il piatto più sontuoso della cucina ligure. Cibi magri sono, ovviamente, pane, legumi, frutta e verdura e il pesce sul quale, però, si è giocato e si gioca tuttora la differenza di ricchezza e di classe sociale. I poveri che non si possono permettere pesci costosi si devono accontentare di aringhe e, di stoccafisso. L’aristocrazia e la borghesia, fin dal medioevo possono gettare le reti su pesci costosi e rari: salmoni, anguille, crostacei, storioni, branzini. Molto ricercati erano i carpioni del lago di Garda, oggi quasi scomparsi. Molto interessante la spesa di quaresima del 1492 di Isabella d’Este, marchesa di Mantova: «Pesi octo de tonina (tonno in salamoia) in tre barili; barilotti cinque de angiove (acciughe); arenghe salate 200 (pesce povero, ma piaceva anche ai richi); tarantello pexi 3 (pancetta di tonno); boteselle quatro de cerioli (piccole anguille); barilli dui de cevali grossi (cefali); pesso di sfoglia pexi 1 (sogliola)...».
Chi fa le regole, papi e vescovi, è capace di fare anche le eccezioni. E così non tutta la carne è... carne. Monsignor di Saint Sinon, vescovo di Agda, in una lettera pastorale del 1784 decreta cibi magri gli uccelli da quaresima, quelli che vivono nell’acqua e si nutrono di pesci: alzavole, anatre acquatiche, folaghe. A differenza della carne, rossa a sangue caldo, gli uccelli da quaresima sono freddi. Come i pesci, Quindi magri. Ci fu anche chi tentò di far passare per pesce l’oca, ma senza riuscirci.
Pio V goloso di chiocciole che non erano né carne né pesce, nella seconda metà del Cinquecento per poterle gustare anche nelle giornate di penitenza e in quaresima, non sapendo sotto quale categoria di alimenti appartenessero, le dichiarò pesci per l’eternità: «Estote pisces in aeternum». E così le povere chiocchiole non ebbero pace nemmeno per Pasqua.