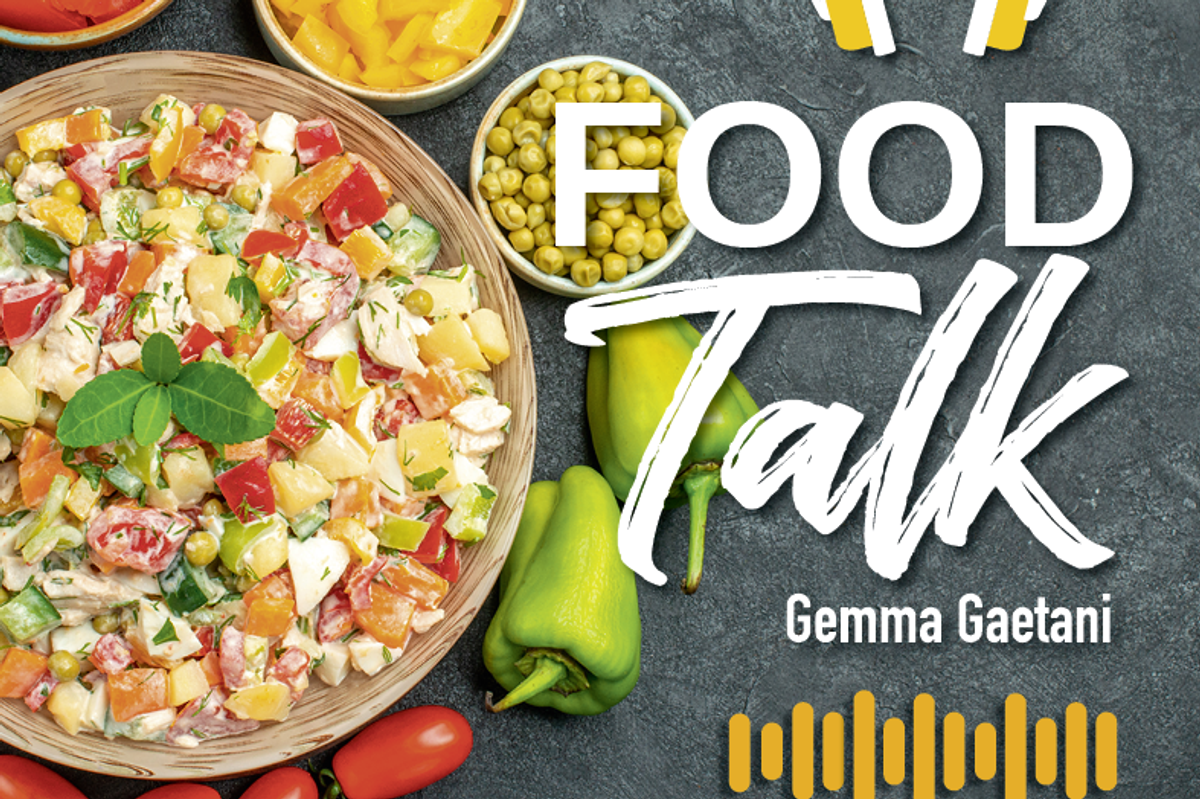«Quello che va bene alla Fiat va bene all’Italia». Un’affermazione che viene attribuita a Enrico Cuccia, fondatore di Mediobanca e per una quarantina d’anni nume protettore della casa automobilistica torinese. Una stampella non certo a buon mercato. Federcontribuenti stima che dai primi anni Settanta fino al 2012 lo Stato ha erogato al gruppo torinese contributi, sussidi e vantaggi fiscali per l’equivalente di 220 miliardi di euro. Nel calcolo sono compresi prepensionamenti, cassa integrazione, rottamazioni, costruzione, in alcune regioni, di nuovi stabilimenti. Nonostante l’ampiezza della piattaforma finanziaria di riferimento resta il dubbio di un conteggio approssimato per difetto. Alcuni valori, infatti, sono difficilissimi da contabilizzare. Per esempio la vendita dell’Alfa Romeo nel novembre 1986.
La Fiat intervenne all’ultimo momento per bloccare l’avanzata della Ford che intendeva provare per la seconda volta lo sbarco in Italia dopo l’alt imposto dal Duce su ispirazione del vecchio Senatore Agnelli. La proposta della casa americana non è mai stata pubblicata in tutti i dettagli. Si conosce solo la busta della Fiat che si dichiarò pronta a coprire i 700 miliardi di lire di debito e versare mille miliardi di lire in comode rate da 200 milioni a partire dal 1992.
Il pagamento, però, era sottoposto a diversi vincoli per cui, secondo la Commissione europea alla fine la spesa fu solo di 389 miliardi di lire. Tanto per capire i valori in campo basterà ricordare che Ferdinand Piech, gran capo della Volkswagen nel 2011 si fece avanti con Sergio Marchionne per rilevare il marchio pagando 1 miliardo di euro. Duemila miliardi di vecchie lire tanto per capire. Certo erano passati 25 anni. Tuttavia varrà la pena ricordare che fra il 1986 e il 2011 l’Alfa si è mantenuta lontana dal record di vendita (200.000 auto dopo la nascita dell’Alfasud) e dai target indicati dall’avvocato Agnelli al momento dell’acquisto (350.000). Ma soprattutto dagli ambiziosissimi traguardi immaginati da Marchionne (500.000 auto l’anno). Il super-manager italo-canadese forse di auto non capiva molto. Ma era ferratissimo nella finanza ed era un uomo d’onore come la Borsa avrà più volte modo di apprezzare. Basti ricordare l’abilità di acquistare Chrysler senza un soldo e, soprattutto la capacità di valorizzare il patrimonio Fiat. La Ferrari diventata il titolo più capitalizzato della Borsa di Milano è una sua magia avendone intuito il valore scorporandola dal resto del gruppo. Marchionne ha un altro merito immenso. Forse il più grande di tutti: è stato l’unico capo della Fiat a rifiutare aiuti pubblici. Di questa eccezione era orgoglioso. Una postura eretta che gli ha consentito di affrontare senza condizionamenti la Fiom di Maurizio Landini che si opponeva a qualunque forma di modernizzazione degli stabilimenti. Per fortuna Marchionne ha avuto ragione altrimenti anche Pomigliano e Melfi oggi sarebbero a rischio. Sia chiaro un concetto: che sostegni e incentivi pubblici vengano concessi a imprese che rappresentano posti di lavoro e producono Pil è più che ragionevole. Anzi doveroso in anni come gli attuali in cui la concorrenza estera è cresciuta in modo esponenziale soprattutto grazie agli aiuti di Stato elargiti da Paesi come Germania, Francia e Spagna. Per non parlare ovviamente della Cina. A maggior ragione se i contributi erano diretti a un gruppo come la Fiat che a un certo punto della sua storia dava lavoro a 190.000 dipendenti (oltre a un indotto almeno doppio), produceva in 188 stabilimenti ed esportava made in Italy in almeno 50 paesi. Mirafiori, negli anni Settanta, occupava cinquantamila persone distribuiti nei vari turni di lavoro. Era l’impianto industriale più grande del mondo prologo del gigantismo cinese o sud-coreano.
Il problema della Fiat, e quindi della dinastia Agnelli, non consiste tanto nel fiume di denaro pubblico che ha ricevuto ma nell’uso che ne ha fatto. Quando Gianni Agnelli nel 1966 sostituì Vittorio Valletta era in piena salute. Aveva motorizzato il Paese negli anni del boom e rivaleggiava con Volkswagen come primo produttore di auto in Europa. Dieci anni dopo il sogno era finito, complice lo choc petrolifero provocato dal conflitto arabo-israeliano. Enrico Cuccia era riuscito a portare nel capitale della Fiat un socio pubblico. Ma non era lo Stato italiano a investire bensì la Libia di Gheddafi: per 415 miliardi di dollari aveva preso il 10% del gruppo torinese. Non si può certo dire che fu un cattivo affare: dieci anni dopo, nel 1986, quelle azioni furono vendute portando a casa 2,6 miliardi di dollari. Ma torniamo ai supporti dello Stato.
L’ultimo è stato la maxi linea di credito da 6,3 miliardi concessa dal secondo governo Conte tramite Intesa Sanpaolo con garanzia Sace a Fca Italy nel 2020, durante la pandemia, per «preservare e rafforzare la filiera automotive italiana». Il prestito è stato restituito in anticipo da Stellantis nel 2022, ma la produzione non è ancora tornata ai livelli pre-Covid, mentre dal 2021 il gruppo ha lasciato a casa quasi 8.000 lavoratori.