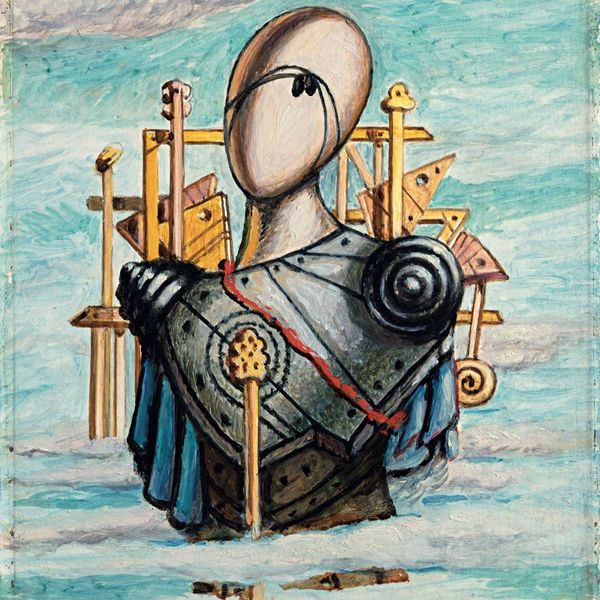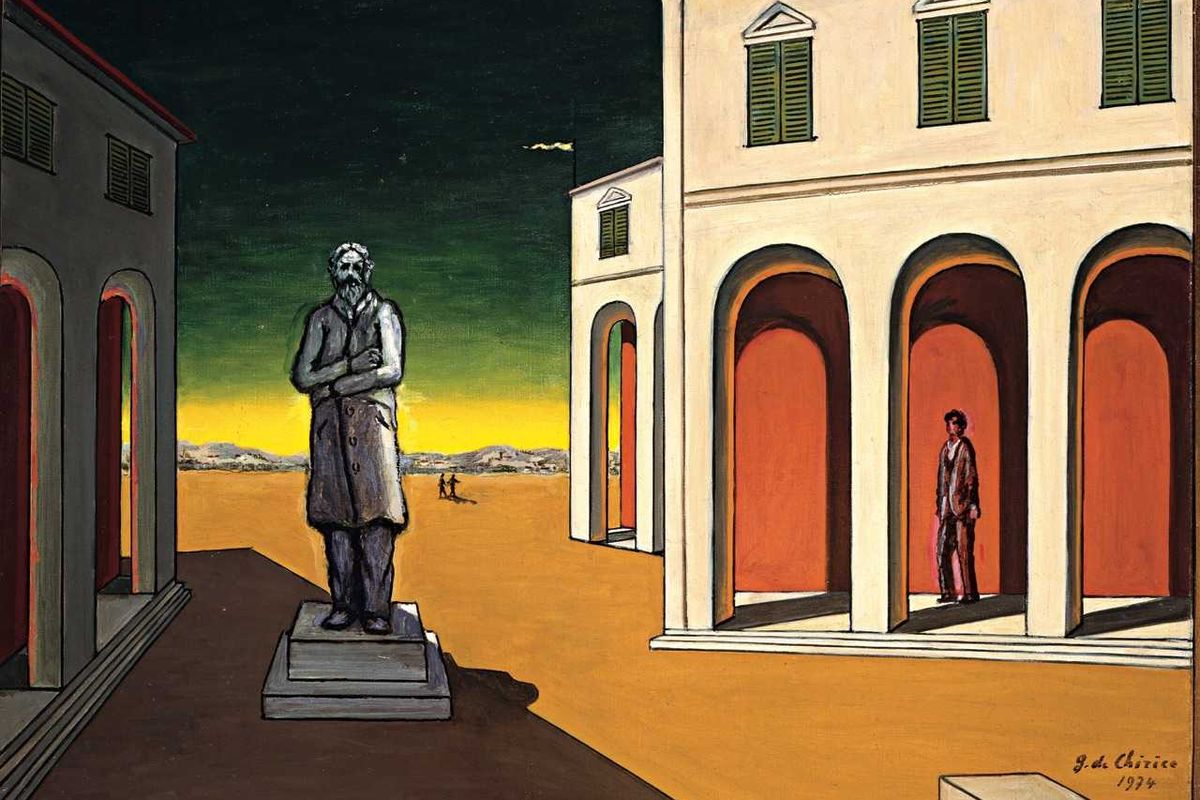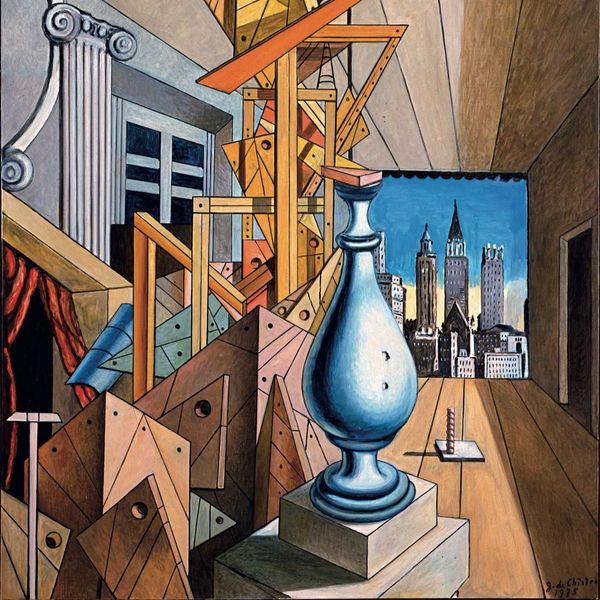Eutanasia al cinema: dal film di Goebbels alla dolce poetica di Paolo Sorrentino

Dal dramma propagandistico nazista del 1941, alla riflessione poetica di Paolo Sorrentino nel 2025: potremmo intitolare così quanto si sta vivendo al Festival del Cinema di Venezia, in corso, ove si propone, a distanza di più di ottant’anni, il delicatissimo tema - con risvolti morali, filosofici, sociali, religiosi - della morte legalmente provocata: eutanasia. In questi giorni, molti critici cinematografici presentano il nuovo film di Paolo Sorrentino, «La Grazia», come un’opera unica, capace di affrontare con coraggio e sensibilità un tema tanto complesso e delicato. In realtà, nel 1941, diretto da Wolfgang Liebeneiner, e prodotto con il forte sostegno del Ministero della Propaganda - con a capo Paul Joseph Goebbels, braccio destro di Adolf Hitler - uscì il film «Ich klage an», «Io accuso», che affrontò proprio il tema eutanasico ed innescò un fortissimo dibattito pubblico sulla «pietà». La trama si dipana attorno a Hanna Heyt, una pianista affetta da sclerosi multipla, e suo marito, Thomas Heyt, medico. La donna chiede al marito di porre fine alle sue sofferenze: un gesto che l’uomo compie somministrandole un farmaco letale. All’apertura del processo, con toni drammatici, il medico viene accusato di omicidio. Il cuore del film è la sua arringa finale, che diventa un inno alla «pietà» come giustificazione dell’eutanasia. Al termine della proiezione, il pubblico veniva invitato ad esprimere un giudizio: un vero e proprio «sondaggio», ante litteram. La netta maggioranza si espresse a favore del medico, opponendosi fermamente alla sua condanna. Il film, venne premiato alla Biennale di Venezia e divenne non solo un successo artistico, ma anche (e soprattutto) un potente strumento di manipolazione dell’opinione pubblica, aprendo la strada alla legittimazione del programma eutanasico nazista, tragicamente passato alla storia come «Aktion T4». Dietro la patina melodrammatica e giudiziaria - strumento vincente per catturare il consenso popolare - si celava un preciso intento ideologico: sdoganare il naturale stigma sociale contro la morte provocata, a vantaggio di una condotta omicida intrisa di mal intesa «pietà». Non è un caso che il «burattinaio» di tutto, fosse Joseph Goebbels, ministro sia della cultura che della propaganda nazista, che sfruttò - con drammatica scaltrezza - quanto era accaduto due anni prima. In Sassonia, nel 1939, nasceva Gerhard Kretschmar, neonato cieco e gravemente malformato. I genitori chiesero che venisse soppresso, invocando la pietà. La richiesta coinvolse l’intera popolazione tedesca, tanto da giungere fino all’attenzione di Adolf Hitler, che autorizzò il suo medico personale, Karl Brandt, a supervisionare l’atto di soppressione del bimbo con un’iniezione letale. Questo evento, noto come «il caso del bambino K», è storicamente considerato l’antesignano del programma Aktion T4. Ottant’anni dopo, l’ottimo regista Paolo Sorrentino, porta a Venezia il film «La Grazia». Il film racconta il dilemma di un presidente della Repubblica (Tony Servillo) chiamato a decidere su una legge a favore dell’eutanasia, con la concessione di due atti di grazia. Sorrentino sceglie la via della poesia, da una parte, e del dubbio, dall’altra. Scene ironiche si intrecciano con momenti surreali, simbolismi visivi, riflessioni profonde sulla responsabilità politica ed etica della decisione. Al di là della critica artistica e dell’esito del Festival, alla luce del dibattito in corso nella nostra nazione sul tema del suicidio assistito - no, sì, Parlamento, Consulta, «male minore», ecc… - è opportuna una riflessione, partendo dai fatti: due film, due epoche certamente molto diverse, ma la stessa drammatica tentazione, quella di legittimare la «morte pietosa», spianando la strada al consenso sociale. 1941 «Ich Klage An», film elegante, ricco di pathos, ottimamente confezionato, premiato dalla giuria. 2025, «La Grazia», film raffinato, con toni spirituali, accattivante, che suscita il dubbio, ma alla fine decide a favore della «normalizzazione» del fatto eutanasico. Non si può non scorgere, sul piano culturale e sociale, una continuità evidente, senza fare processi alle intenzioni (o meglio: alle intenzioni di Sorrentino, non certo di Goebbels!): dietro la retorica della pietà, si nasconde il rischio (la volontà?) di aprire la porta alla eliminazione della vita fragile e alla cultura dello scarto, quella delle «vite indegne di essere vissute». Il cinema, potente strumento che attraverso l’emozione è in grado di plasmare le coscienze, diventa così un forte mezzo di persuasione, neppure tanto occulta. E quando la persuasione tocca il tema del «senso della vita», il dramma anti-umano è dietro l’angolo. Occorre prendere posizione: non dalla parte della retorica della pietà, ma dalla parte degli ultimi, dei più fragili, di coloro che rischiano di essere considerati un «peso» sociale insopportabile. Il compito della cultura, e quindi di ogni espressione artistica, compreso il cinema, non può essere quello di legittimare la morte provocata, ma ricordarci che il vero parametro di misura di una società civile è la «cura», quella che sappiamo avere e dare ai più deboli.