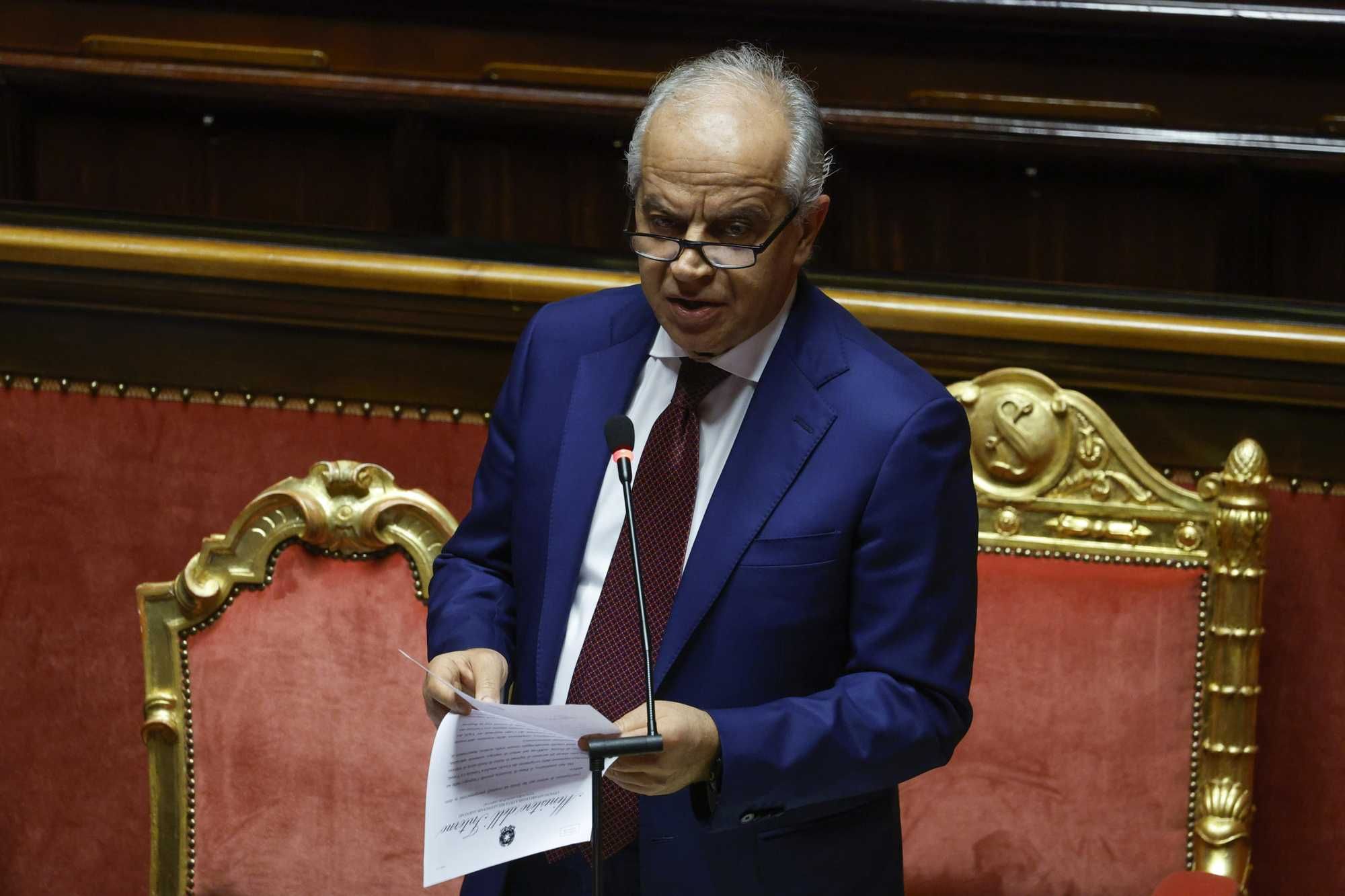Toscana, Umbria e Lazio: sono tre le regioni in cui l’affascinante popolo etrusco proliferò, lasciandoci testimonianze di inestimabile valore. Ecco un viaggio, conciso e ricco allo stesso tempo, attraverso 4 delle 12 città etrusche: Chiusi, Veio, Tarquinia e Vulci.
Lo speciale contiene un articolo e quattro approfondimenti.
Che fossero di origine autoctona, turca o addirittura svizzero-austriaca (queste le tre ipotesi più accreditate), poco importa: il mistero che circonda la cultura degli Etruschi fa sì che un viaggio tra città e borghi da essi fondati abbia un sapore particolare, fatto più di domande che di risposte certe.
Una delle poche cose che sappiamo è che fondamentale fu il contatto con i Fenici e soprattutto con i Greci. Gli Etruschi, infatti, costituirono 12 città-Stato sul modello delle poleis greche e oggi possiamo ammirarle in tutta la loro bellezza, per quanto modificata dal passare dei secoli: Populonia, Tarquinia, Arezzo, Cerveteri, Chiusi, Vulci, Roselle, Veio, Orvieto, Perugia, Vetulonia e Volterra.
Volendo seguire come cani da tartufo le tracce di questo popolo, potremmo anche spingerci in Emilia Romagna e persino sulle coste corse, perché gli Etruschi, per via dei loro mercati fiorenti, ebbero rapporti anche al di fuori dei confini della penisola italica.
In effetti, pur non affacciando direttamente sul mare – posizionate com’erano nell’entroterra e solitamente in cima a delle alture - alcune di queste città erano dotate di porti efficientissimi. Oggi stupisce sapere che località vacanziere come Ladispoli – conosciuta per le spiagge, i locali e i ristoranti – fossero porti etruschi.
Visitare l’Etruria significa scoprire zone dalle grandi bellezze storico-naturalistiche, alcune delle quali ancora poco conosciute, borghi dai colori scuri dovuti alla presenza del tufo, necropoli praticamente intatte, opere d’arte disseminate tra musei e parchi archeologici.
Ciò che non possiamo vedere, purtroppo, sono i templi, simili a quelli greci ma – purtroppo per noi – costruiti in legno e, perciò, non sopravvissuti. In alcuni casi, come per esempio a Veio, sono rimasti i basamenti in pietra: il resto venne devastato dai Romani, che conquistarono l’Etruria come sapevano fare loro, cioè tramite razzie e incendi.
Quello che possiamo ancora osservare, almeno in larga parte, sono le mura ciclopiche. A Fiesole (FI), per esempio, sono ancora visibili, anche grazie al fatto che i Romani le rafforzarono e ampliarono a loro uso e consumo. Altre mura ciclopiche di origine etrusca si trovano a Cortona (AR), anche se della struttura difensiva originaria rimane poco: troppe le modifiche prima romane e poi medievali/medicee.
Altre rimanenze etrusche sono le porte d’ingresso alle città, come quella di Volterra (Porta all’Arco). Nella loro semplicità, sono ancora in grado di colpire il visitatore: non bisogna essere grandi amanti della storia per rendersi conto della preziosità di queste testimonianze, nonché della maestria architettonica e ingegneristica di un popolo vissuto tra il IX e il I secolo a.C.
I siti meglio conservati sono comunque le necropoli, questo anche grazie al culto dei morti. Gli Etruschi, infatti, credevano fortemente nell’aldilà. Tantissime le suppellettili e gli arredi arrivati fino a noi, che ci parlano sia delle loro credenze che della loro arte. Il monumento più rappresentativo di ciò è sicuramente il Sarcofago degli Sposi, conservato nel Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, a Roma.
Alcune necropoli sono così ben conservate da essere diventate patrimonio Unesco. Si pensi a Tarquinia e Cerveteri. Si tratta di due vere e proprie cittadelle, con tanto di strade, trincee e persino piazze. Per noi hanno il valore di due immense enciclopedie: essendoci rimasto poco di questo popolo, tutto ciò che è contenuto all’interno delle necropoli ha lo stesso peso delle testimonianze scritte, se non di più. Anche i dipinti parietali sono come testimoni sopravvissuti all’oblio del tempo, istantanee di vita quotidiana che ci parlano direttamente dai muri delle città mortuarie.
Quelle che seguono sono solo 4 delle 12 città etrusche. Molto ci sarebbe ancora da dire, ma per un viaggio conciso e ricco allo stesso tempo abbiamo dovuto fare una piccola selezione tra quelle che amiamo di più.
Chiusi

iStock
Bandiera arancione del Touring Club Italiano, Chiusi è una cittadina del Senese, ubicata in posizione fortunatissima: si trova infatti in piena Valdichiana, a due passi dalla Val d’Orcia e, dotata di stazione ferroviaria, è il punto d’approdo dei turisti non automuniti che vogliono visitare questa zona del Senese.
Passeggiando nel centro storico non si possono non notare le fortificazioni e Porta Lavinia, testimonianze vive della civiltà etrusca. Ma il centro storico val bene una visita anche per il bel Duomo, il Museo Nazionale d’Arte Medievale e Moderna (con opere di celeberrimi artisti, come il Vasari) e la medievale Chiesa di San Francesco.
La parte più bella è sotterranea: nel sottosuolo si trova infatti una serie di stretti cunicoli scavati nel tufo dagli Etruschi, che ospitano cisterne, urne e tegole funerarie e persino un laghetto. Bellissimo anche il Labirinto di Porsenna, che si trova proprio sotto la cattedrale. È infatti dall’annesso museo che vi si accede. Qui si dice che venne sepolto il re etrusco Porsenna, ma fonti più pragmatiche lo descrivono come un sistema per l’approvvigionamento idrico della città etrusca.
Assolutamente da non perdere il Museo Etrusco, molto ben organizzato (si può chiedere un tablet all’ingresso, che fornisce tutte le informazioni sui reperti qui esposti). È anche possibile pagare il biglietto per la visita cumulativa al museo e alle tombe etrusche, che si trovano poco oltre le mura cittadine.
Gli amanti della natura potranno trovare ristoro al Lago di Chiusi. Protetto dal WWF, ospita specie ornitologiche quali l’airone rosso e il falco pescatore. Da esplorare o a piedi, in bicicletta o in barca.
Dormire a Chiusi
- La Piccola Locanda, Via Leonardo Da Vinci 26: affittacamere con ristorante al piano terra;
- Agriturismo Macciangrosso Casale Piccolomini, Località Macciangrosso: immerso nella natura e dotato di piscina.
Mangiare a Chiusi
- La Solita Zuppa, Via Porsenna 21: ristorante tipico, famoso per le zuppe;
- Il Grillo è Buoncantore, Piazza XX Settembre 10: prodotti a km 0 di ottima qualità;
- Ristorante Pape Nero, Piazza del Teatro 1: da provare i pici con sugo toscano.
Veio

iStock
Veio è un’altra perla forse poco conosciuta da chi non vive nei pressi di Roma. Si trova infatti vicino a Isola Farnese, a una quindicina di chilometri dalla capitale. Patria etrusca prima e romana poi, venne definitivamente abbandonata nel IV secolo a.C.
Anche qui la natura abbonda: Veio è un’area naturale protetta ed è il quarto parco laziale per estensione, tanto da comprendere ben 9 comuni.
Il monumento etrusco più importante è il Santuario di Portonaccio, dedicato alla dea Minerva; qui venne ritrovata la famosa statua in terracotta di Apollo, oggi conservata nel Museo Nazionale di Villa Giulia. Il santuario di Campetti, dedicato alla dea Veii, diede invece il nome alla città.
A Veio si possono anche visitare le necropoli, all’interno delle quali spiccano le Tombe delle Anatre e dei Leoni Ruggenti, chiamate così per i dipinti che le decorano.
Il Ponte Sodo, infine, è una galleria che serviva a far defluire il fiume Cremera durante le piene, a dimostrazione dell’abilità ingegneristica di questo popolo.
E proprio l’acqua è l’elemento preponderante all’interno del Parco di Veio: la Mola di Isola Farnese è un vecchio mulino che funzionava grazie al Fosso Piordo, di cui ora possiamo ammirare la piccola ma suggestiva cascata. Dall’altro lato del ponte si trova una cascata “vera”, che cade da un’altezza di 10 metri.
Per raggiungere Veio, bisogna prendere l’uscita Fiano Romano (A1) e la direzione Capena-Morlupo. Se si viene da sud, invece, le uscite possibili dal G.R.A. sono tre: Flaminia, Cassia Veientana o Cassia.
Dormire
- B&B Parco di Veio, Via del Praticello Alto 40, Formello: gentilezza, tranquillità e colazione ottima;
- Antica Pietrata B&B, Via della Pietrara 4, Formello: bellissima location. Buono anche il ristorante.
Mangiare
- Hostaria La Cerquetta, Via Enrico Bassano 54/56, Roma: famoso per la carne;
- Ara Bracis, Via Cassia 1837, Roma: anche qui è d’obbligo assaggiare la carne;
- Antico Mulino a Vejo, Via Riserva Campetti, Isola Farnese: location da sogno e cucina ricercata.
Tarquinia

iStock
Tarquinia è una gran bella cittadina in provincia di Viterbo. Sono due i motivi che spingono a visitarla: gli Etruschi e il mare. La sua vicinanza a Roma, inoltre, la rende una meta particolarmente appetibile.
Prima ancora di visitare la sua necropoli, è nel borgo che vanno ricercate le testimonianze della civiltà etrusca. A partire da Palazzo Vitelleschi, dove si trova il Museo Nazionale Etrusco di Tarquinia, il più importante d’Italia. Da non perdere i Cavalli Alati in terracotta, altorilievo che decorava l’Ara della Regina, tempio che si trovava sull’altura della Civita.
Sicuramente è la necropoli di Monterozzi ad attirare la maggioranza dei visitatori: qui è possibile comprendere a fondo la cultura etrusca. Sono 200 le tombe dipinte, di cui le più famose sono quelle delle Leonesse, dei Leopardi, della Caccia e della Pesca e dei Giocolieri.
La necropoli, così come il museo, è visitabile tutti i giorni ad eccezione del lunedì, dalle 9:00 alle 19:30. Il biglietto intero costa € 6,00, € 10,00 se si abbinano necropoli e museo. Infine, esiste un altro luogo di grande interesse archeologico: Porto Clementino, che è l’antico porto etrusco.
Andare a Tarquinia significa anche visitare il bellissimo centro storico, caratterizzato da vicoli e monumenti medievali di indubbia bellezza, tra cui il Palazzo Comunale e il Duomo dei Santi Margherita e Martino.
Per gli amanti della natura è d’obbligo un salto alla Riserva Naturale Saline di Tarquinia (luogo che ospita innumerevoli specie di uccelli), nonché al lido per un bagno ristoratore.
Dormire a Tarquinia
- Hotel Villa Tirreno, Via B. Croce 2: struttura a due passi dal centro storico, dotata anche di un buon ristorante;
- Villa Hotel Valle del Marta Resort, Via Aurelia Vecchia Km 93: hotel immerso nel verde e dotato di una spa.
Mangiare a Tarquinia:
- Chicche e Pepe, Piazza Santo Stefano 11: consigliate le pappardelle al ragù di cinghiale;
- Ristorante Cavatappi, Via dei Granari 2: da provare la tagliata di cinta;
- Namo Ristobottega, Via Giovanni Battista Marzi 1: piatti tipici della zona, ma reinventati.
Vulci

iStock
Non siamo né in un borgo né in una città, bensì in un’ex città-Stato, oggi parco archeologico: benvenuti a Vulci, nel Viterbese.
La natura incontaminata si insinua tra i resti di questo Parco Naturalistico ed Archeologico, per accedere al quale vengono richiesti solo € 10,00. Una cifra irrisoria, se si considera l’importanza storica di questo sito.
È possibile seguire due percorsi: breve (2 km) e lungo (4 km). Il secondo permette chiaramente di svolgere una visita più approfondita e, allo stesso tempo, di fare incetta di verde.
La preziosità di Vulci consiste nell’unione tra cultura etrusca e cultura romana: nel 280 a.C., infatti, la città-Stato venne conquistata e lo dimostrano monumenti quali la domus, il foro e l’arco di Publius Sulpicius Mundus.
La parte più importante è costituita dalle necropoli, all’interno delle quali sono state trovate pregevoli opere, alcune delle quali conservate oggi al Museo di Villa Giulia, a Roma.
Lungo il percorso, ci si imbatte anche nell’Area Tradizioni Maremmane, dov’è possibile osservare i butteri (i “cowboy” della Maremma) al lavoro. Un altro luogo bellissimo del parco è il laghetto del Pellicone, dove sono anche stati girati diversi film, tra cui “Non ci resta che piangere”, con Roberto Benigni e Massimo Troisi. Poco oltre c’è la bellissima Valle delle Farfalle: qui sono state inserite delle piante nutrici, su cui le farfalle possono depositare le uova. Un’iniziativa lodevole, considerato il rischio di estinzione che stanno correndo questi meravigliosi insetti.
La visita si conclude al Castello dell’Abbadia, il piccolo ma ricchissimo Museo Archeologico Nazionale di Vulci.
Dormire
- Borgo S. Maria di Vulci, Località Camposcala, SP 105, km 2.5 (Strada del Fiora 25): una casa di campagna dotata di tutti i comfort e vicina alle attrazioni principali della zona;
- Camere Montalto di Castro, Via Soldatelli 3: un bed & breakfast apprezzato per la sua posizione e i servizi.
Mangiare a Vulci e dintorni
- Ristorante Casale dell’Osteria: si trova proprio all’interno del parco. Ottimi i ravioloni maremmani e la faraona all’arancia;
- Ristorante Metrò, Via Eugenio Curiel 22: ottima la pizza fritta con i salumi;
- Casaletto Mengarelli: è l’altro ristorante del parco. Tra i piatti da provare le polpette alla ricotta.