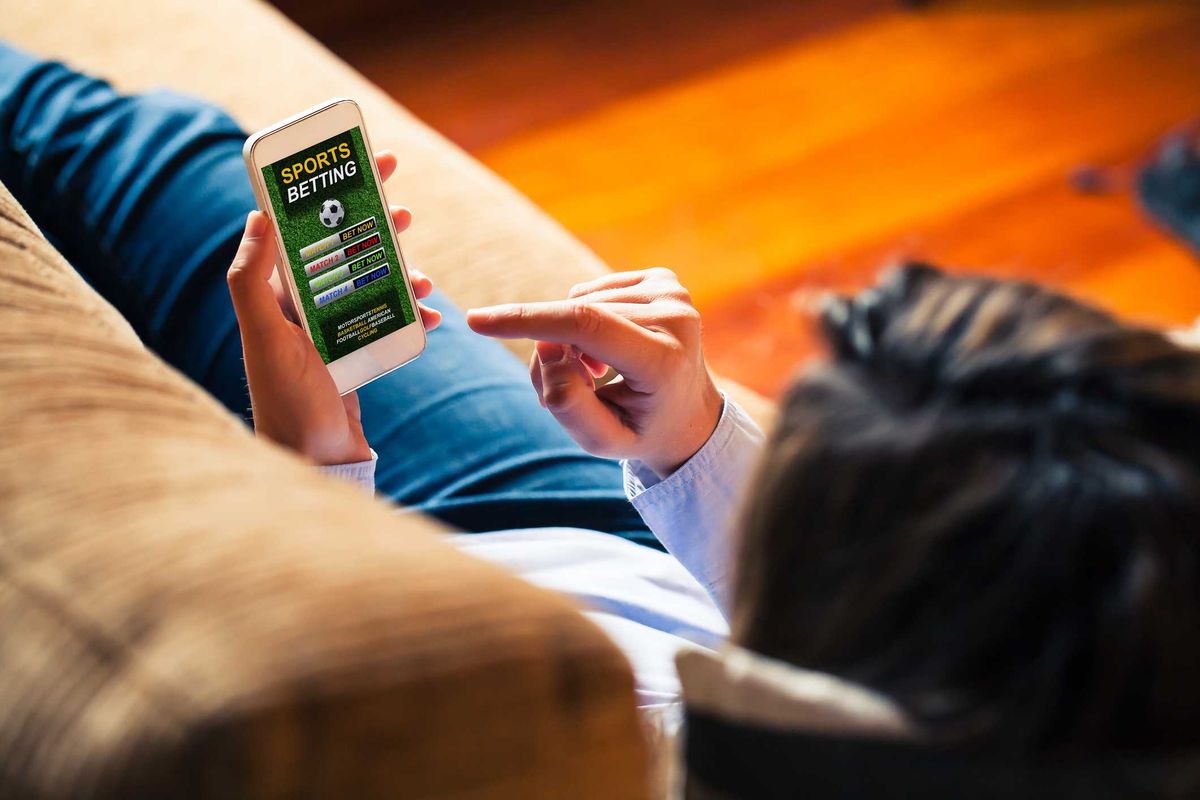Sono piatti che trovano spunto dalla fantasia e dalla necessità di chi affronta il mare per lavoro. Celebrati anche da Goldoni e nei «Malavoglia», ogni territorio ha il suo miscuglio di varietà ittiche e ingredienti diversi come pomodoro, zafferano e finocchietto.«In fondo al mar, in fondo al mar…» Ha un bel cantare Sebastian, il granchio rosso amico della Sirenetta, ma anche in fondo al mar ci sono differenze di classe. Ci sono pesci ricchi e pesci poveri, pesci aristocratici e pesci plebei, pesci costosi e pesci a buon mercato. Questi ultimi non sono figli di un mare minore. Lo dimostrano le grandi, tradizionali, povere, gustosissime zuppe della cucina dei pescatori. Sono piatti nati e cresciuti nel corso del tempo da un miscuglio di pesci umili, dal pescato invenduto: cacciucchi, brodetti, mescolanze di pesce, ricette marinare di cui parliamo oggi.È un giro dell’Italia piscatoria concentrato, ma sufficiente per capire la filosofia di piatti nati dalla fantasia e dalle necessità della brava gente che per secoli ha affrontato il mare e i suoi pericoli per sfamare la famiglia. Detto che l’elemento principale è il pescato invenduto, aggiungiamo che gli altri ingredienti di zuppe e brodetti sono suppergiù gli stessi: olio, acqua (un tempo quella di mare), aceto, aglio, prezzemolo, pane vecchio. C’è chi aggiunge pomodoro, chi zafferano o finocchietto selvatico, chi il vino bianco o altre componenti che, nel tempo, con tocchi e ritocchi, hanno migliorato le ricette fino a far diventare superlative le modeste zuppe marinare.In Liguria ci aiuta Fabrizio De Andrè a capire i piatti dei pescatori di questa ascella d’Italia. Il mercato del pesce di piazza Cavour a Genova non c’è più, ma nell’aria echeggiano ancora le voci dei pescivendoli di Creuza de mä: «Mia che bella robba, le bughe, le anciuve…». Guardate che bei pesci, le boghe, le acciughe… È così anche a Oneglia, a Sestri Levante e negli altri porti liguri che ospitano pescherecci. Si vendono branzini, orate, polpi, calamari, aragoste, astici, triglie di scoglio e triglie di sabbia, pesce azzurro. Ittiofauna per benestanti e per chi non può permettersi spigole, cernie e gamberi rossi. Meno male che ci hanno pensato i pescatori a elevare in pentola lo status dei pesci proletari elaborando appetitose ricette con acciughe, sardine, triglie, ghiozzi, boghe e resti di pesci rovinati da reti e sciabiche aggiungendo nel pentolone verdure, erbette, aromi e pane vecchio per nascondere i difetti, esaltare il gusto ed amalgamare il tutto. Grande piatto dei pescatori liguri è il bagnun de anciue, la zuppa di acciughe con aglio, olio e gallette. Si preparava a bordo dei leudi, le imbarcazioni a vela latina usate per il cabotaggio.Sull’altra ascella d’Italia trionfa il brodetto. A Chioggia lo chiamano broeto. A Venezia si è ingentilito in brodeto. A Marano, altra laguna ma stesso pesce, boreto. A Grado boreto a la graisana. A Trieste si torna a parlare di brodeto. Quello di Marano è fatto con i gò, i ghiozzi, brutti ma buoni, ma anche con anguilla, passerina, volpina, seppie, canocchie. Il brodetto di Grado gli somiglia molto ma è precolombiano: non vuole il pomodoro. Anche nel brodeto a la triestina nuotano sarde, vari tipi di piccoli pesci, bivalvi e canoce infarinati, fritti e messi in pentola col pomodoro. In Istria, in Dalmazia, un tempo terre veneziane, i nomi variano di poco: brudet, brodet, brujet… Se navighiamo a Sud di Chioggia, sulle coste di Romagna, Marche, Abruzzo, se non è zuppa è pane intinto in meravigliosi brudet o brodetti che dir si voglia. Ogni città ha la sua zuppa: Cervia, Rimini, Bellaria, Cattolica, Ancona, Porto Recanati, Civitanova, Porto San Giorgio, Porto d’Ascoli, San Benedetto del Tronto, Pescara, Vasto… Poco sostanziali le variazioni.Dove e quando è nato il brodetto di pesce adriatico? Sul quando, Massimo Alberini, storico della gastronomia, nel libro Antica cucina veneziana cita un manoscritto trecentesco di ricette dove si insegna come preparare un brodeto de pessi. Sul dove e sul chi si discuterà in eterno. Molti studiosi sostengono che la tradizione più tradizionale e la tipicità più tipica vengono da Chioggia, dai bragozzi di Paron Fortunato, Paron Toni e degli altri pescatori ai quali Carlo Goldoni ha dato vita nelle Baruffe. Sono loro ad aver creato il broeto, zuppa di svariati pesci poveri e di molluschi cotti con olio, cipolla e aceto, e ad aver fatto scuola in tutti i territori dell’ex Serenissima, Rodi, Corfù e altre isole greche. Nato dal bisogno dei pescatori di sfamarsi con un piatto unico, il broeto era cotto nel caldano sistemato a prua dei bragozzi chioggiotti, le stupende barche da pesca che per secoli hanno colorato il pescosissimo mar Adriatico. Mitiche anche le sarde in saor, prima cotte e poi conservate in aceto e olio. Anche questa prelibatezza la troviamo lungo tutte le coste adriatiche, a Corfù, a Zacinto fino al Medio Oriente. Particolare era il metodo di conservazione che usavano i pescatori veneziani, i quali avevano l’esigenza di tenere il cibo a bordo per molto tempo o comunque il più a lungo possibile, un piatto che grazie alla cipolla ha evitato lo scorbuto a molti marinai.Nella Romagna mangiapreti, oltre al brudet, si mangiano gli «uomini nudi»: così i pescatori chiamano i bianchetti, il novellame di pesce azzurro e di altre specie ittiche. È un’arte culinaria di pesce semplice, povera anzi poverazza come la squisita vongolina che si prepara con aglio e prezzemolo. Una cucina, quella dei pescatori romagnoli, che non spreca. Utilizzava e utilizza tuttora anche se non è più la fame a dettar legge ma il palato, tutto ciò che rimaneva impigliato nelle reti: novellame, minuscoli pescetti, bianchetti talmente piccoli da essere trasparenti, «nudi», appunto. I pescatori li cuociono nella stessa padella della piadina e li mangiano a scottadito, con sale e pepe.Cos’hanno in comune il quadaru, una pentola di coccio nella quale si prepara una zuppa di pesce piuttosto piccante, con il quadrato costruito sull’ipotenusa di un triangolo rettangolo uguale alla somma dei quadrati costruiti su base e altezza? Oltre all’assonanza quadaru-quadrato, hanno in comune Crotone. Qui, ottocento anni prima di Cristo, nasceva la scuola di matematica di Pitagora. Qui, ed è il motivo per il quale ci siamo fermati in Calabria nei pressi di Capocolonna, è nata una delle più interessanti minestre di mare. Un tempo era preparata dai pescatori al ritorno dal mare. U quadaru prende il nome dai tegami di terracotta. Anche questa ricetta è fatta di diversi tipi di pesce, soprattutto, o solo, di scoglio. Ci si aggiunge un cipollotto, aglio, olio, pomodoro, pane abbrustolito. Molto importante il peperoncino, il caviale calabrese.La pasta chi sardi - pasta con le sarde - ha tre anime. La prima anima è quella del piatto, tipico della cucina siciliana, inserito dal ministero delle Politiche agricole nella lista dei Prodotti agroalimentari tradizionali (Pat), è quella del mare, della pesca, dei pescatori siciliani. La sarda, pesce povero, pesce azzurro, è un pesce presente da sempre sul desco dei Malavoglia, dei Padron ‘Ntoni. Come la triglia: «Donna di telaio, gallina di pollaio e triglia di gennaio», recita un proverbio della Trinacria. La pasta con le sarde nasce, come tutte le ricette povere dei pescatori rivalutate dalla tradizione, dalla necessità di sfamarsi con ingredienti semplici, ma di gusto e di sostanza.La seconda anima della pasta con le sarde è il territorio, il finocchietto selvatico, i pinoli e lo zafferano che le donne raccoglievano nei campi vicini alle coste. La terza è un misto di leggenda e storia. È storia che i vermicelli che solitamente si usano per la pasta con le sarde li abbiano creati gli arabi, che dominavano l’isola, intorno al 900 a Trabia, vicino a Palermo. È leggenda che la pasta chi sardi sia nata dalla genialità di un cuoco arabo durante la campagna militare del generale bizantino Eufemio. Il cuoco preparò un pasto con il poco che riuscì recuperare: pasta, sarde, finocchietti selvatici, pinoli e zafferano. Gli storici della gastronomia tricolore sostengono che questo è il primo piatto «mare e monti» della cucina italiana.
Nadia e Aimo Moroni
Prima puntata sulla vita di un gigante della cucina italiana, morto un mese fa a 91 anni. È da mamma Nunzia che apprende l’arte di riconoscere a occhio una gallina di qualità. Poi il lavoro a Milano, all’inizio come ambulante e successivamente come lavapiatti.
È mancato serenamente a 91 anni il mese scorso. Aimo Moroni si era ritirato oramai da un po’ di tempo dalla prima linea dei fornelli del locale da lui fondato nel 1962 con la sua Nadia, ovvero «Il luogo di Aimo e Nadia», ora affidato nelle salde mani della figlia Stefania e dei due bravi eredi Fabio Pisani e Alessandro Negrini, ma l’eredità che ha lasciato e la storia, per certi versi unica, del suo impegno e della passione dedicata a valorizzare la cucina italiana, i suoi prodotti e quel mondo di artigiani che, silenziosi, hanno sempre operato dietro le quinte, merita adeguato onore.
Franz Botrè (nel riquadro) e Francesco Florio
Il direttore di «Arbiter» Franz Botrè: «Il trofeo “Su misura” celebra la maestria artigiana e la bellezza del “fatto bene”. Il tema di quest’anno, Winter elegance, grazie alla partnership di Loro Piana porterà lo stile alle Olimpiadi».
C’è un’Italia che continua a credere nella bellezza del tempo speso bene, nel valore dei gesti sapienti e nella perfezione di un punto cucito a mano. È l’Italia della sartoria, un’eccellenza che Arbiter celebra da sempre come forma d’arte, cultura e stile di vita. In questo spirito nasce il «Su misura - Trofeo Arbiter», il premio ideato da Franz Botrè, direttore della storica rivista, giunto alla quinta edizione, vinta quest’anno da Francesco Florio della Sartoria Florio di Parigi mentre Hanna Bond, dell’atelier Norton & Sons di Londra, si è aggiudicata lo Spillo d’Oro, assegnato dagli studenti del Master in fashion & luxury management dell’università Bocconi. Un appuntamento, quello del trofeo, che riunisce i migliori maestri sarti italiani e internazionali, protagonisti di una competizione che è prima di tutto un omaggio al mestiere, alla passione e alla capacità di trasformare il tessuto in emozione. Il tema scelto per questa edizione, «Winter elegance», richiama l’eleganza invernale e rende tributo ai prossimi Giochi olimpici di Milano-Cortina 2026, unendo sport, stile e territorio in un’unica narrazione di eccellenza. A firmare la partnership, un nome che è sinonimo di qualità assoluta: Loro Piana, simbolo di lusso discreto e artigianalità senza tempo. Con Franz Botrè abbiamo parlato delle origini del premio, del significato profondo della sartoria su misura e di come, in un mondo dominato dalla velocità, l’abito del sarto resti l’emblema di un’eleganza autentica e duratura.
iStock
A rischiare di cadere nella trappola dei «nuovi» vizi anche i bambini di dieci anni.
Dopo quattro anni dalla precedente edizione, che si era tenuta in forma ridotta a causa della pandemia Covid, si è svolta a Roma la VII Conferenza nazionale sulle dipendenze, che ha visto la numerosa partecipazione dei soggetti, pubblici e privati del terzo settore, che operano nel campo non solo delle tossicodipendenze da stupefacenti, ma anche nel campo di quelle che potremmo definire le «nuove dipendenze»: da condotte e comportamenti, legate all’abuso di internet, con giochi online (gaming), gioco d’azzardo patologico (gambling), che richiedono un’attenzione speciale per i comportamenti a rischio dei giovani e giovanissimi (10/13 anni!). In ordine alla tossicodipendenza, il messaggio unanime degli operatori sul campo è stato molto chiaro e forte: non esistono droghe leggere!
Messi in campo dell’esecutivo 165 milioni nella lotta agli stupefacenti. Meloni: «È una sfida prioritaria e un lavoro di squadra». Tra le misure varate, pure la possibilità di destinare l’8 per mille alle attività di prevenzione e recupero dei tossicodipendenti.
Il governo raddoppia sforzi e risorse nella lotta contro le dipendenze. «Dal 2024 al 2025 l’investimento economico è raddoppiato, toccando quota 165 milioni di euro» ha spiegato il premier Giorgia Meloni in occasione dell’apertura dei lavori del VII Conferenza nazionale sulle dipendenze organizzata dal Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze. Alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a cui Meloni ha rivolto i suoi sentiti ringraziamenti, il premier ha spiegato che quella contro le dipendenze è una sfida che lo Stato italiano considera prioritaria». Lo dimostra il fatto che «in questi tre anni non ci siamo limitati a stanziare più risorse, ci siamo preoccupati di costruire un nuovo metodo di lavoro fondato sul confronto e sulla condivisione delle responsabilità. Lo abbiamo fatto perché siamo consapevoli che il lavoro riesce solo se è di squadra».