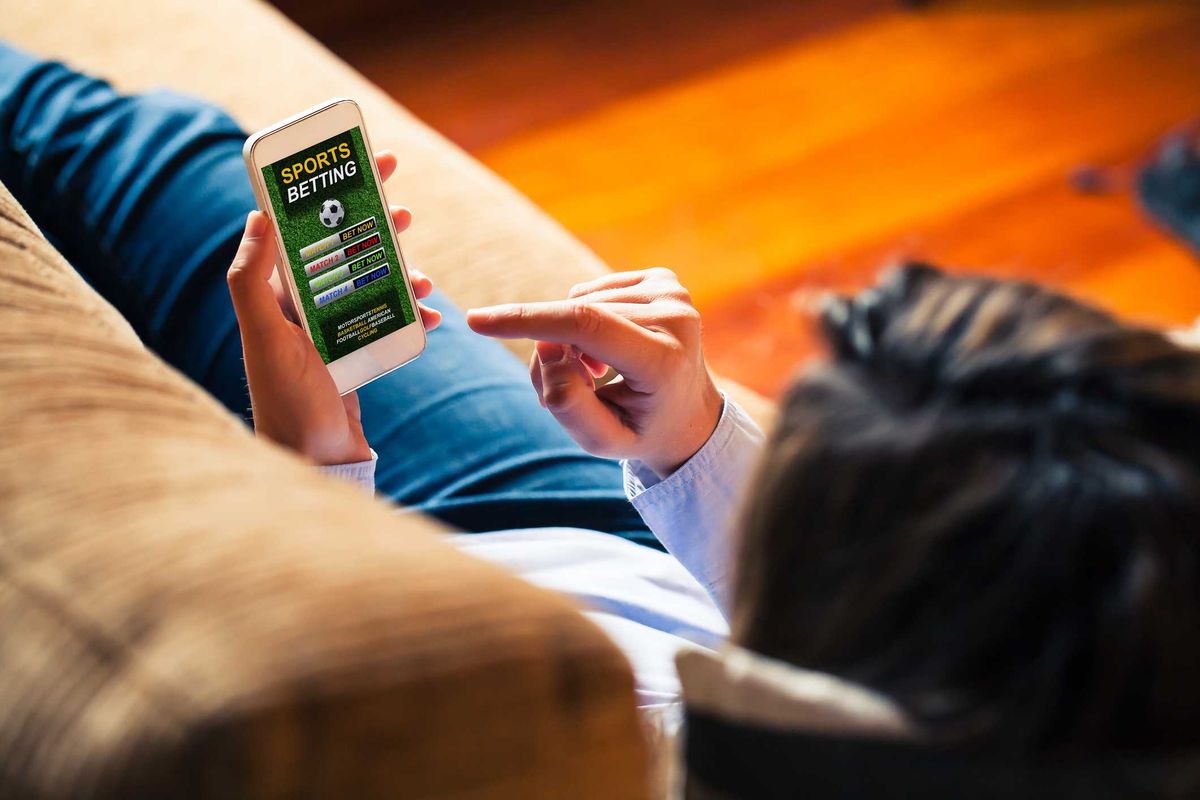Le battaglie sull’eutanasia oscurano il fatto che spesso i pazienti gravi non chiedono la morte, bensì un sollievo alla sofferenza. Ma in Italia molte Regioni sono indietro con la terapia del dolore.
Le battaglie sull’eutanasia oscurano il fatto che spesso i pazienti gravi non chiedono la morte, bensì un sollievo alla sofferenza. Ma in Italia molte Regioni sono indietro con la terapia del dolore.Lo speciale contiene tre articoliDi fronte allo scomposto dibattito su eutanasia e fine vita, in Italia il tema delle cure palliative risulta spesso oscurato. La questione, di primaria importanza, è tornata però di stretta attualità. Dopo la triste vicenda di Indi Gregory, morta lo scorso novembre, l’opinione pubblica e la politica si sono dovute scontrare col tema della sofferenza e della morte in occasione della bocciatura, da parte del consiglio regionale del Veneto, della legge di iniziativa popolare (ma appoggiata dal governatore leghista, Luca Zaia) sul suicidio medicalmente assistito. Quest’ultimo evento, in particolare, è stato l’occasione per riaccendere i fari sulla inadeguata offerta di cure palliative, garantite dalla legge e gratuite, ma ancora non sufficientemente diffuse. L’Italia è stato infatti il primo Paese in Europa a varare una legge-quadro (la 38/2010) per riconoscere il «diritto alla misurazione e al trattamento del dolore, al trattamento delle sofferenze di paziente e familiari, alla formazione dei professionisti e a un’organizzazione secondo reti cliniche». Ovvero, a tutte quelle cure per le persone affette da malattie per le quali non esistono terapie o, se esistono, sono inadeguate o inefficaci a stabilizzare la malattia o a prolungare significativamente la vita. Non solo per i pazienti oncologici, ma anche per chi soffre di malattie croniche o degenerative con prognosi infausta. Negli ultimi anni, infatti, è aumentata la richiesta di assistenza anche per i malati di Parkinson, Sla, Alzheimer, sclerosi multipla, malattie cardiovascolari e Aids.In questo quadro, il controllo del dolore e degli altri sintomi invalidanti, dei problemi psicologici e sociali, assume importanza primaria. Lo scopo delle cure palliative, infatti, non è quello di accelerare o ritardare la morte, ma di garantire ai malati dignità e la miglior qualità della vita possibile nel tempo che rimane e alla loro famiglia il supporto durante la malattia e nella fase del lutto. A quasi 14 anni dalla promulgazione, però, la legge 38/2010 resta parzialmente inapplicata. Come spiega il Comitato nazionale di Bioetica (Cnb) nel parere pubblicato lo scorso dicembre, «in Italia l’applicazione delle cure palliative è, nei migliore dei casi, a macchia di leopardo». Un problema che può incrociarsi con i diversi temi di eutanasia e suicidio poiché, rileva sempre il Comitato, «in molti casi la richiesta di essere aiutati a morire può essere riformulata come richiesta di aiuto a non soffrire».L’ultima relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge, che doveva essere annuale, risale al 31 gennaio 2019 e si riferisce al periodo 2015-2017. Ma i numeri del Rapporto di Salutequità pubblicato lo scorso novembre, elaborato su dati del ministero della Salute, di Agenas, Aifa e Italia Longeva, parlano chiaro: sono quasi 600.000 le persone che avrebbero bisogno di cure palliative ogni anno, ma solo una persona su tre riesce a riceverle. Tutte le Regioni avrebbero dovuto realizzare la Rete di cure palliative (ovvero tutte le strutture e le istituzioni del sistema socio-sanitario necessarie all’assistenza del paziente) ma, a dicembre 2021, secondo le rilevazioni dell’Agenas, Abruzzo e Marche non l’avevano istituita. La legge di Bilancio 2023 ha stabilito che entro il 2028 le cure palliative dovranno raggiungere il 90% delle persone che ne hanno bisogno, e ha stanziato 10 milioni annui per il Fondo vincolato. La Corte dei Conti, però, ha rilevato che nel 2021 era «ancora fortemente insufficiente l’assistenza prestata ai malati di tumore attraverso la rete delle cure palliative: appena 5 Regioni, tutte del Centro-Nord, sono state in grado di garantire un livello adeguato; tra le Regioni meridionali, solo la Puglia si avvicina alla soglia minima richiesta, il 35%». Uno squilibrio che risulta evidente nella mappatura delle strutture che erogano servizi di cure palliative in hospice realizzata dalla Federazione cure palliative: dalle 71 unità della Lombardia, prima Regione, alle 31 del Lazio e alle 25 del Veneto, fino a scendere alle 6 di Abruzzo, Basilicata e Calabria. Per la terapia del dolore invece, in assenza di dati istituzionali, il censimento Siaarti (Società italiana anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva) del 2021 rileva 305 centri di terapia del dolore non oncologico, anch’essi collocati in modo eterogeneo sul territorio: 164 al Nord, 64 al Centro e 77 al Sud. Come spiega ancora Salutequità, la disparità territoriale è rilevabile anche dall’utilizzo dei farmaci contro il dolore: in base ai dati Aifa, al Sud è circa il 22% inferiore alla media nazionale. Per contro, le Regioni del Nord hanno un livello di consumo del 14% superiore. Anche per quanto riguarda la formazione dei sanitari, i dati a disposizione non fotografano uno stato dell’arte soddisfacente, con un’offerta disomogenea sul territorio. Nel 2021, secondo l’Istruttoria Agenas, ben nove Regioni non avevano ancora attivato corsi di formazione per i professionisti per le cure palliative. E il numero di corsi per i sanitari sono andati diminuendo post pandemia: dai 712 corsi su dolore e cure palliative offerti nel 2019, si scende ai 470 del 2022, fino ai 348 dei primi sei mesi del 2023, con un picco minimo nel 2020 (271), anno dello scoppio della pandemia. Il Covid 19, infatti, ha travolto anche i pazienti bisognosi di cure palliative, passate in secondo piano di fronte all’emergenza sanitaria che ha costretto gli ospedali a dimettere più pazienti possibile, compresi quelli inguaribili, facendo aumentare esponenzialmente il bisogno di cure domiciliari. Secondo la ricerca svolta da Fondazione cure palliative, sul periodo dal 1° marzo al 31 maggio 2020, tramite questionario online a 90 soggetti tra associazioni di volontariato ed enti erogatori, le misure di contenimento dei contagi determinarono la rapida e quasi totale sospensione del volontariato in hospice, Rsa, ambulatori e a domicilio. Tra le altre difficoltà da fronteggiare vi sono state la parziale mancanza di operatori, finiti in quarantena, il difficile reperimento di mascherine e ritardi nell’accesso ai tamponi, con ripercussioni negative sulla qualità dell’assistenza. A cui si sono aggiunti costi per la sicurezza degli ambienti, per i Dpi e per la tecnologia necessaria per le comunicazioni a distanza, a causa del divieto di visita ai propri familiari.<div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem1" data-id="1" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/cure-palliative-ancora-negate-a-2-malati-su-3-2667108533.html?rebelltitem=1#rebelltitem1" data-basename="troppi-bimbi-in-terapia-intensiva-perche-mancano-reparti-dedicati" data-post-id="2667108533" data-published-at="1706474390" data-use-pagination="False"> Troppi bimbi in terapia intensiva perché mancano reparti dedicati Lo stato dell’arte delle cure palliative pediatriche è di difficile definizione, sia per la mancanza di dati ufficiali aggiornati sia per il tabù associato alla morte di un bambino, insieme al malinteso sulle terapie, spesso scambiate per placebo o assimilate all’eutanasia.Invece, molti dei bambini e adolescenti che necessitano di cure palliative, pur essendo affetti da patologie inguaribili, possono avere una buona qualità della vita per lungo tempo. Come spiega la Fondazione Maruzza, però, solo una minima parte dei bambini con diagnosi di malattia incurabile ha potuto accedere al supporto clinico, psicologico e spirituale a cui avevano diritto. Le stime sono impietose: in Italia su 30.000 malati pediatrici, solo il 18% riceve le cure palliative necessarie. Un terzo dei pazienti soffre di cancro. Le altre patologie pediatriche più diffuse sono insufficienza d’organo irreversibile, fibrosi cistica, malattie degenerative metaboliche e neurologiche, patologie cromosomiche e geniche e paralisi cerebrale.Al ristretto accesso alle cure, si aggiungono altre difficoltà rispetto all’età adulta. Per esempio, la disponibilità limitata di farmaci specifici per i bambini, spesso sotto forma di compresse di grandi dimensioni e di difficile somministrazione ai più piccoli. Molti medicinali non prevedono l’etichettatura per l’uso pediatrico con le relative indicazioni per l’età, le dosi e gli effetti collaterali. Inoltre, i referenti legali del paziente sono i genitori o il tutore, con il rischio che i desideri e la partecipazione nel processo di scelta dell’interessato possono rimanere inascoltati. Il continuo sviluppo fisico, emotivo e cognitivo di bambini e adolescenti, poi, incide su ogni aspetto della loro cura.L’assenza di un adeguato supporto è ancora più drammatica se si pensa al carico emotivo per i familiari e per le figure che forniscono assistenza, in un contesto in cui il fallimento dei trattamenti e la morte divengono spesso inaccettabili e il lutto e la sensazione di perdita perdurano più a lungo. La maggior parte dei minori malati muore senza il supporto dell’assistenza a domicilio, dove vorrebbero passare più tempo possibile e infine morire. Gli studi e le testimonianze confermano che le cure in casa diminuiscono la paura e il senso di isolamento, oltre a non comportare, tendenzialmente, costi più elevati rispetto all’assistenza ospedaliera. Tuttavia, dare sollievo e assistenza adeguati ai malati pediatrici nelle loro case non è sempre possibile. In questo caso, la soluzione migliore appaiono essere gli hospice o i reparti ospedalieri dedicati. Eppure, la maggiori parte dei minori continua a morire nei reparti di terapia intensiva, senza adeguati trattamenti contro la sofferenza fisica e psicologica. <div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem2" data-id="2" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/cure-palliative-ancora-negate-a-2-malati-su-3-2667108533.html?rebelltitem=2#rebelltitem2" data-basename="le-medicine-non-bastano-va-colmato-il-bisogno-daffetto" data-post-id="2667108533" data-published-at="1706474390" data-use-pagination="False"> Le medicine non bastano, va colmato il bisogno d’affetto «Le associazioni che si occupano di cure palliative si trovano a dover affrontare con sempre maggiore frequenza situazioni di solitudine. L’aumento del numero di famiglie composte da una sola persona e il progressivo invecchiamento della popolazione sono due temi con i quali ci confrontiamo sempre più spesso: capita di incontrare malati soli o assistiti da un familiare, un coniuge altrettanto anziano e bisognoso di assistenza». Tania Piccione è presidente della Federazione cure palliative, organizzazione che raggruppa 103 enti no profit a livello nazionale, e direttore generale della Onlus Samot. «Le cure palliative rappresentano un modello di cura capace di rispondere appropriatamente alla complessità dei bisogni, affiancando e integrando il paradigma clinico con la cura sociale, oggi maggiormente difficile da gestire. La politica sanitaria punta sulla territorialità delle cure identificando la casa come luogo privilegiato per l’assistenza ma è chiaro che dobbiamo fare i conti con una percentuale di malati soli che non possono essere curati a domicilio perché non hanno una valida rete familiare di supporto». Piccione sottolinea l’importanza di «promuovere azioni per rafforzare i legami con la comunità mobilitando le risorse esistenti e il capitale sociale al fine di migliorare i modi informali in cui le persone si connettono tra loro, arginando situazioni di solitudine ed isolamento. Un ruolo strategico viene svolto dalle associazione di volontariato». Ma proprio la solitudine non finisce per essere una spinta verso il suicidio assistito? Piccione ritiene che non necessariamente debba esserci un legame tra i due temi. «Penso che le cure palliative siano una risposta validissima anche al problema della solitudine attraverso la mobilitazione della rete del volontariato e la capacità di creare comunità attorno al malato. Le cure palliative offrono alle persone la possibilità di vivere l’ultimo percorso di vita in piena dignità attraverso il sollievo dallo stato di sofferenza globale della persona malata e che riguarda allo stesso modo gli aspetti fisici, psichici, sociali e spirituali». Quindi quando si parla di cure palliative si fa riferimento ad un paradigma di cura sistemico non circoscritto solo al malato, perché guarda anche alla sua famiglia, e che non si esaurisce con l’erogazione di prestazioni mediche. «Si tratta di un approccio alla cura che riguarda non solo la sfera fisica del malato, ma tutti gli aspetti che possono contribuire a peggiorarne le condizioni, partendo dal presupposto che la persona gravemente malata, oltre a bisogni fisici, presenta bisogni affettivi, psicologici, esistenziali, sociali di cui è necessario prendersi cura». E le reti di supporto sono diverse tra Nord e Sud Italia. «Nel Mezzogiorno è ancora estesa la rete familiare e amicale sulla quale il malato può contare e risulta attiva una comunità di vicinato generalmente pronta ad intervenire a sostegno dei più fragili. Nel Nord il cambiamento sociale è più profondo ma anche nelle regioni del Sud si registra una progressiva trasformazione delle strutture familiari. Ed è sui nuovi bisogni e sui contesti socio-demografici che cambiano che gli operatori di cure palliative si devono confrontare».
Nadia e Aimo Moroni
Prima puntata sulla vita di un gigante della cucina italiana, morto un mese fa a 91 anni. È da mamma Nunzia che apprende l’arte di riconoscere a occhio una gallina di qualità. Poi il lavoro a Milano, all’inizio come ambulante e successivamente come lavapiatti.
È mancato serenamente a 91 anni il mese scorso. Aimo Moroni si era ritirato oramai da un po’ di tempo dalla prima linea dei fornelli del locale da lui fondato nel 1962 con la sua Nadia, ovvero «Il luogo di Aimo e Nadia», ora affidato nelle salde mani della figlia Stefania e dei due bravi eredi Fabio Pisani e Alessandro Negrini, ma l’eredità che ha lasciato e la storia, per certi versi unica, del suo impegno e della passione dedicata a valorizzare la cucina italiana, i suoi prodotti e quel mondo di artigiani che, silenziosi, hanno sempre operato dietro le quinte, merita adeguato onore.
Franz Botrè (nel riquadro) e Francesco Florio
Il direttore di «Arbiter» Franz Botrè: «Il trofeo “Su misura” celebra la maestria artigiana e la bellezza del “fatto bene”. Il tema di quest’anno, Winter elegance, grazie alla partnership di Loro Piana porterà lo stile alle Olimpiadi».
C’è un’Italia che continua a credere nella bellezza del tempo speso bene, nel valore dei gesti sapienti e nella perfezione di un punto cucito a mano. È l’Italia della sartoria, un’eccellenza che Arbiter celebra da sempre come forma d’arte, cultura e stile di vita. In questo spirito nasce il «Su misura - Trofeo Arbiter», il premio ideato da Franz Botrè, direttore della storica rivista, giunto alla quinta edizione, vinta quest’anno da Francesco Florio della Sartoria Florio di Parigi mentre Hanna Bond, dell’atelier Norton & Sons di Londra, si è aggiudicata lo Spillo d’Oro, assegnato dagli studenti del Master in fashion & luxury management dell’università Bocconi. Un appuntamento, quello del trofeo, che riunisce i migliori maestri sarti italiani e internazionali, protagonisti di una competizione che è prima di tutto un omaggio al mestiere, alla passione e alla capacità di trasformare il tessuto in emozione. Il tema scelto per questa edizione, «Winter elegance», richiama l’eleganza invernale e rende tributo ai prossimi Giochi olimpici di Milano-Cortina 2026, unendo sport, stile e territorio in un’unica narrazione di eccellenza. A firmare la partnership, un nome che è sinonimo di qualità assoluta: Loro Piana, simbolo di lusso discreto e artigianalità senza tempo. Con Franz Botrè abbiamo parlato delle origini del premio, del significato profondo della sartoria su misura e di come, in un mondo dominato dalla velocità, l’abito del sarto resti l’emblema di un’eleganza autentica e duratura.
iStock
A rischiare di cadere nella trappola dei «nuovi» vizi anche i bambini di dieci anni.
Dopo quattro anni dalla precedente edizione, che si era tenuta in forma ridotta a causa della pandemia Covid, si è svolta a Roma la VII Conferenza nazionale sulle dipendenze, che ha visto la numerosa partecipazione dei soggetti, pubblici e privati del terzo settore, che operano nel campo non solo delle tossicodipendenze da stupefacenti, ma anche nel campo di quelle che potremmo definire le «nuove dipendenze»: da condotte e comportamenti, legate all’abuso di internet, con giochi online (gaming), gioco d’azzardo patologico (gambling), che richiedono un’attenzione speciale per i comportamenti a rischio dei giovani e giovanissimi (10/13 anni!). In ordine alla tossicodipendenza, il messaggio unanime degli operatori sul campo è stato molto chiaro e forte: non esistono droghe leggere!
Messi in campo dell’esecutivo 165 milioni nella lotta agli stupefacenti. Meloni: «È una sfida prioritaria e un lavoro di squadra». Tra le misure varate, pure la possibilità di destinare l’8 per mille alle attività di prevenzione e recupero dei tossicodipendenti.
Il governo raddoppia sforzi e risorse nella lotta contro le dipendenze. «Dal 2024 al 2025 l’investimento economico è raddoppiato, toccando quota 165 milioni di euro» ha spiegato il premier Giorgia Meloni in occasione dell’apertura dei lavori del VII Conferenza nazionale sulle dipendenze organizzata dal Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze. Alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a cui Meloni ha rivolto i suoi sentiti ringraziamenti, il premier ha spiegato che quella contro le dipendenze è una sfida che lo Stato italiano considera prioritaria». Lo dimostra il fatto che «in questi tre anni non ci siamo limitati a stanziare più risorse, ci siamo preoccupati di costruire un nuovo metodo di lavoro fondato sul confronto e sulla condivisione delle responsabilità. Lo abbiamo fatto perché siamo consapevoli che il lavoro riesce solo se è di squadra».