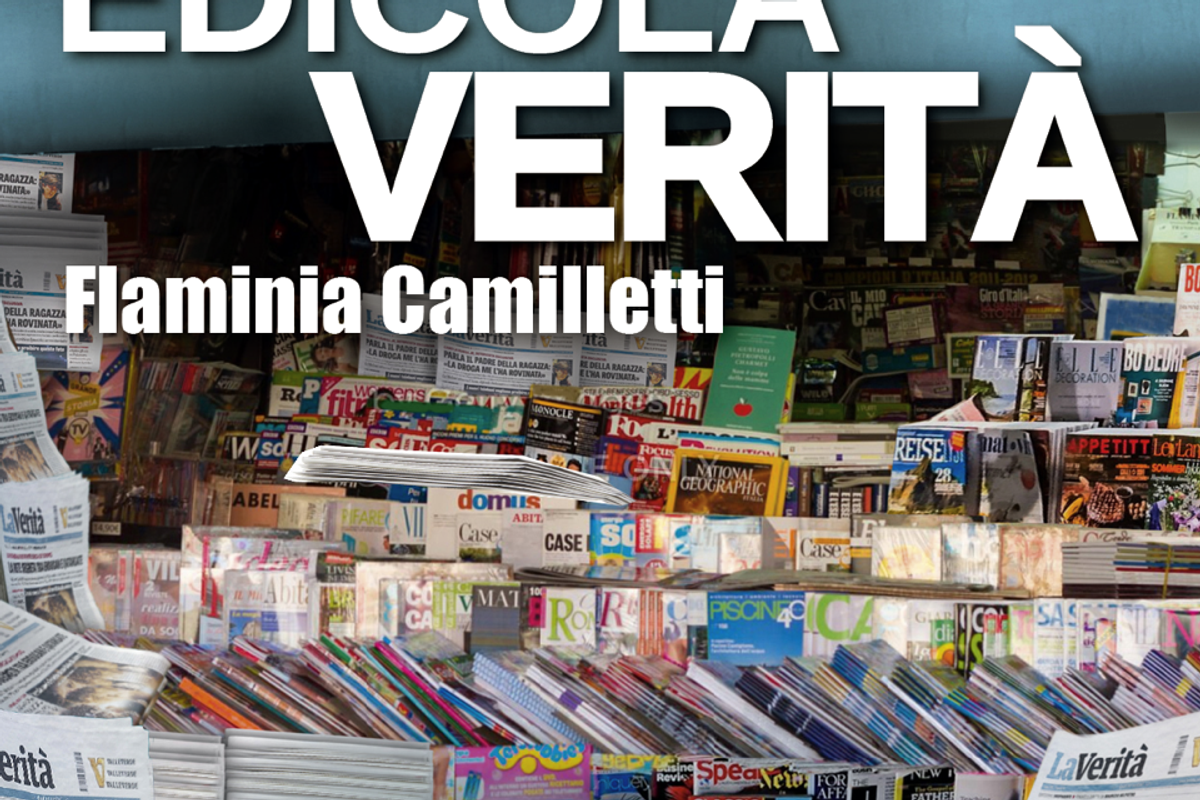Presidente di sezione a riposo della Corte di Cassazione
Non è certo la scoperta dell’America quella che, non di rado, scelte puramente politiche vengano veicolate mediante apparenti tecnicismi decifrabili, come tali, soltanto dagli «addetti ai lavori». Specialista in tali operazioni è la nostra Corte costituzionale, nella sua autoattribuitasi funzione di organo preposto non (come dovrebbe) alla sola verifica del rispetto, da parte del legislatore ordinario, delle regole e dei limiti fissati dalla Costituzione, ma anche alla salvaguardia e alla promozione di veri o presunti «valori» desumibili dall’evoluzione della società civile, di cui essa si pone quale privilegiata e insindacabile interprete.
Fra tali valori spicca, negli ultimi anni, quello costituito dalla dignità della donna sulla quale, ovviamente, in sé e per sé, non si potrebbe che essere totalmente d’accordo se non fosse per il fatto che, in taluni casi, la dignità della donna viene concepita in termini non di uguaglianza ma di ingiustificata prevalenza rispetto a quella dell’uomo. Uno di questi casi, passato a suo tempo quasi in sordina, è quello della sentenza numero 161 del 2023, con la quale venne ritenuta non contraria al principio di uguaglianza stabilito dalla Costituzione la pur riconosciuta disparità di trattamento che, nella legge numero 40/2004 sulla procreazione medicalmente assistita (Pma), è riscontrabile tra la posizione dell’uomo e quella della donna con riguardo all’eventuale revoca del consenso reciprocamente prestatosi per il ricorso alla suddetta pratica.
Pur essendo, infatti, previsto per entrambi che il consenso possa essere revocato solo fino a quando non sia avvenuta la fecondazione dell’ovulo, la donna può comunque revocarlo di fatto, rifiutando di sottoporsi all’impianto dell’ovulo fecondato e, quindi, di diventare madre mentre l’uomo è costretto a diventare legalmente padre del nascituro pur quando, venuto meno per fatti sopravvenuti il rapporto affettivo o di coniugio con la donna, quest’ultima abbia, ciononostante, autonomamente deciso di sottoporsi all’impianto dell’ovulo a suo tempo fecondato e rimasto in stato di crioconservazione.
Le linee guida per la procreazione assistita, recentemente rinnovate dal ministero della Salute (come segnalato su La Verità dell’11 maggio), hanno necessariamente dovuto recepire la suddetta disciplina, la cui legittimità, secondo la Corte costituzionale, si basa essenzialmente sul fatto che essa sarebbe «funzionale a salvaguardare l’integrità psicofisica della donna» e, al tempo stesso a tutelare la «dignità dell’embrione». Quanto alla prima di tali finalità, la Corte ha osservato che la donna, «nell’accedere alla Pma è coinvolta in via immediata con il proprio corpo, in forma incommensurabilmente più rilevante rispetto a quanto accade per l’uomo»; ragion per cui occorrerebbe proteggerla «dalle ripercussioni negative che su di lei produrrebbe l’interruzione del percorso intrapreso, quando questo è ormai giunto alla fecondazione».
Quanto alla seconda, la Corte ha fatto leva sul principio secondo cui la Pma «mira favorire la vita», per cui dovrebbe ritenersi consentito «che la relativa disciplina possa privilegiare, anche nella sopraggiunta crisi della coppia, la richiesta della donna che, essendosi fortemente coinvolta, come si è visto, nell’interezza della propria dimensione psicofisica, sia intenzionata, anche dopo che sia decorso un rilevante periodo di tempo dalla crioconservazione, all’impianto dell’embrione».
In realtà entrambe le argomentazioni appaiono, sotto un profilo logico, assai criticabili. Con riguardo alla prima, risulta messo in luce, nella stessa sentenza della Corte, che il coinvolgimento corporeo più impegnativo, da parte della donna, è proprio quello che precede la fecondazione, alla quale può giungersi soltanto dopo che la donna si è sottoposta e ripetuti cicli di stimolazione ovarica (comportanti anche il rischio dell’insorgenza di gravi patologie), per giungere, quindi, al prelievo dell’ovocita, da realizzarsi mediante «un trattamento sanitario particolarmente invasivo, tanto da essere normalmente praticato in anestesia generale». Se, quindi, l’irrevocabilità del consenso del «partner» maschile dovesse servire - come si è voluto sostenere - a prevenire il pericolo che la donna si ritrovi ad aver subito inutilmente fastidi e pericoli per la propria salute, il relativo limite temporale avrebbe dovuto essere fissato ben prima di quello coincidente con l’avvenuta fecondazione.
Con riguardo, poi, alla «dignità dell’embrione» - da ricollegarsi, con ogni evidenza, all’aspettativa di vita in esso contenuta - appare evidente come sia del tutto ingiustificato che essa sia fatta prevalere solo sulla volontà dell’uomo di revocare il consenso a suo tempo prestato, così da impedire che quell’aspettativa si realizzi, e non sulla volontà della donna, che, senza dover addurre giustificazione alcuna, può, di fatto, parimenti impedire, anche dopo la fecondazione dell’ovulo, con il proprio rifiuto di sottoporsi all’impianto, che dall’embrione nasca la vita.
Ma una qualche giustificazione all’irrevocabilità del consenso del «partner» maschile dopo la fecondazione dell’ovulo potrebbe comunque trovarsi nel caso di fecondazione omologa - qual’era quello esaminato dalla Corte costituzionale con la citata sentenza numero 161/2023 - comportando essa l’esistenza di un effettivo rapporto genetico tra il «partner» maschile e l’embrione. Ben diverso sarebbe però il caso di una eventuale fecondazione eterologa, quale resa giuridicamente possibile, nell’ambito di coppie eterosessuali, in determinate condizioni, dalla riconosciuta, parziale incostituzionalità, per effetto di altre precedenti decisioni della Consulta, del divieto originariamente previsto dalla legge numero 40/2004.
Dovendosi comunque applicare la norma (ritenuta legittima dal giudice delle leggi) sulla irrevocabilità del consenso dopo la fecondazione, pur quando il rapporto di coppia sia venuto meno, il risultato sarebbe che il «partner» maschile si troverebbe a essere, suo malgrado, legalmente «padre» (con assunzione delle relative responsabilità) di un bambino con il quale non esiste alcun tipo di rapporto genetico, essendo la fecondazione avvenuta mediante uso del liquido seminale proveniente da altro, sconosciuto soggetto. E il bambino si troverebbe, a sua volta, costretto a dover riconoscere come «padre» - e a far conto su di lui per le proprie esigenze materiali e anche affettive - un individuo che gli è, sotto ogni profilo, del tutto estraneo.
Potrebbe sperarsi che, se e quando una tale situazione si presentasse e la Corte costituzionale venisse nuovamente investita della questione sulla irrevocabilità del consenso da parte maschile, la decisione sarebbe diversa da quella adottata nel 2023. Ma, nel frattempo, grazie ai precedenti di cui si è detto, la situazione è tale per cui l’assurdo può diventare realtà.