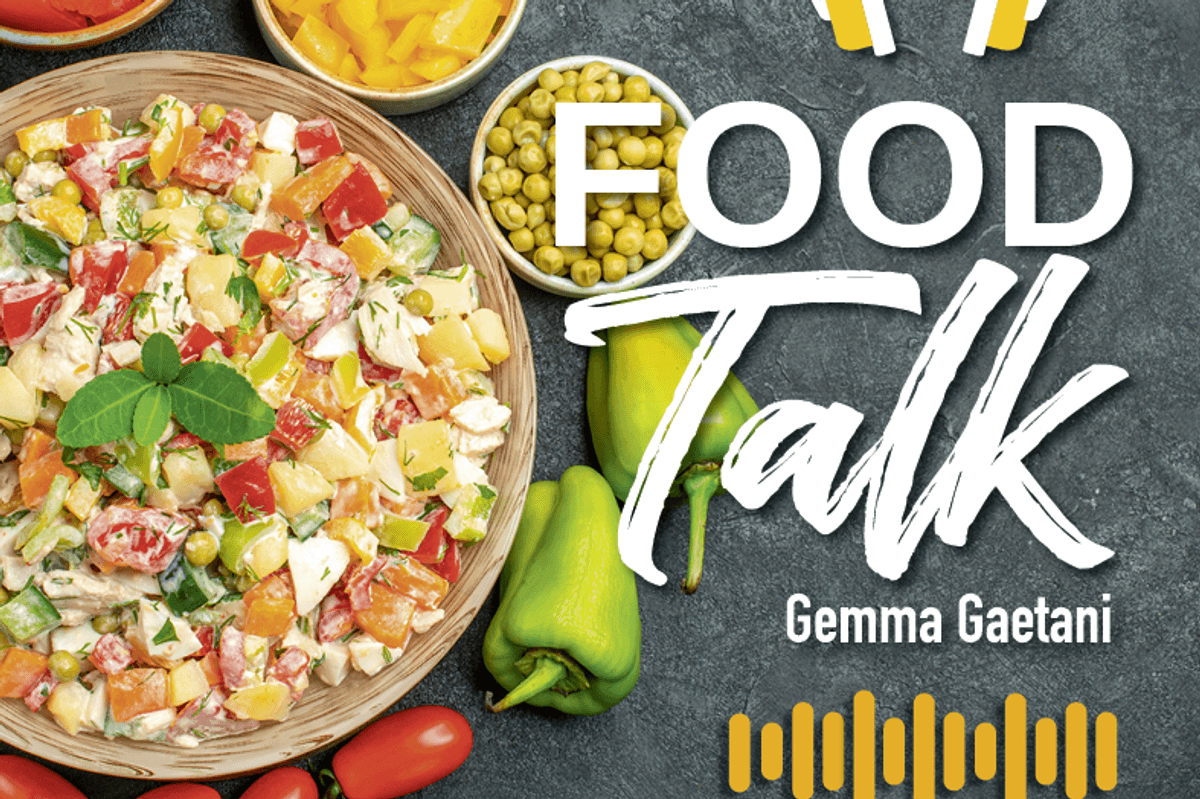La crisi energetica iniziata un anno e mezzo fa in Europa, aggravata dallo scorso febbraio a causa dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, non accenna a risolversi e anzi si aggrava con il passare dei giorni. Non solo i prezzi di gas ed energia elettrica continuano a salire, ma il progressivo affievolirsi dei flussi di gas dalla Russia e la crisi del nucleare francese pongono ora il problema dell’approvvigionamento fisico. Così, la Francia di Emmanuel Macron e la Germania di Olaf Scholz cercano di correre ai ripari e intervengono massicciamente nell’arena economica. Qualche giorno fa il primo ministro francese Élizabeth Borne ha reso nota l’intenzione del suo governo di nazionalizzare di nuovo Edf entro fine anno. L’annuncio, che ha sollevato molti interrogativi in Francia, segue la decisione di imporre sempre a Edf un prezzo calmierato per la vendita di energia elettrica al mercato all’ingrosso.
In Germania, il governo sta lavorando al salvataggio del colosso del gas Uniper. Il ceo dell’azienda ha dichiarato che per il 2022 è prevista una perdita di circa 10 miliardi di euro e, anche se per il momento l’azienda non rischia l’insolvenza, la dirigenza insiste per un intervento pubblico urgente. Il ministro delle finanze Christian Lindner e quello dell’economia Robert Habeck hanno in mano il dossier e stanno studiando un aumento di capitale che porterebbe lo Stato a controllare il 25% della compagnia. In precedenza, lo stesso governo tedesco aveva nazionalizzato le infrastrutture di stoccaggio gas affidate in concessione ad Astora, società controllata dalla russa Gazprom. I tre siti erano stati lasciati semivuoti sin dalla scorsa estate. Ora sono sotto il controllo del gestore della rete, ente pubblico, che sta provvedendo al riempimento a tappe forzate.
Dunque, i governi dei due maggiori Paesi del continente ignorano l’Unione europea, con i suoi tempi lunghi e la sua inadeguatezza, e con una sana dose di pragmatismo decidono in autonomia di giocare un ruolo attivo nell’economia. E l’Italia? Dopo tre mesi di incertezze e ritardi, il decreto del ministero della Transizione ecologica del 22 giugno 2022 ha affidato il servizio di riempimento degli stoccaggi di ultima istanza al responsabile del bilanciamento (Snam, parte del gruppo Eni) e successivamente al Gestore dei servizi energetici (Gse), società controllata dal Mef Inoltre, su mandato del governo, Snam ha acquistato due unità Fsru (Floating storage and regasification unit), ovvero la nave Bw Singapore (dal costo di 400 milioni di dollari) e la Golar Tundra (330 milioni di euro). Ma il governo italiano, assai più timido di quelli di Berlino e Parigi, dà l’impressione di attendere che a Bruxelles qualcuno indichi una soluzione.
La proposta italiana di introdurre un tetto al prezzo del gas è stata accolta con poco entusiasmo a Bruxelles e se ne parlerà, forse, soltanto a ottobre. Decisamente tardi, vista la situazione. In Germania sono già in vigore misure di contenimento della domanda tramite razionamento. La crisi mondiale dell’energia si arricchisce dunque della variante interventista, che vede i governi europei rientrare direttamente nella gestione economica e financo in quella operativa, in seguito al clamoroso fallimento del mercato così come voluto dall’Unione europea. Il peccato originale del mercato europeo dell’energia sta nell’aver dato al punto di scambio olandese del gas chiamato Title transfer facility (Ttf) una dimensione continentale. Da mercato regionale per lo scambio di partite fisiche quale era, il Ttf è diventato prima un mercato finanziario, con l’introduzione dei futures, poi un riferimento di prezzo per tutta l’Europa. Ciò è stato fatto, però, senza tenere conto di due fattori determinanti. Il primo è la struttura assai concentrata dell’offerta, che in dieci anni fino al 2021 è stata rappresentata per oltre il 50% da gas russo. Il secondo fattore è il gas naturale liquefatto, mercato mondiale molto volatile e più costoso, che spesso ha fornito i quantitativi marginali utili a soddisfare la domanda di gas al Ttf, contribuendo alla formazione del prezzo. La combinazione dei due fattori si è rivelata esplosiva nel momento in cui è intervenuto uno shock esterno, nel caso specifico il lancio delle politiche del Green deal, con il progressivo abbandono degli investimenti negli idrocarburi, combinato con la turbolenta ripresa cinese. La guerra in Ucraina è venuta ad acuire una crisi già conclamata e ha solo reso più evidente l’errore europeo della mancata diversificazione dell’approvvigionamento.
Di fronte alla grottesca inerzia dell’Unione, gli Stati membri meno ingenui intervengono con decisione per salvare le economie nazionali. Dall’euforia irresponsabile di Bruxelles per la concorrenza come panacea si è passati agli appelli ai governi perché «facciano qualcosa». Il sistema nato a esaltazione della concorrenza si sta attorcigliando in un accrocco di partecipazioni statali, in cui verticalizzazione e centralizzazione sono gli elementi fondanti. Una nemesi che assume la forma di una corsa alle scialuppe di salvataggio al grido di si salvi chi può, e soprattutto come può. Nella già difficile congiuntura monetaria e geopolitica, non è azzardato dire che la crisi energetica rischia di rappresentare un elemento dirompente nella già traballante costruzione europea.