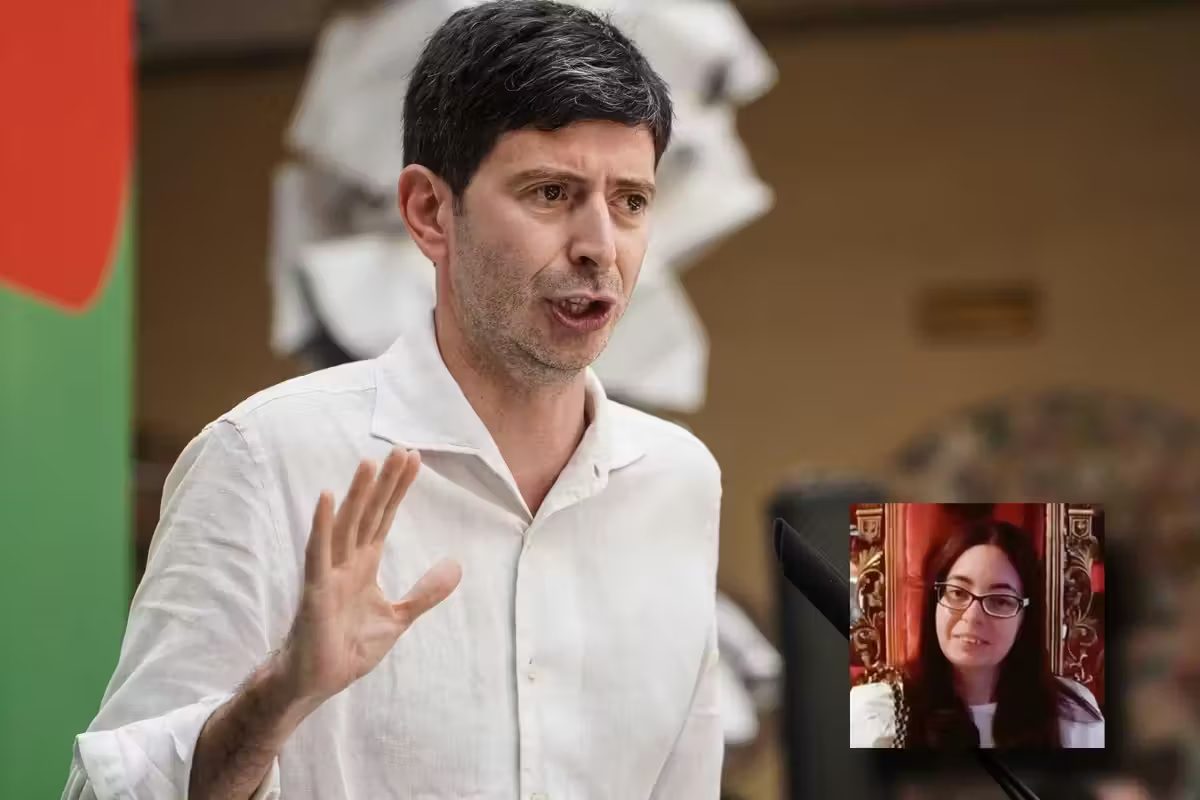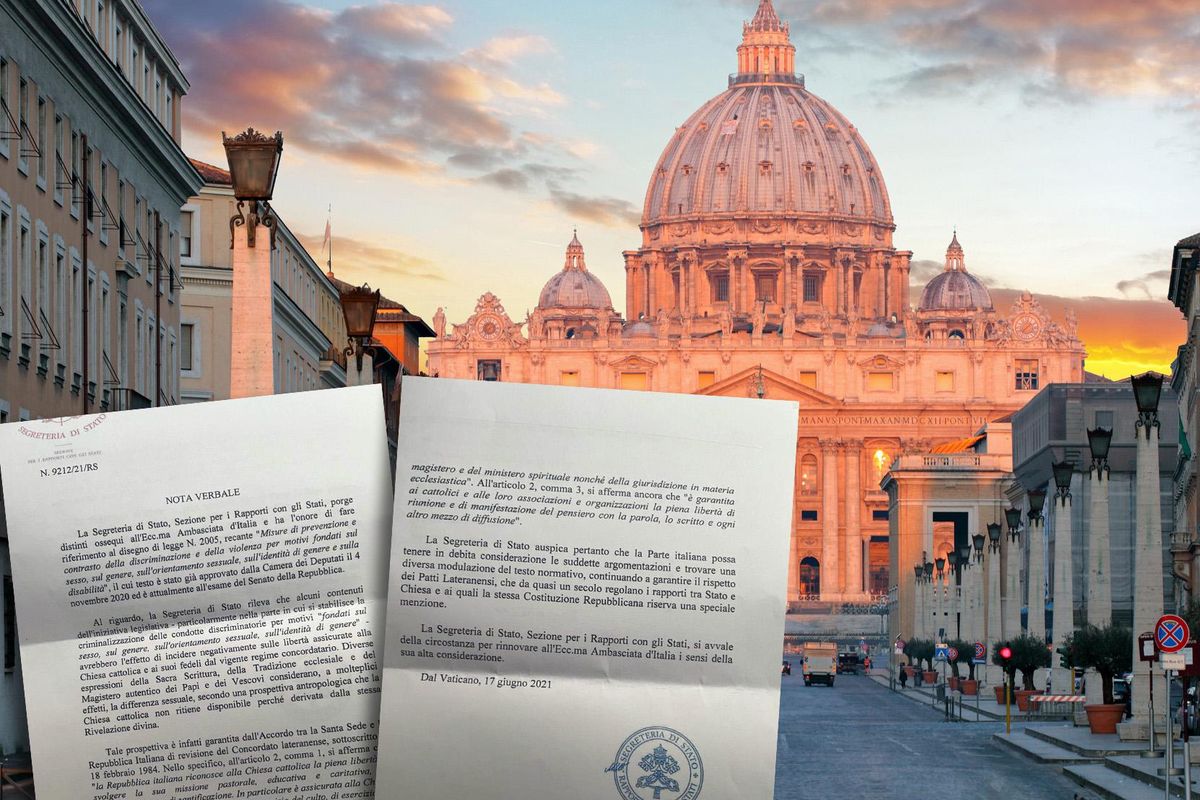
Presidente di sezione a riposo della Corte di cassazione
Si può pensarla come si vuole a proposito della recente nota diplomatica del Vaticano sul ddl Zan. Una cosa, però, dovrebbe essere chiara, e cioè che tanto il tipo di risposta che ad essa si vorrà dare quanto, più in generale, l’esito finale del ddl in questione (approvazione così com’è, approvazione con modifiche, bocciatura), non hanno nulla, ma proprio nulla, a che vedere con la salvaguardia del principio di laicità dello Stato. Per rendersene conto occorre partire dalla premessa che perché uno Stato possa dirsi «laico» è necessaria e sufficiente la sola condizione che esso non sia «confessionale», cioè che non riconosca come propria una determinata confessione religiosa e non si ritenga quindi vincolato ad adeguare ad essa, e ad essa soltanto, la propria legislazione e la propria prassi politica e amministrativa. Lo Stato laico è, quindi, uno Stato indifferente rispetto alla scelte religiose, riservate, come tali, ai singoli individui.
Ciò non significa, però, che esso sia privo di una sua propria visione etica, la quale può essere della più varia natura, ma costituisce comunque, almeno nelle enunciazioni, il necessario punto di riferimento di tutto il suo operare. Non può non esservi, infatti, una determinata visione etica alla base della scelta di ciò che lo Stato intenda vietare, imporre o permettere, pur quando si tratti di una scelta che risponde anche a finalità di tipo utilitaristico. Il vietare e il sanzionare penalmente, ad esempio, comportamenti quali l’omicidio, il furto, la rapina (tanto per limitarci ai casi di maggiore evidenza), trova la sua legittimazione in esigenze di natura etica rispondenti ai principi della morale comune prima ancora che in esigenze di natura pratica connesse alla salvaguardia delle condizioni minime per il mantenimento della convivenza civile.
Ora, il fatto che quei principi siano o possano essere condivisi anche da un determinato credo religioso e, segnatamente, da quello della religione cattolica, senza per questo essere propri ed esclusivi del medesimo, nulla toglie, con ogni evidenza, alla laicità dello Stato che, per sua libera scelta, ispiri ad essi la sua azione politica. Se così è, deve però anche ritenersi che, per converso, qualora lo Stato, sempre per sua libera scelta, si ispiri ad una visione etica contrastante con quella cattolica o di un’altra religione, non per questo sia da considerare «più laico» di quanto lo sarebbe qualora il contrasto non esistesse. Così, ad esempio, lo Stato nel quale l’aborto volontario sia, di regola, penalmente perseguibile (come avveniva fino a non moltissimo tempo fa in quasi tutti gli Stati), non può solo per questo dirsi «meno laico» di quello nel quale esso sia invece consentito, dal momento che le ragioni a sostegno dellw illiceità penale dell’aborto volontario, quale che sia il giudizio da darsi circa la loro validità, non sono, comunque, proprie ed esclusive della religione cattolica o di qualunque altra religione.
Ed ecco allora che, anche con riguardo al ddl Zan, il fatto che lo stesso sia approvato nel testo attuale, ovvero sia modificato o, ancora, respinto rileva unicamente sotto il profilo della dialettica politica tra le varie forze che si battono per l’una o l’altra delle suddette soluzioni, ma non si presta (o meglio, non dovrebbe prestarsi) a valutazioni che investano il principio della laicità dello Stato. Le ragioni a sostegno della modifica o della reiezione, infatti, pur se largamente condivise dalla Chiesa cattolica o da movimenti che ed essa siano ispirati, non trovano il loro fondamento solo ed esclusivamente nella dottrina cattolica ma sono, in tutto o in parte, comuni a fasce della pubblica opinione che a tale dottrina sono estranee e, talvolta , addirittura radicalmente ostili (come, in particolare, lo sono taluni movimenti femministi, dai quali, come è noto, sono state espresse critiche anche molto severe nei confronti del ddl in questione).
Né può dirsi che la messa in discussione della laicità dello Stato sia la necessaria conseguenza dell’invio, da parte del Vaticano, della nota verbale nella quale si prospetta la possibile violazione, da parte dell’Italia, nel caso di approvazione del ddl nel testo attuale, di norme pattizie contenute nel Concordato tra l’Italia e la Santa Sede, come rivisto e aggiornato con l’Accordo del 1984. Infatti, proprio perché si denuncia una tale possibile violazione, quello che viene in questione è soltanto il fondamentale principio delle relazioni internazionali (o, comunque, fra entità che si riconoscono reciprocamente come sovrane), secondo cui «pacta sunt servanda», e non anche la salvaguardia o meno della laicità dello Stato. Ciò in quanto quest’ultima entra in gioco solo ed esclusivamente nella fase in cui i patti sono stipulati e non in quella successiva in cui essi devono trovare applicazione e nella quale, quindi, l’unico riferimento possibile è quello ai comuni criteri tecnico-giuridici ai quali occorre rifarsi per giungere alla loro corretta interpretazione. Salvo che, essendosi tardivamente rilevata, in tale fase, la pretesa lesione, nella precedente fase di stipulazione, della laicità dello Stato, si pretenda che gli accordi concordatari vengano unilateralmente denunciati e resi quindi inoperanti.
Con il che i fautori di una tale soluzione si metterebbero però nell’imbarazzante situazione di apparire emuli del cancelliere tedesco Bethmann-Hollweg, al quale risale la famosa affermazione che i trattati internazionali (nella specie, quello che avrebbe dovuto garantire la neutralità del Belgio e sottrarlo, quindi, nel 1914, all’invasione da parte tedesca) altro non erano se non «chiffons de papier» (pezzi di carta) che potevano in ogni momento essere strappati quando non facevano più comodo.
Se tutto ciò ha un qualche fondamento, come si spiega, dunque, la levata di scudi da parte di molti in nome della «laicità dello Stato», contro l’iniziativa diplomatica del Vaticano? Si spiega considerando che essa trae origine dalla confusione, più o meno consapevole, tra la laicità dello Stato, che è una cosa seria, e il «laicismo di Stato», che ne costituisce una sorta di caricatura, consistente soltanto nel «fare i dispetti», ogni qual volta se ne presenti l’occasione, per puro preconcetto ideologico, alla Chiesa cattolica; con l’aggravante che, come caricatura, non risulta neppure particolarmente divertente.