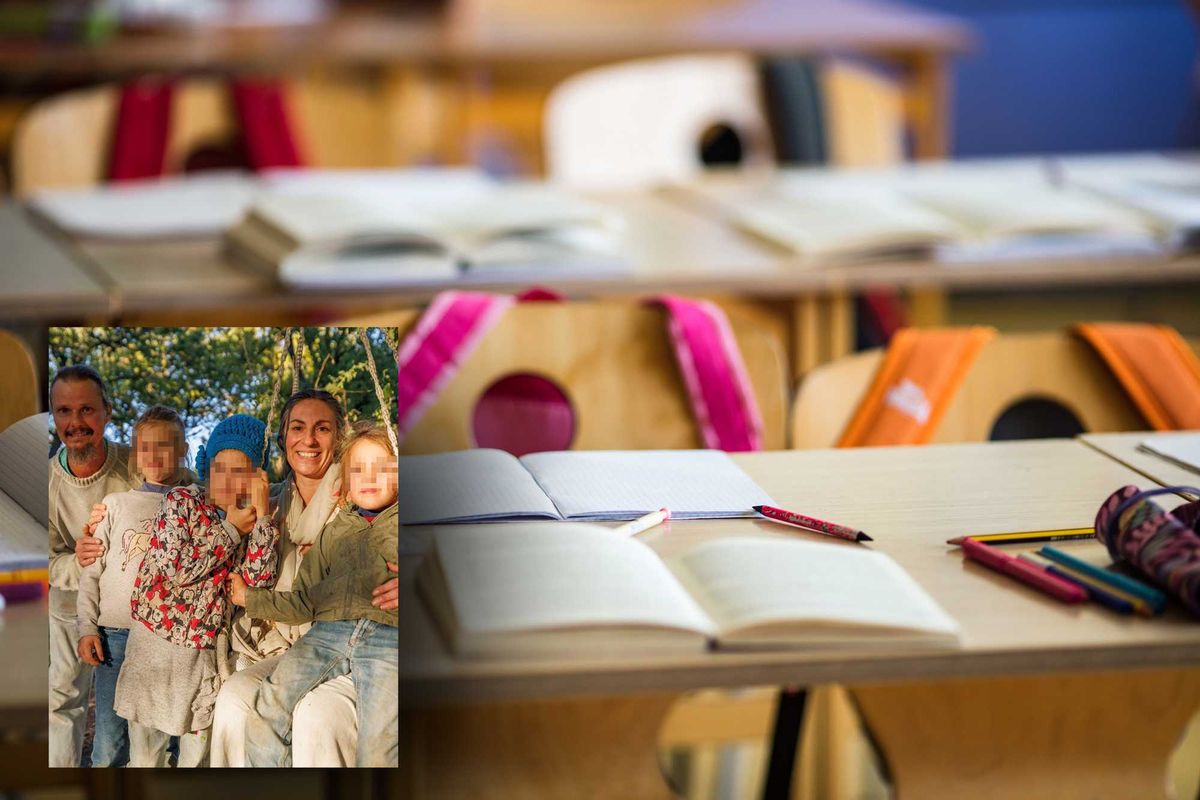Centralizzare altri poteri a Bruxelles umilia voto popolare e democrazia

Nel 2017 un gruppo di intellettuali europei tra cui Rémi Brague, Pierre Manent e Roger Scruton si riunì a Parigi e condivise un lungo manifesto in 36 punti sull’«Europa in cui possiamo credere». Un appello filosofico e politico, di cui non è difficile capire le ragioni di una scarsa diffusione. Scrivevano tra le altre cose i 13 pensatori: «Legittimati da presunte necessità economiche, i mandarini sovranazionali delle istituzioni comunitarie europee confiscano la vita politica dell’Europa, rispondendo alle sfide in modo tecnocratico: non esiste alternativa. È questa la tirannia morbida ma concreta che abbiamo oggi di fronte».
Un piccolo saggio di questa «confisca» allucinata si è avuto ieri: con il Medio Oriente in fiamme e l’Ucraina a pezzi, il «ministro degli Esteri» dell’Ue, Josep Borrell, ha detto che l’Unione «all’inizio era solo una potenza commerciale, ora è diventata una potenza economica e con la guerra è diventata una potenza geopolitica: siamo uno dei poli del mondo multipolare». Il suo collega della Commissione, il francese Thierry Breton, sta in questi giorni affrontando un tema capitale come quello della libertà d’espressione e della responsabilità dei contenuti sulle piattaforme digitali riducendolo a una rissa social con Elon Musk, sotto cui si cela una battaglia campale sul controllo dell’informazione.
Come scritto da Sergio Giraldo pochi giorni fa, la proposta di revisione dei Trattati elaborata dagli esperti del Parlamento prevede, tra le altre cose, una competenza esclusiva dell’Ue per l’ambiente e per i negoziati sui cambiamenti climatici; competenze concorrenti con gli Stati in materia di sanità, industria e istruzione; e di «rafforzare ulteriormente le competenze concorrenti dell’Unione nei settori dell’energia, degli affari esteri, della sicurezza esterna e della difesa, della politica in materia di frontiere esterne». Se attuate, queste istanze ridefinirebbero in senso non proprio sussidiario le architravi che fondano uno Stato di diritto, i cardini della rappresentanza e tutto sommato della possibilità stessa dell’alternanza.
Qui sotto viene tratteggiata una dinamica di cui più volte questo giornale si è occupato, purtroppo in solitudine: l’asse con cui Oms e Ue intendono procedere in materie sanitarie e ancora di libertà di espressione, rendendo automaticamente vincolanti negli ordinamenti nazionali raccomandazioni e indicazioni dell’ente globale. Comunque la si pensi sulla gestione del Covid, dovrebbe essere scattato qualche campanello d’allarme sui rischi delle compressioni dei diritti e delle libertà sotto la sferza dell’emergenza. E invece.
Sul piano formale si può sostenere con ragione che nessuno dei passaggi qui descritti sia fuori dall’alveo della democrazia: trattati e accordi internazionali approvati dai Paesi e dai loro parlamenti hanno consentito il trasferimento di decisioni complesse a strutture sovranazionali, spesso indubbiamente utili. Tuttavia, con altrettante ragioni è difficile negare uno svuotamento sostanziale della sostanza della democrazia che faceva affermare con sarcasmo a Scruton e soci sei anni fa: «Le nostre classi dirigenti promuovono i diritti umani. Combattono i cambiamenti climatici. Progettano un’economia di mercato più globalmente integrata e l’armonizzazione delle politiche fiscali. Supervisionano i passi compiuti verso l’eguaglianza di genere. Fanno così tanto per noi! Che importa dei meccanismi con cui sono arrivati ai loro posti? Che importa se i popoli europei sono sempre più scettici delle loro gestioni?».
Stanno venendo ora al pettine molti di questi nodi, sotto i colpi di una storia che marcia a passi orrendi: da mesi l’aria e la maggioranza all’Europarlamento sono cambiati. È cresciuta la consapevolezza che certi pensieri magici (e interessati) sul green, sull’elettrico, sulle magnifiche sorti del Pnrr, cadono all’apparir del vero. Il dividendo di questa rivincita della realtà pare appannaggio di famiglie politiche conservatrici. Vedremo l’uso che ne sapranno fare, ma il nocciolo della battaglia è più profondo. Proporre un pensiero e un’azione politica tesi a contenere lo svuotamento istituzionale degli Stati non è questione di destra o di sinistra: è questione grazie a cui destra e sinistra possano esistere, perché in condizione di fare cose diverse una volta giunte al potere. Mentre Gaza brucia, l’Occidente difende la democrazia di Israele e ad essa chiede di comportarsi come tale di fronte al terrorismo. Sarebbe imperdonabile dimenticarne i fondamenti a casa e poi piangere sull’astensionismo.