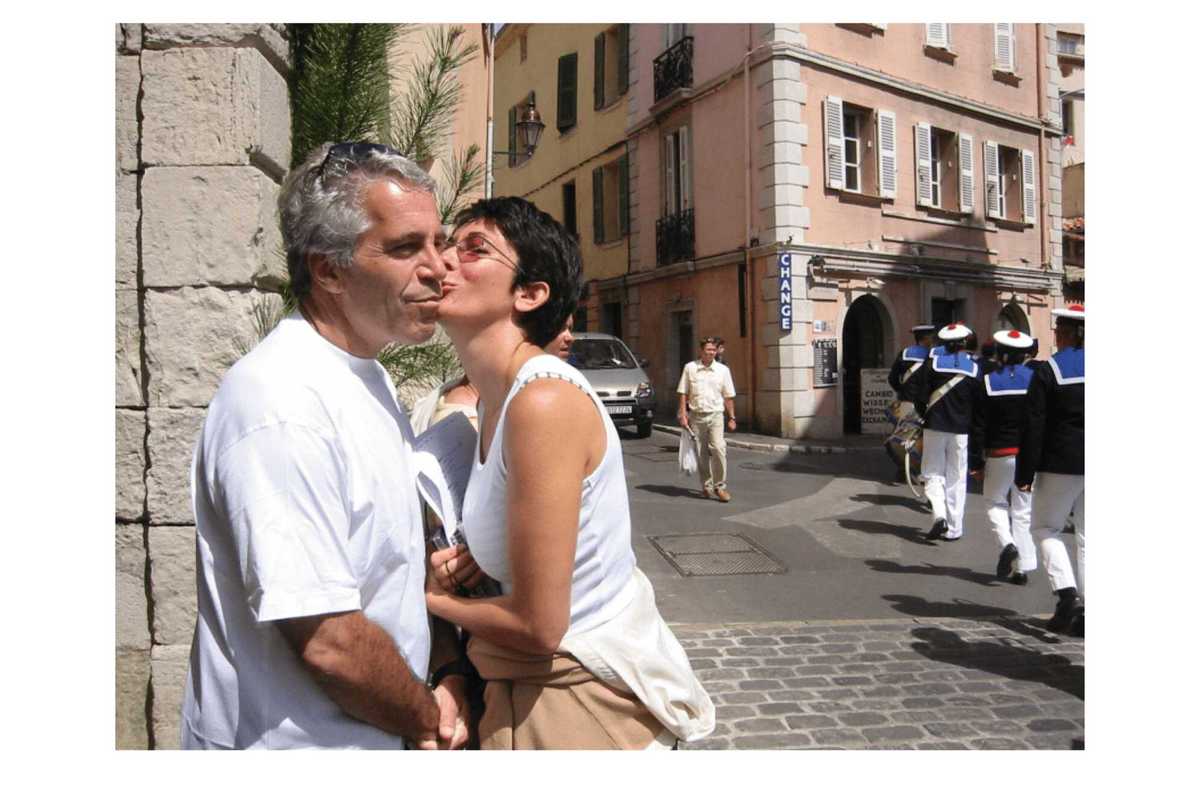C'è bisogno di eroi. Nella storia e nel mito essi compaiono periodicamente, quando le leggi della vita (come la procreazione) vengono violate dalla società, e gli antichi valori ed equilibri devono essere riparati e rimessi in funzione. L'eroe nel mito (come anche nella realtà) è appunto l'uomo che affronta situazioni al di fuori della routine dell'esistenza quotidiana, per modificare positivamente la vita di tutti. L'obiettivo buono e difficile e il dono all'altro e alla comunità sono caratteristiche dell'eroe. Il cui intervento avviene soprattutto nelle fasi storiche di decadenza, quando non funziona più nulla o quasi, dalle cose grandi alle piccole. Come appunto accade nella nostra vita, da un bel po' di tempo. Il crollo del ponte di Genova è solo l'ultima, vistosa metafora della nostra vita quotidiana; ma lo sono anche le liste dei soffitti a rischio nelle scuole, gli immigrati in carico alla Caritas che spariscono (poi quando ritrovati non si riescono a rimandare a casa perché gli aerei che li dovrebbero trasportare si guastano) e migliaia di altri fatti quotidiani del tutto fuori dal previsto e da ogni regola di buon senso.
I miti, storie simboliche che hanno la funzione educativa di riavvicinare l'uomo alle forze delle origini, parlano spesso degli eroi per trasformare positivamente le coscienze delle persone e aiutarle nei tempi di decadenza ad allearsi con le loro energie capaci di trasformare la situazione. È appunto in questi frangenti opachi e pesanti che spesso si intravedono aspetti della figura dell'eroe, colui che può cambiare il mondo attorno, soprattutto perché è profondamente diverso dagli aspetti più corrosi e invecchiati della condizione precedente.
«L'eroe ha luce», dice il mitologo Károly Kerényi nei suoi lavori su queste figure, perché è in una relazione naturale, spontanea, con il mondo trascendente, che ci parla del senso della vita umana, l'unica cosa che lo interessa profondamente. Egli è il risanatore naturale delle istituzioni, proprio perché è cresciuto al di fuori di esse e non partecipa alla loro corruzione. È quindi il caso di osservare qualcuno di questi personaggi eroici e vedere cosa ci mostrano.
L'eroe mitico dell'Occidente dopo la consunzione e decadenza dell'impero romano e della prima fase del mondo cavalleresco di re Artù, è Parsifal, il figlio di un re guerriero ucciso in Oriente, e per questo allevato dalla madre nella natura incontaminata lontano da ogni corte, pratica e intrigo di governo. È proprio questa sua innocenza e diversità rispetto all'ormai decaduta corte di Artù, dove viene infatti accolto con beffe e risate per la sua apparente rozzezza, che può guarire (anzi: solo lui è in grado di farlo) la malattia che corrompe il corpo e il regno del Re Pescatore, di cui è destinato a prendere il posto. Il mito illustra come ogni livello ormai maturo di civiltà tenda a decadere e per rigenerarsi abbia bisogno dell'istintiva naturalezza e coraggio dell'eroe, di solito definito «barbaro» per la sua lontananza dalle maniere consuete, o «selvatico» per la sua vicinanza alla selva. Thomas Stearns Eliot, ispirato dalla sua forte attualità l'ha riproposto nel Novecento con il poema La terra desolata.
Spesso l'eroe, oltre che «barbaro» è anche un «figlio senza padre» o perché il genitore è morto in guerra (come quello di Parsifal), o perché lontano da casa. Come i padri espulsi da casa dalla «fabbrica dei divorzi» della tarda modernità occidentale o quelli di cui parlano i protagonisti di Fight club, film cult dell'in-sofferenza maschile oggi. L' allontanamento del padre è infatti un altro dei tasti dolenti delle società decadenti, che rifiutano di riconoscere le loro superficialità e preferiscono tenersi strette le loro disfunzioni malate. Ma, come aveva riconosciuto Barack Obama (non proprio un conservatore), i problemi dei troppi figli senza padre fanno ammalare un intero Paese, anche se grande come gli Usa. È per questo, ad esempio, che il nuovo progetto di legge sull'affido condiviso in Italia dà tanto fastidio, anche se propone misure e princìpi ormai in vigore da anni in tutta Europa, e non solo. Potenti gruppi di pressione, alcuni genitori, e soprattutto molti avvocati, non vogliono gestire la separazione nell'interesse dei figli, lo considerano un eroismo del tutto fuori luogo.
Meglio milioni di figli resi orfani di padre dai ridicoli tempi di frequentazione stabiliti dall'affido condiviso finora praticato in Italia, che una legge che richieda una partecipazione veramente paritaria, alleggerendo anche le madri da una falsa onnipotenza, che avvelena la vita dei figli oltre a quella dei genitori in competizione tra loro. Anche su questa legge, dunque, il cambiamento è considerato «barbarie» da logori interessi consolidati (che controllano però la quasi totalità dei media); le patologie generate dal sistema sonola norma, tanto più che il prezzo del disastro lo pagano i figli e non gli adulti. Appunto per questo, però, è necessario l'eroe, Parsifal, che irrompa nella corte dei bugiardi con il suo ronzino scalcagnato e vestito di pezza. I rischi (compreso quello delle diverse forme di follia, perché diventare grandi così non fa bene, come provano le statistiche), sono ormai troppo elevati per credere che le istituzioni si autoguariscano.
Anche l'antropologia (con Arnold Gehlen) dà la stessa risposta. Quando le istituzioni non sono più in grado di proteggere l'uomo dai rischi elementari cui dovrebbero provvedere, a cominciare dalla sicurezza personale «affiorano irresponsabilità e disorientamento» e il comportamento pubblico tende a regredire verso livelli puramente istintivi. Chi detiene il potere vuole semplicemente sopravvivere e mantenerlo, anche se è ormai privo di slancio ideale e non sa assolutamente come usarlo. A pagarne le spese sono sempre soprattutto le nuove generazioni, i giovani: ed è l'eroe che interviene per salvarli.
Spesso il comportamento patologico è rappresentato dal mito come un mostro che esige a intervalli regolari giovanissimi maschi e femmine del paese per divorarli. Dal punto di vista simbolico, si uccide il futuro per soddisfare i propri appetiti. Per salvare la gioventù della nazione l'eroe deve uccidere il mostro. È interessante che i mostri siano sempre parenti stretti del potere riconosciuto. A Morholt, il mostruoso fratello del re d'Irlanda, devono essere consegnati i giovani della Cornovaglia, finché il giovanissimo Tristano si ribella e dopo una dura lotta lo uccide. Pretese simili ha l'orribile Minotauro, l'uomo con la testa da toro rinchiuso al centro del labirinto del palazzo reale di Creta, che divora i giovani ateniesi. Il Minotauro è il figlio della Regina di Creta (rappresentante dalla Grande Madre lunare), e del toro bianco di cui la regina Pasifae si era innamorata, convincendo il re, Minosse, a non sacrificarlo al dio della guerra Ares (Marte) cui era destinato. Il significato è trasparente: le più pure forze virili (il toro bianco) anziché sacrificate al dio venivano destinate ad appagare istinti bestiali che divoravano il meglio della gioventù greca. A ciò si oppone l'eroe Teseo, che parte con i giovani ateniesi e con l'aiuto di Venere e di Arianna, l'innamorata figlia della regina, uccide il Minotauro e libera le prede destinategli.
Gli aspetti mostruosi dei vecchi poteri (anche dentro di noi, non solo nella società), che rifiutano l'autenticità del cambiamento accusandolo di barbarie e inciviltà, vanno messi in condizione di non fare altri danni e rinunciare ai loro mostruosi appetiti. Occorre parteggiare per l'eroe, già presente negli altri e dentro di noi. E saperne riconoscere la luce, aiutandola a crescere.