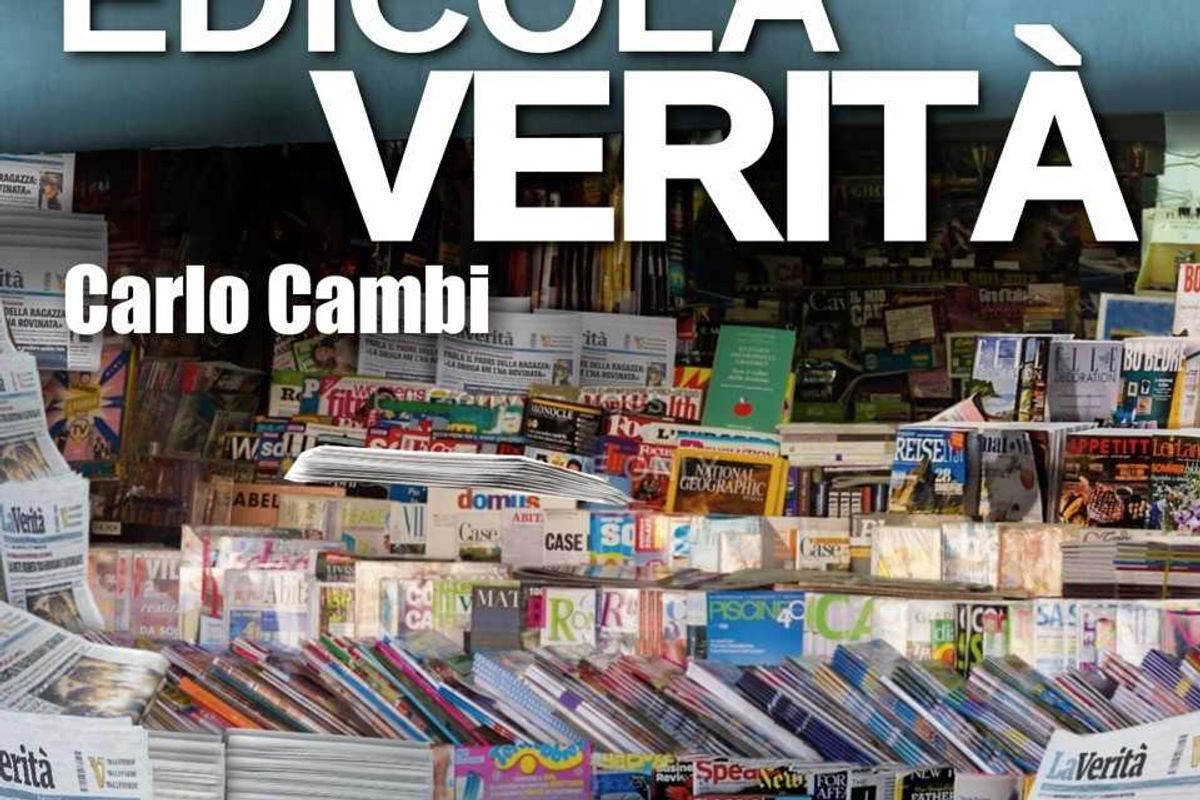Quando i nonni erano bambini - diciamo una settantina d’anni fa - e la domenica pomeriggio, dopo il catechismo, si fiondavano nei cinema parrocchiali a vedere i film «d’indiani» di terza o di quarta visione, sentivano il bisogno proprio come i loro nipotini d’oggi di scaricare la tensione sgranocchiando qualcosa. A quei tempi (Cesare Marchi li definì «i tempi di quando eravamo povera gente») il ruolo del pop corn e delle chips lo svolgeva l’italianissima e proletaria carruba che i nonni-bambini acquistavano con poche lirette al carretto del fruttivendolo che stazionava in piazza davanti al cinematografo. I più ricchi si potevano permettere il castagnaccio o addirittura le noccioline americane, i più poveri (e cioè quasi tutti) comperavano la carruba, chiamata anche siliqua, o i semi di zucca. Una volta in sala, tra un duello e l’assalto a una carovana, tiravano fuori di tasca il secco baccello dolciastro e lo mordicchiavano di gusto, beatamente ignari che i loro nipoti, decine d’anni dopo, si sarebbero goduti film di prima visione in cinema multisale triturando maxi secchielli di pop corn ricchi di sale e di carboidrati complessi. Una carruba durava quanto un film.
Impossibile spiegare ai bimbi d’oggi, soprattutto se cittadini, cos’è la carruba se non si può mostrar loro il bacellone della Ceratonia siliqua, cioè del carrubo. Improponibile, poi, farglielo assaggiare. Già la carruba è poco bella da vedere, scura e grinzosa com’è. I gusti, poi, sono cambiati: il dolcigno che piaceva ai nonni dispiace agli schizzinosi nipoti. La sputerebbero schifati nonostante il vago sapore di cacao che ricorda il cioccolato. La carruba è un frutto per certi versi dimenticato. I carretti degli ambulanti di dolciumi sono spariti, dai fruttivendoli non si trova, nei mercati neppure e nei supermercati tanto meno. Le carrube si danno ai maiali e ai cavalli che ne sono ghiotti. Si trova, però, il prodotto trasformato: la farina di carrube che viene lavorata dall’industria alimentare in surrogato del cacao e ampiamente usata per fare biscotti, gelati, sciroppi, marmellate, budini.
Per fare un buon budino bastano 80 g. di farina di carruba, 60 di farina normale, 100 g. di zucchero, 6 dl. di latte e 80 g. di burro che va sciolto in un pentolino a bagnomaria. Dopo di che si aggiunge la farina di carruba e si mescola bene. Tolto il pentolino dall’acqua calda si aggiungono poco alla volta lo zucchero e la farina continuando a mescolare. In fine si versa il latte, intiepidito a parte, continuando a mescolare. Si pone il pentolino sul fuoco facendolo bollire per un paio di minuti. Si versa il tutto nello stampo per budino, si fa raffreddare a temperatura ambiente, si pone lo stampo in frigorifero in modo che il budino si addensi e il sano dessert è pronto.
La farina di carrube essendo priva della caffeina, viene da molti - soprattutto da chi è allergico al cioccolato - preferita al cacao e usata come addensante per preparare dolci. Sia la polvere che la farina costituiscono la base di molte ricette. In Sicilia, dove la produzione di carrube è ancora fiorente e dove tra Catania e Taormina, alle pendici dell’Etna, c’è una località in comune di Giarre che si chiama Carruba, con la farina di carrube si confezionano molte specialità. Un grande poeta ragusano, Salvatore Quasimodo, ricorda l’albero in una sua bellissima poesia, Lamento per il sud: «Ho dimenticato il mare, la grave/ conchiglia soffiata dai pastori siciliani,/ le cantilene dei carri lungo le strade/ dove il carrubo trema nel fumo delle stoppie...»
Il Ceratonia siliqua è un albero formidabile che arriva ai 10 e passa metri d’altezza e si presenta con una bella chioma frondosa sempreverde tanto che sullo stesso albero si trovano contemporaneamente le foglie, i fiori e i frutti che restano a lungo appesi ai rami. Il carrubo è un vegliardo della natura. Se non gli si rompono le scatole, campa fino a 500 anni. Nei dintorni di Milazzo, sempre in Sicilia siamo, c’è un carrubo che gli esperti di scienze forestali dell’univesità di Palermo fanno risalire alla metà del Cinquecento.
In Palestina, da dove proviene la Ceratonia siliqua, usavano i suoi frutti duemila anni prima di Cristo. Gli antichi egizi per il sapore dolciastro lo adoperavano come dolcificante. Era lo zucchero di Tutankhamon. A portarlo in Italia sono i Greci, ma sono stati gli Arabi a dare importanza e nome al kharrub. Sempre gli arabi chiamavano i semi qirat e li usavano, essendo tutti, suppergiù, di peso uguale, per misurare l’oro. Per pesare l’oro oggi si usa un’unità di misura ponderale specifica che ha mantenuto il nome antico: il carato.
La carruba è un frutto presente nelle sacre scritture e nelle leggende legate a personaggi della religione. Nel Vangelo di Luca, Gesù racconta la parabola del figliol prodigo che dopo aver dissipato tutte le sue sostanze vivendo dissolutamente, va a pascolare i porci: «Egli desiderava riempire il ventre con le carrube che i porci mangiavano, ma nessuno gliene dava».
Secondo una credenza popolare, le carrube erano nel menu di Giovanni il Battista insieme alle cavallette e al miele selvatico. È per tale motivo che questo baccellone scuro è chiamato anche pane di San Giovanni. Una leggenda racconta che il carrubo è diventato un albero maestoso e ricco di frutti dopo essere stato benedetto da Gesù Bambino per ringraziarlo di aver nascosto lui, la sua mamma, Maria, e Giuseppe dagli sgherri di Erode durante la fuga in Egitto. Un’altra leggenda narra che fu sotto ad un carrubo nell’orto dei Getsemani che Giuda tradì Gesù con un bacio. Dopo la cattura del Maestro, disperato, s’impiccò alla stessa pianta. Una terza leggenda siciliana afferma che le croci dei ladroni crocifissi con Gesù erano fatte con legno di carrubo.
La pianta appartiene ad una famiglia dal nome difficile: Caesalpinioideae, che, a sua volta, appartiene alla più vasta famiglia delle Fabacee (leguminose). Il frutto ha proprietà terapeutiche. La carruba ha meno proteine degli altri legumi e più carboidrati. La farina, ricca di vitamine e sali minerali, soprattutto calcio, povera di grassi, senza glutine, è utilizzata per preparare dolci dietetici. La cucina tradizionale, povera, trattava la carruba, e in genere le erbe dei campi (erano la farmacia dei poveri) come cibo e come medicina. La farina di carruba è antisettica e combatte la diarrea assorbendo le tossine che causano gastroenteriti e coliti. Il decotto di carruba in polvere è un buon espettorante. Sempre la farina, ridotta in crema, fa bene anche per la pelle. Creme e unguenti a base di carruba per la bellezza della pelle si trovano in erboristeria.
Molti studiosi nei secoli passati sottolinearono il doppio uso della carruba come cibo (nei periodi di carestia la siliqua salvò dalla fame migliaia di poveri cristi) e come medicina. L’umanista modenese Giacomo Castelvetro, vissuto a cavallo tra il ’500 e il ’600, scrittore che viaggiò per mezza Europa e richiò di finire sul rogo per essersi fatto protestante, nel libro Brieve racconto di tutte le radici, di tutte l’erbe e di tutti i frutti che crudi o cotti in Italia si mangiano, edito a Venezia nel 1614, descrive le caratteristiche del regno vegetale italico e quindi anche delle «carobe»: «Nasce nel reame di Napoli una spezie d’alberi alti e grossi quanto le querce, portanti certi frutti chiamati carobe assai dolce quando è secco ma molto più quando è verde. Viene per cibo molto stomachevole stimato e riscaldato alquanto sopra cenere calda e dopo cena mangiato, consuma il catarro e fa mille altri buoni effetti».