Favorisce l’abbronzatura. Protegge il cuore e la vista. E fa bene all’economia
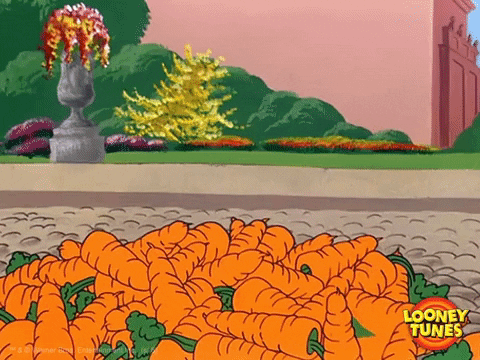
Ha il colore giallo arancio del sole che in questa stagione illumina a lungo le nostre giornate, caratterizzate da ben 15 ore di luce contro le 9, per esempio, di gennaio, ma non c'è solo questo. La sua affinità elettiva con la stagione durante la quale sentiamo le cicale frinire è testimoniata anche dal fatto che uno dei suoi componenti, il betacarotene, è il prezioso ingrediente di molte delle profumate lozioni solari che spalmiamo sulla pelle prima del bagno di sole in spiaggia o in piscina. Stiamo parlando della bella e buona carota, uno dei dieci ortaggi più consumati al mondo, diffusissimo in primo luogo in forma selvatica, perché attecchisce così facilmente da essere considerata una pianta infestante, poi in forma addomesticata, essendo ormai coltivata a fini in primo luogo alimentari ovunque il clima temperato lo consenta.
Nella stagione estiva fiorisce la carota selvatica, nei prati e a bordo strada, portando sotto i nostri occhi icone floreali molto diverse dai fiori che di più siamo abituati a vedere. Al contempo, d'estate si raccoglie la carota addomesticata, dopo la semina tipicamente primaverile (ma si può effettuare la semina forzata delle carote precoci da ottobre a febbraio, con raccolta dopo tre mesi, oppure la semina semiforzata in regioni dal clima molto caldo come quelle del nostro Sud da febbraio e marzo, e poi si può riseminare da fine agosto, proteggendo le carote dall'umidità autunnale-invernale). Il suo nome, tardo latino, deriva dal greco karotón. La specie, ribattezzata da Linneo Daucus carota, in una sorta di duello tra carota selvatica e carota addomesticata, ha visto poi trionfare nel tempo la più diffusa di quest'ultima, la Daucus carota subspecies sativus. Si tratta dell'attuale carota di colore arancione che coltiviamo come pianta alimentare: è una coppia di caratteristiche che ci potrebbero sembrare scontate e sempre date in questo modo, ma non è così. Le carote sono arancioni adesso, ma in passato erano viola e gialle: discendenti dalle carote selvatiche addomesticate probabilmente in Afghanistan, furono diffuse in Europa dagli Arabi attraverso il bacino del Mediterraneo nel Medioevo. Nel Libro de arte coquinaria di Maestro Martino da Como del 1460, troviamo scritto: «Simelmente poterai fare pavonazo l'altro quarto bianco, havendo de le carote cotte sotto le brascie, et mondate, levarai dextramente col coltello quella parte di sopra la quale ha il colore pavonazo, et quella mettirai in fondo del sacco in nel quale si cola la decottione de la gelatina, et tante volte reiterando gli buttirai sopra quello brodo bianco riscaldato al foco che habia molto bene preso il ditto colore».
Con le carote si poteva dare alla gelatina il colore «pavonazo», il viola, appunto. La carota viola inizia a declinare nel XVII secolo, quando viene direzionata verso l'alimentazione animale più che umana. Al suo posto inizia ad affermarsi quella gialla che poi, con l'avvicendamento di quella arancione, declina anch'essa. Con linguaggio odierno definiremo la carota arancione «carota definitiva». Ormai concepiamo la carota come arancione e anche nel momento in cui il commercio provi a reintrodurre le antiche colorazioni non incontra mai grandi successi.
Viola, gialla o arancione che sia, la carota addomesticata presenta una differenza fondamentale con quella selvatica, cioè i fiori. Acquistando carote fresche in mazzetto, magari in queste settimane, avrete certamente notato il ciuffo di foglioline in cima. La pianta produce le foglie durante il primo anno di vita. Soltanto nel secondo anno (al quale la carota domestica che mangiamo non arriva perché la raccogliamo ben prima per il consumo) quel ciuffo si espande in un un bel fusto eretto e ramificato che può arrivare fino a 2 metri di altezza e che culmina con l'infiorescenza a forma di ombrello, la declinazione floreale inusuale di cui sopra. La carota appartiene infatti alla famiglia delle Apiacee, anche dette Ombrellifere perché caratterizzate dall'ombrella, questa infiorescenza a grappolo composta, cioè, con ogni raggio dell'ombrella che non termina con un fiore, come sarebbe nell'infiorescenza semplice, ma con altri piccoli ombrelluli.
La pianta è trattenuta al suolo dalla radice, quel fittone con la forma di cono rovesciato che noi, appunto, estirpiamo e mangiamo. La carota selvatica, invece, restando interrata ben oltre i pochi mesi della carota coltivata a scopo alimentare, in cambio dell'espansione, che la parente «allevata» non conosce, «cede» la commestibilità: la radice diventa tanto legnosa quanto immangiabile. Tornando fuori dalla terra, l'ombrella della carota selvatica è una splendida costellazione vegetale di tanti deliziosi fiorellini bianchi a 5 petali, al centro preciso della quale stanzia un unico fiore di colore rosso intenso, quasi nero, e sterile: è un escamotage cromatico tramite il quale la pianta attira gli insetti impollinatori. Le ombrelle della nostra ricordano la Gypsophila paniculata, detta anche Nebbiolina o Velo da sposa, la pianta erbacea spesso usata per composizioni di fiori e sui capi delle spose.
Nel linguaggio dei fiori, i fiori della carota selvatica, un tempo regola dei panorami e non, come è oggi, rarità da cercare nelle città come gli uccelli quando si fa birdwatching, hanno sempre simboleggiato la felicità e la festa: secoli or sono, si usavano per decorare gli ambienti delle celebrazioni nuziali. I fiori della carota selvatica nel mondo anglosassone sono chiamati anche Merletto della regina Anna, prima del regno di Gran Bretagna: nella trasposizione, il fiore centrale è rosso come la goccia di sangue che cade dal dito che, lavorando un merletto con l'ago, si punga. La pianta è anche chiamata Nido di uccelli perché, dopo l'impollinazione dei fiori, l'ombrella si contrae su sé stessa per proteggere i semi che si stanno sviluppando. Quando lo sono, l'architettura dell'ombrella si secca e, da quell'apparente nido di uccelli che invece contiene semi, essi cadono nel terreno: i peli ispidi che li contornano servono per attraccarli a un sostegno, garantendo l'eventuale trasporto più lontano dalla pianta originaria anche sul pelo di un animale.
Finché l'uso della subspecies sativus non sostituì quello delle carote selvatiche, queste ultime erano apprezzate più come piante medicinali che alimentari. Con la parte aerea si tingevano le stoffe, le quali, grazie a flavonoidi e carotenoidi, diventavano gialle. Gli antichi Romani usavano anche i semi, come antidoto ad alcuni veleni. Nonché come afrodisiaco-anti impotenza, funzione per la quale, probabilmente, si era più suggestionati dalla forma della radice che non da precise conoscenze. Tuttavia, uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Fertility and sterility, «Semen quality in relation to antioxidant intake in a healthy male population», ha spiegato come la carota aiuti la fertilità maschile: consumare carote e altra frutta e verdura di colore arancione e giallo incrementerebbe la qualità dello sperma del 10%.
La nostra radice arancione presenta la stessa efficacia nei confronti dell'abbronzatura. Anche il rapporto della carota con l'abbronzatura non è soltanto una suggestione, cioè l'idea iperbolica di diventare arancioni «come» una carota. Se si esagera con l'assunzione di betacarotene, si può diventare veramente arancioni. Si tratta dello stesso principio che fa diventare arancione la carne del salmone: «Se mangiate troppe carote, apprezzate il fatto che il colore del cibo si rifletta nella vostra pelle. Il loro pigmento, il betacarotene, la fa diventare arancio. Analogamente l'astaxantina, pigmento naturale dell'alimentazione del salmone, anch'esso appartenente alla famiglia dei caroteni, rende arancio la sua carne», spiega La scienza della cucina. Tecniche, ingredienti e strumenti di Stuart Farrimond, Gribaudo editore. Il betacarotene stimola la produzione di melanina, sostanza che colora la pelle quando ci si espone al sole con lo scopo di proteggerla dai raggi ultravioletti. Per questa ragione le creme abbronzanti e protettive contengono betacarotene.
Conviene approfittare non solo di quello che si applica sulla pelle, ma soprattutto di quello che si assimila mangiando carote. Sia crude, sia cotte: si assimila betacarotene dalle carote crude nella percentuale del 4-5%, che aumenta fino a 5 volte se la carota è brevemente cotta. Il betacarotene, potentissimo antiossidante che contrasta anche la secchezza e la disidratazione, non è soltanto un protettore della pelle, ma anche del cuore e della vista: in collaborazione con la luteina mantiene la vista sana e favorisce la visione notturna.
La vitamina A, di cui il betacarotene è precursore, è idrosolubile e non viene danneggiata dalla cottura come avviene invece alla vitamina C, quindi l'ideale è alternare il consumo di carote crude e cotte, condendole con olio extravergine di oliva o altri grassi. Con le sue poche calorie, 35 ogni 100 grammi, i 91,6 grammi di acqua e i 3,1 grammi di fibre alimentari, le carote sono un cibo antiulcera, utile anche in caso di problemi intestinali di tipo diarroico e un ingrediente perfetto per chi voglia saziarsi senza rischiare di ingrassare. Non solo come contorno: sgranocchiate crude, senza condimento, sono un ottimo snack spezzafame quando si seguono diete e aiutano anche in caso di fame nervosa, perché sono impegnative da masticare e, in questo modo, scaricano l'ansia.
Ricche di altre vitamine oltre alla A (1.148 microgrammi), come la B, la C e la E, e di sali minerali, come calcio, fosforo, zinco e selenio, sono rimineralizzanti e toniche non solo della pelle, ma dell'organismo in generale. La carota contiene anche fruttosio: per quel sapore dolciastro ne facciamo anche succhi, centrifugati, confettura (per quanto la carota non sia frutta, ma ortaggio) e un dolce molto apprezzabile come la torta di carote.
Quanto alla salute della nostra economia, l'Italia è il quarto produttore europeo di carote, con una superficie dedicata di circa 11.000 ettari e una produzione di circa 500.000 tonnellate annue. Le nostre principali zone di produzione sono terreni sabbiosi di Alessandria, Chioggia, dei Lidi Ferraresi, Sabaudia, Maccarese, Oristano, il Fucino e Ispica: anche per non perdere posizione in una classifica nella quale non primeggiamo, dobbiamo ricordarci di comprare sempre carote italiane. Il primo produttore mondiale, infatti, è la Cina, con 17 milioni di tonnellate di produzione l'anno, seguita dall'Uzbekistan con quasi 2 milioni, la Russia con 1,7, gli Stati Uniti con 1,4 e l'Ucraina con 900.000.





