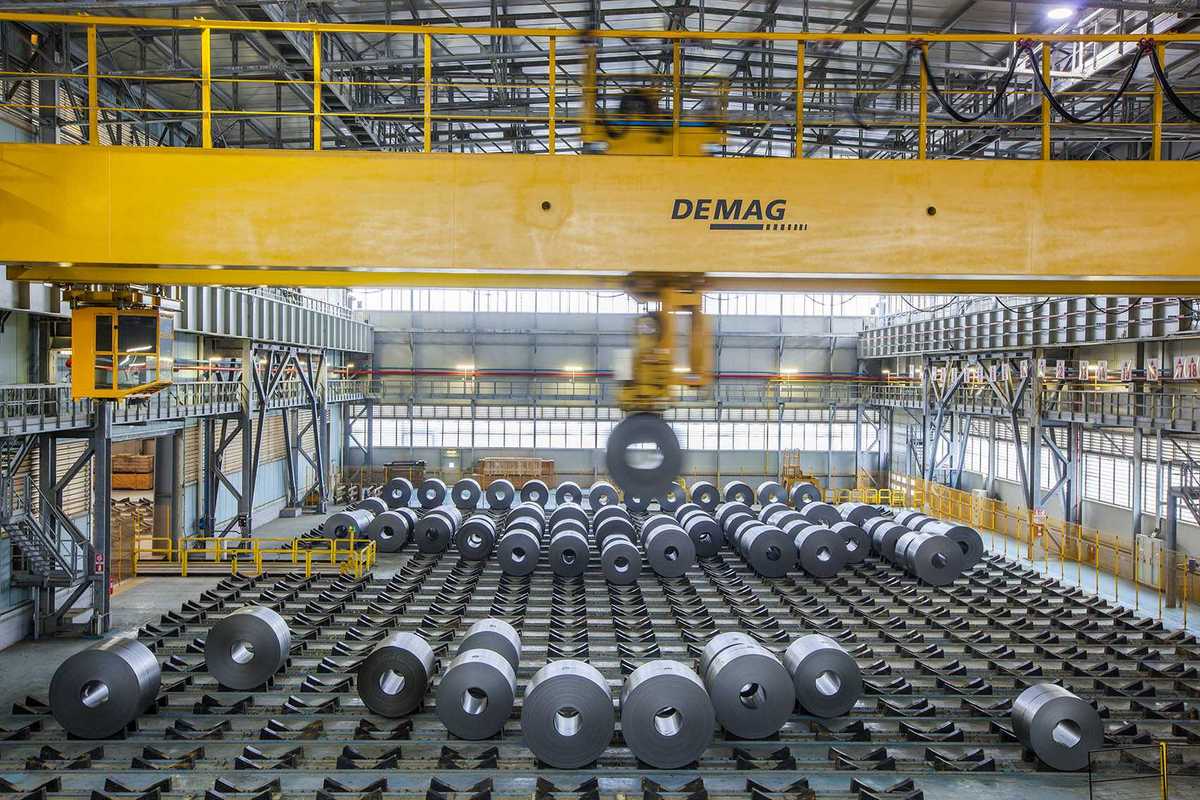Biden in pubblico mette Putin al muro. Ma poi gli lascia estrarre l’uranio Usa
- Il presidente fa la faccia cattiva con lo zar, però l'impresa canadese fresca di concessione in una miniera nel Wyoming è controllata da un'azienda di Stato russa. Il solito pragmatismo dem: per i soldi tutto fa brodo.
- Due compagnie telefoniche useranno la tecnologia 5G di Nokia e Ericsson. Intanto il Giappone si oppone ai tamponi anali cinesi.
Lo speciale contiene due articoli.
Il Wyoming apre ai russi sull'estrazione dell'uranio. Lo scorso 23 febbraio, il dipartimento della qualità ambientale dello Stato ha reso ufficialmente noto di aver approvato la richiesta di autorizzazione per l'estrazione di uranio, presentata da Uranium One: società mineraria canadese, controllata dall'azienda statale russa Rosatom.
La notizia ha un suo perché, soprattutto alla luce del fatto che, dal 20 gennaio, siede nello Studio ovale quel Joe Biden che, durante l'ultima campagna elettorale per le presidenziali, aveva avuto parole particolarmente dure verso la Russia di Vladimir Putin, dalle interferenze elettorali ai temi dei diritti umani (vedi caso Navalny). Parole condivise dalla maggioranza dello stesso Partito democratico americano. Ad agosto, la Speaker della Camera, Nancy Pelosi, aveva dichiarato che Mosca costituisse un pericolo maggiore di Pechino in materia di interferenze elettorali. Una posizione, questa, fatta propria anche dall'allora senatrice, Kamala Harris. Del resto, si tratta di una linea che lo stesso Biden ha recentemente ribadito durante la conferenza di Monaco sulla sicurezza: in quell'occasione, il neo presidente ha speso parole più dure sulla Russia che sulla Cina. Tutto questo, senza poi dimenticare la questione del Russiagate, cavalcata dai dem contro Donald Trump dal 2017 al 2019 e risoltasi poi sostanzialmente in una bolla di sapone.
Ecco: questa acredine nei confronti di Mosca non sembra (almeno per ora) emersa su una questione delicata come quella dell'uranio in Wyoming. Certo: va sicuramente sottolineato che, sulla concessione dei permessi minerari, i singoli Stati godano di un discreto margine di manovra. Tuttavia, come notato lo scorso settembre dal sito della World nuclear association, sul tema ha (più o meno) voce in capitolo anche la Nuclear regulatory commission: agenzia indipendente del governo statunitense, il cui nuovo presidente, Christopher T. Hanson, è stato designato dallo stesso Biden a fine gennaio. E comunque, a prescindere da ciò, se ci fossero state delle obiezioni dalla Casa Bianca, Biden avrebbe potuto far sentire in qualche modo la propria voce.
D'altronde, Uranium One era già balzata agli onori delle cronache nell'ambito di una polemica che, alcuni anni fa, aveva coinvolto alcuni settori del Partito democratico. Ricordiamo che l'azienda canadese venne gradualmente acquisita da Rosatom tra il 2009 e il 2013 e che, data la natura strategica dell'uranio, quell'acquisizione avrebbe dovuto ottenere l'approvazione di varie agenzie governative statunitensi (era d'altronde in gioco circa un quinto della produzione americana di uranio). Ora, tra i dicasteri coinvolti figurava anche il Dipartimento di Stato che - rammentiamolo - tra il 2009 e il 2013 fu guidato da Hillary Clinton. Ebbene, nell'aprile 2015, il New York Times riportò che, con il progredire dell'acquisizione, fossero pervenute delle donazioni dai vertici di Uranium One nelle casse della Fondazione Clinton. Tutto questo, mentre - nell'estate 2010 - l'ex presidente americano Bill Clinton, avrebbe ricevuto, per un discorso tenuto a Mosca, 500.000 dollari da Renaissance Capital: istituto bancario vicino al Cremlino, «che stava promuovendo l'azionariato di Uranium One». Certo: non è provato che quelle donazioni fossero legate all'acquisizione. Ed è pur vero che, insieme al Dipartimento di Stato, l'ok all'acquisto dovesse arrivare anche da altre agenzie, oltre al fatto che l'ultima parola l'avrebbe comunque avuta il presidente (che all'epoca era Barack Obama). Restano tuttavia connessioni e tempistiche un po' sospette. Senza dimenticare che Foggy Bottom fosse parte integrante del processo decisionale.
Tornando alla recente concessione del Wyoming, è improbabile - fatto salvo il caso di una specifica licenza della Nuclear regulatory commission - che l'uranio estratto da Uranium One possa lasciare gli Stati Uniti. Più plausibile è che sarà indirizzato al fabbisogno interno: lo Zio Sam importa d'altronde la maggior parte dell'uranio, che usa come combustibile per i reattori nucleari. Resta però il fatto che un'azienda controllata dai russi stia rafforzando la propria presenza sul suolo americano (Uranium One deteneva già il sito - fuori servizio dal 2018 - di Willow Creek, sempre in Wyoming). Tutto questo, mentre alla Casa Bianca siede un presidente che ha appena imposto sanzioni contro sette alti funzionari russi, accusati dell'avvelenamento dell'attivista Alexei Navalny. Ecco che dunque il silenzio di Biden sul Wyoming è doppiamente significativo. Non solo per le vecchie connessioni tra Uranium One e alcuni settori dell'establishment dem. Ma anche perché evidenzia una sorta di doppio binario su cui il presidente americano si sta muovendo nei suoi rapporti con la Russia. Alla severità in materia di diritti umani fa infatti da contraltare un atteggiamento spregiudicato su fronti come quello energetico. È quindi come se, al di là dello scontro che avviene in superficie, Biden lasciasse sotterraneamente aperto un canale con Mosca. Evidentemente non era solo Trump ad essere convinto che ai russi non andasse chiusa del tutto la porta in faccia.
In Francia inizia la stretta: via le antenne Huawei, al loro posto quelle Ue
Diverse città francesi, tra cui Tolosa, Tolone, Rennes e Brest, hanno iniziato a smantellare le apparecchiature 4G di Huawei dopo che a inizio febbraio il Consiglio costituzionale aveva confermato le norme cosiddette anti Huawei decise dal governo di Parigi per mettere dei paletti all'ingresso dell'azienda cinese nell'infrastruttura 5G del Paese.
Il Consiglio aveva respinto i ricorsi presentati da due operatori di telefonia mobile (Sfr e Bouygues Telecom) evidenziando come il Parlamento avesse approvato le norme con l'obiettivo di preservare gli «interessi della Difesa e della sicurezza nazionale». Dopo la sentenza, Sfr e Bouygues Telecom avevano chiesto indennizzi, esclusi immediatamente dal governo. Bouygues Telecom, inoltre, aveva spiegato che avrebbe dovuto così procedere alla rimozione di 3.000 antenne Huawei entro il 2028 in tutto il Paese.
Ed è quanto sta accadendo in queste settimane, come ha rivelato ieri Bloomberg. Bouygues Telecom e Altice (del gruppo Sfr) hanno iniziato a rimuovere anche le apparecchiature 4G di Huawei, diventate incompatibili dopo la decisione del Consiglio costituzionale in vista della realizzazione del 5G. La prima le rimpiazzerà con quelle della svedese Ericsson, la seconda con quelle della finlandese Nokia: il che va esattamente nella direzione indicata dal governo e dall'intelligence francesi che hanno auspicato la realizzazione del 5G facendo affidamento soltanto su fornitori europei. Quantomeno per la parte core, visto che, diversamente da quanto fatto dal Regno Unito, la Francia non sembra intenzionata a imporre un vero e proprio divieto per le aziende cinesi (Huawei ma anche Zte), accusate dagli Stati Uniti di spionaggio per conto della Cina (accuse sempre respinte e bollate come leva geopolitica).
Se Huawei avrà ancora un peso decisivo nel 5G europeo dipenderà soprattutto dalla decisione della Germania di Angela Merkel, dove il Bundestag sta discutendo una proposta del governo che prevede forti restrizioni ma non un veto.
Intanto, però, la rivolta anti cinese si allarga, anche in vista del G7 organizzato dal Regno Unito che vede i Sette (più Australia, Corea del Sud e India invitati come ospiti) impegnati a contenere l'ascesa, in particolare tecnologica e militare, di Pechino. Un segnale l'ha dato ieri il governo giapponese lamentando di non avere ancora ricevuto risposta dalla Cina in merito allo richiesta di stop ai tamponi anali effettuati ai viaggiatori giapponesi (un «grande dolore psicologico»). Il Giappone continuerà a reiterare la sua richiesta, fino a quando non verrà accettata e la pratica sarà interrotta, ha fatto sapere Tokyo criticando la pratica del governo cinese, che nelle scorse settimane aveva avuto frizioni con i diplomatici Usa contrari, anch'essi, alla pratica considerata una vessazione voluta da Pechino.