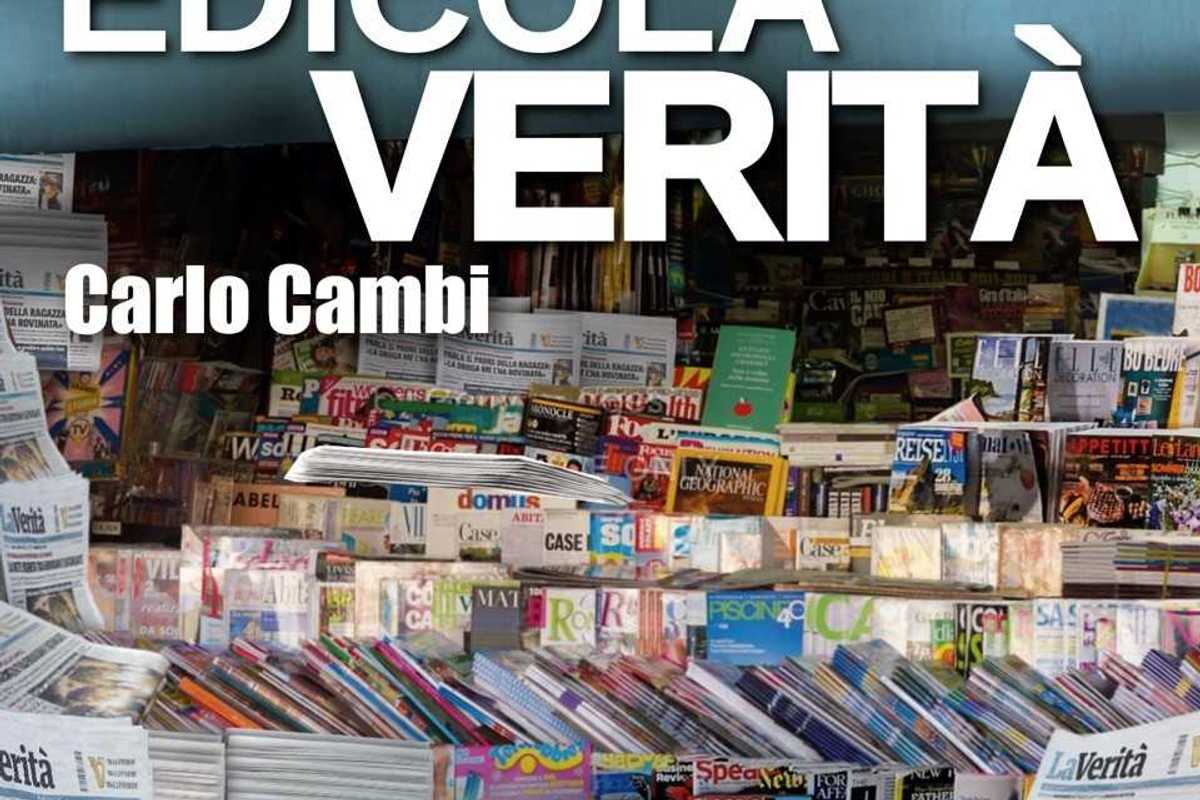L’inflazione rafforza i falchi pro austerità. Per l’Italia torna lo spettro Salvastati

Il consiglio direttivo della Bce nella riunione del 10 giugno ha all'unanimità deciso di proseguire nella sua politica espansiva con al centro il Pepp (programma di acquisto titoli da 1.850 miliardi che si aggiunge a quello varato da Mario Draghi nel 2015). Sono tuttavia di nuovo emerse due diverse scuole di pensiero. Da un lato i falchi secondo cui è il momento di iniziare a tirare i remi in barca rallentando le iniezioni di liquidità, visto che l'inflazione nell'Eurozona è già al 2%. Dall'altro le colombe, secondo le quali l'attuale aumento dei prezzi è da ritenersi transitorio e non è quindi il momento di restringere i cordoni della borsa. O comunque non prima di marzo del 2022; data di possibile chiusura del Pepp.
Concetto ribadito ancora due giorni fa dal presidente Christine Lagarde: «Finché i muscoli non tornano a posto e il paziente non cammina sulle sue gambe, non si accantonano le stampelle». E l'economia dell'Eurozona -nel suo complesso - «tornerà se tutto va bene ai livelli pre Covid nel primo trimestre del 2022», ha sottolineato il presidente della Bce. Economia dell'Eurozona «nel suo complesso», sottolineiamo noi. Perché nessuna delle attuali stime consente di dire che l'Italia tornerà al livello pre Covid neppure a fine 2022.
A questo punto si pongono due domande: chi ha ragione, i falchi o le colombe? E come finirà? Cominciamo dalla prima. L'aumento dei prezzi può avere diverse cause. L'economia che funziona a pieni giri con le famiglie che comprano è il classico caso di surriscaldamento. Il compito di un bravo banchiere centrale, in questa situazione, è quello di spegnere l'incendio; non certo di uccidere l'economia. Il sintomo inequivocabile è la piena occupazione che si raggiunge nel momento in cui il numero dei disoccupati arriva a un livello così basso da non poter ulteriormente scendere. In qualsiasi momento si scatterà la fotografia, vedremo dei disoccupati; coloro che in quel momento stanno appunto cambiando lavoro e si trovano in una temporanea «disoccupazione tecnica». Chiunque capisce che oggi non siamo in questa situazione. Pure il governatore della Banca centrale olandese ha ieri aperto alla necessità di una maggiore flessibilità nella politica di bilancio dei Paesi dell'eurozona. Rimane la Germania a far finta di non capire. Oppure i prezzi possono salire perché il costo delle materie prime o dei semilavorati (grano, petrolio, legname, acciaio) aumenta così tanto che i prezzi al consumo necessariamente crescono. E gli indizi che ci troviamo probabilmente in questa seconda situazione sono molti. I prezzi aumentano perché cresce il costo delle materie prime, non perché i consumatori si strappano i prodotti di mano. In entrambi i casi salgono, ma non è propriamente la stessa cosa.
Nella Bce è ora in corso una revisione della strategia di politica monetaria. Era dal 2003 che non veniva attuata. Anche sulla spinta di ciò che è stato deciso negli Usa, dove la Fed sta tollerando livelli di inflazione superiori al 2%; l'obiettivo esplicito di tutte le più importanti Banche centrali al mondo. Sulla base di una motivazione banale; avendo per anni sopportato un'inflazione inferiore al 2%, nessuno scandalo se per un po' supererà il limite. L'importante è che in media e per un numero congruo di anni si attesti intorno al 2%. L'economista Frederik Ducrozet ha fatto due conti. Se dal 2012 la Bce avesse centrato l'obiettivo di un'inflazione annuale del 2%, a fine 2020 i prezzi sarebbero stati mediamente superiori del 17% rispetto all'inizio. Ma poiché questo obiettivo non è stato centrato, i prezzi oggi sono mediamente superiori del 10%. Con un orizzonte temporale sufficientemente lungo - «all'americana» per intendersi - nel 2021 dovremmo registrare un aumento dei prezzi pari al 9% circa per tornare «in linea». Numeri da boom del Dopoguerra. Immaginatevi i tedeschi che tollerano tassi negativi con prezzi in aumento quasi a doppia cifra.
L'esercizio è teorico ma ci fa capire quanta strada potremmo ancora percorrere. Quindi, che succederà? Ha provato a disegnare uno scenario il capo economista di Unicredit Erik Fossing Nielsen, fra i più ascoltati e sicuramente non ascrivibile allo stormo dei cosiddetti falchi. Poiché il Pepp prima o poi finirà, scrive in sostanza Nielsen, dovremo tornare a convivere con una politica monetaria più normale. Anzi «convenzionale» per dirla in gergo. È però presumibile che gli spread tornino a crescere. Oggi - per darvi un'idea - anche il rendimento a cinque anni della Grecia è negativo. Solo l'Italia paga qualcosa su questa scadenza. La conseguente volatilità rischierebbe di minare l'efficacia della politica monetaria in tutta l'Eurozona; un'area del pianeta praticamente condannata all'eterno acquisto di titoli di Stato da parte della Bce pur di non far scoppiare l'incendio. Francoforte da aprile 2020 ha praticamente acquistato la quasi totalità del debito aggiuntivo emesso dai singoli Stati. Quando si è data meno da fare, ha acquistato poco più del 60%. Ora siamo intorno al 100%.
Che fare? Ma che domande. Torna di nuovo il Mes, che per l'occasione dovrebbe essere «senza condizioni» (certo, come no!) convertendo le linee di credito per l'emergenza pandemica che nessuno ha utilizzato (ma guarda un po'...). Il Mes dovrebbe garantire fino al 75% delle emissioni annuali dello Stato richiedente. Nel caso dell'Italia (esempio di Nielsen) parliamo di circa 350 miliardi di emissioni lorde. Da garantire in misura pari ad almeno 260 miliardi. Su una capacità complessiva di credito di 400. Verrebbe addirittura da rispondere con le parole del 2019 dell'ex ministro Roberto Gualtieri: «Ciò che ha salvaguardato l'integrità dell'eurozona è stata la capacità di iniziativa della Bce sintetizzata nel famoso “whatever it takes" […] a dimostrazione del fatto che quando si dispone di una potenziale sovranità monetaria questa è più efficace del conferimento di risorse ai vari fondi Salvastati». Lo capiva perfino lui.