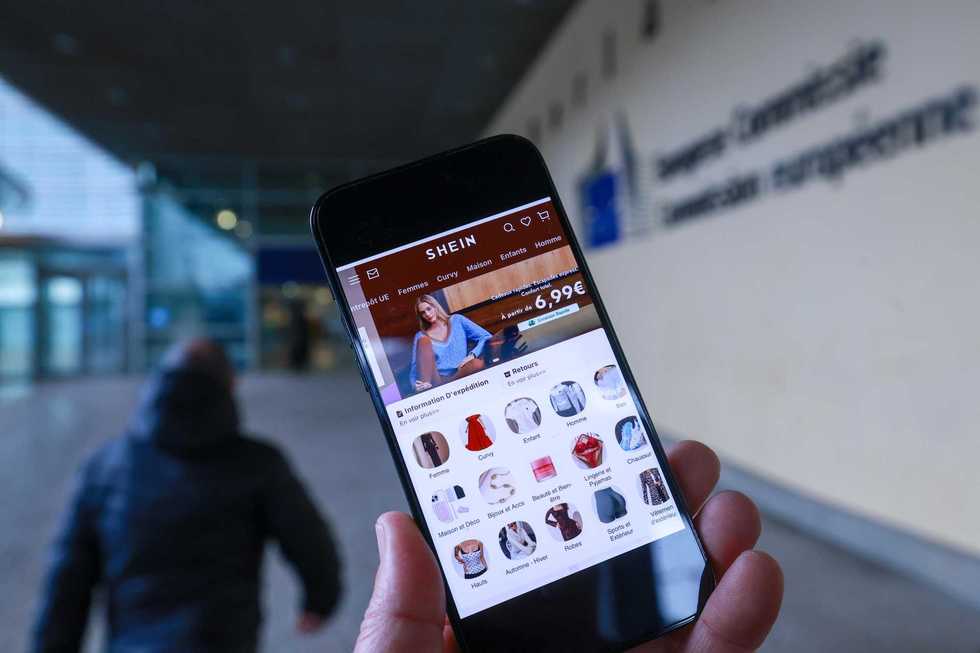2022-05-05
Battaglia legale Rcs-Blackstone,sei anni non bastano: rinviata la decisione di appello sul lodo

Il lodo arbitrale contro il fondo Blackstone
Non ci sono né vinti né vincitori nella battaglia fra Blackstone ed Rcs. Almeno per il momento. Nell’udienza di ieri il collegio ha rinviato la decisione sull’appello della casa editrice relativamente al lodo arbitrale contro il fondo Blackstone sull’accusa di usura nella compravendita dell’immobile di via Solferino.
A New York, invece, tutto tace anche se i legali di Rcs sono convinti che ci sia un difetto di giurisdizione dal momento che nessun pezzo della storia è avvenuto negli Stati Uniti. Così anche il titolo della casa editrice del Corriere della sera è rimasto, per così dire, sospeso attorno alla parità ( +0,27% a 0,74 euro). Nonostante i buoni risultati della casa editrice, anche il mercato attende infatti di conoscere quale sarà la sorte del gruppo su cui pende la richiesta di un maxi-risarcimento (300 milioni, oltre ad altri 300 richiesti al numero uno Urbano Cairo) da parte del fondo americano. Ci vorrà ancora del tempo quindi prima che il collegio presieduto da Carla Raineri e i consiglieri Caterina Apostoliti e Rossella Milone decida il da farsi. Esattamente come a New York, tribunale al quale si è rivolto il fondo Blackstone per ottenere il maxirisarcimento.
Eppure gli anni sono volati da quando tutta questa storia è iniziata. Correva l’anno 2013. Ed Rcs non era certo in buono stato di salute. La casa editrice aveva ristrutturato il debito ottenendo un finanziamento da 575 milioni da un pool di banche. Ma doveva anche provvedere ad una ricapitalizzazione da 400 milioni e alla cessione di alcuni asset. In particolare, l’allora amministratore delegato di Rcs, Pietro Scott Jovane, decise di cedere il complesso immobiliare di via Solferino, sede del Corriere della Sera. Nonostante l’opzione non convincesse a a pieno tutti i soci, l’immobile venne venduto al fondo Blackstone per 120 milioni. Tuttavia, allo stesso tempo, venne firmato un accordo di locazione con il fondo. L’intesa prevedeva che la casa editrice versasse 10,3 milioni di affitti per i suoi ex immobili per almeno due anni. Con un canone che era pari all’8,5% di quanto incassato. La questione fece subito gridare allo scandalo i giornalisti del Corriere il cui comitato di redazione definì fuori luogo un affitto che superasse la soglia del 7%. Anche perché «un mutuo ipotecario costa oggi a chi lo contrae all’incirca il 3% lordo» chiarirono i giornalisti all’epoca dei fatti. L’operazione trovò peraltro contrari sia Cairo che il socio Diego Della Valle. Ma venne comunque realizzata sulla scia delle necessità finanziarie del gruppo.
E proprio sulle «necessità» dell’epoca che poi Cairo ha impostato la sua battaglia contro il fondo Blackstone sostenendo il caso di usura. Ipotesi però scartata nel lodo arbitrale che, pur valutando basso il prezzo cui avvenne la compravendita immobiliare (stimato a 153 milioni contro il prezzo effettivo pagato di 120), non ritenne opportuno attribuire un risarcimento ad Rcs. Dal punto di vista di Cairo l’operazione non avvenne ad armi pari, come spiegò nel 2016 quando decise di attaccare Blackstone nell’intento di riequilibrare la partita a suo vantaggio. Ma la battaglia legale finì col pregiudicare il passaggio di mano dell'edificio da Blackstone ad Allianz, facendo sfumare anche la relativa plusvalenza. Di qui la maxirichiesta risarcitoria di Blackstone nei confronti di Rcs e dello stesso Cairo per un totale di 600 milioni. Gli investitori sanno bene che la richiesta è decisamente elevata visto che l’intera capitalizzazione della casa editrice si aggira attorno ai 380 milioni. E, in caso di vittoria americana, potrebbe persino mettere in discussione gli attuali assetti proprietari del gruppo editoriale che intanto, nella gestione Cairo, ha recuperato terreno. Lo testimonia un 2021 con ricavi consolidati 2021 a 846,2 milioni (+96,7 milioni rispetto al 2020) e un utile netto da 72,4 milioni, più del doppio rispetto ad un anno prima.
Continua a leggereRiduci
(iStock). Nel riquadro, il libro di Luca Ciarrocca, «L'anima nera della Silicon Valley»
In un libro la storia di come la sua «Palantir» per anni abbia fornito dati alle forze dell’ordine in stile «Minority report».
L’esperimento ha un nome in codice, Operazione Laser, e per quasi dieci anni, dal 2011, trasforma Los Angeles in un banco di prova continuo per la polizia predittiva. La scena si ripete ogni giorno. Un agente apre il «Chronic Offender Bulletin» generato da Gotham, il software che Palantir - l’azienda di Peter Thiel - ha fornito al comune di Los Angeles e che setaccia i database del dipartimento di Polizia in cerca di arresti, affiliazioni a gang, persino semplici contatti con gli agenti, e assegna un punteggio di rischio a centinaia di persone. Ne esce una lista quotidiana di nomi e volti. La direttiva è trovare questi individui, fermarli, interrogarli e, se serve, arrestarli. La base dell’intervento, in sostanza, è una stima di rischio calcolata dal sistema.
Il software di Palantir promette alla polizia ciò che finora apparteneva alla fantascienza e alle trame di film come Minority Report: usare l’analisi predittiva per scongiurare i reati prima che vengano commessi. L’idea arriva proprio dal racconto di Philip K. Dick del 1956, esploso poi con il film di Steven Spielberg del 2002. In quella storia tre precognitivi, Agatha, Arthur e Dashiell, fluttuano nel «Tempio», il cuore del dispositivo. Tom Cruise è John Anderton, capo della sezione PreCrime di Washington, e la sua squadra, guidata dalle visioni dei tre sensitivi, blocca gli omicidi giusto un attimo prima dell’atto arrestando i potenziali assassini. A Los Angeles il precog prende la forma di un algoritmo, Gotham. Il copione distopico immaginato da Dick, un apparato che sposta il bersaglio dalle azioni alle intenzioni, diventa un protocollo operativo di polizia, come detto, dal 2011. Anni dopo, diverse inchieste giornalistiche e la pressione dei gruppi per la difesa dei diritti civili mostreranno che i dati utilizzati sono spesso imprecisi e pieni di pregiudizi, e il programma verrà cancellato. Per un lungo periodo, però, la città californiana lo mette alla prova sul campo. [...]
Quando al Los Angeles Police Department (Lapd) viene presentata per la prima volta, la proposta di Palantir suona allettante. Il dipartimento firma un accordo e da lì nasce Operazione Laser. L’acronimo, Los Angeles Strategic Extraction and Restoration, dal tono quasi militare, dice tutto. Dall’intervento degli agenti dopo un crimine, si passa alla selezione preventiva dei soggetti ritenuti a rischio, «estratti» dal tessuto sociale prima che agiscano. Minority Report è realtà. Per evitare la trafila degli appalti pubblici con obbligo di trasparenza, Thiel e l’amministratore delegato Alex Karp donano Gotham al Lapd tramite la Los Angeles Police Foundation, un’associazione non profit. In tal modo, il software entra in servizio senza un vero dibattito pubblico. L’operazione parte come pilota nelle divisioni urbane con più reati, come la Newton Division, e negli anni successivi si allarga ad altre zone, Hollywood compresa.
L’architettura dell’Operazione LASER è un meccanismo di profilazione automatizzato. Un’inchiesta di «BuzzFeed News», basata su centinaia di pagine di documenti interni del dipartimento di Polizia losangelino, ha svelato la logica del sistema. Gotham funziona come un collettore di dati. Vi vengono riversati i classici dati «duri», come arresti e condanne, ma soprattutto, e per la prima volta, un universo di informazioni «soft», ambigue e discrezionali, come le note compilate dagli agenti durante i fermi per strada, le cosiddette «schede di intervista sul campo», che spesso non portano ad alcuna accusa formale. A queste si aggiungono le affiliazioni a gang, reali o presunte, e l’intera rete di contatti personali e familiari di un individuo. Il software aggrega questi frammenti, trasformando informazioni non verificate in fattori di rischio, e produce il suo verdetto. Il sistema è a punti, con regole che non saranno mai rese pubbliche. A ogni persona è attribuito un punteggio, una traccia digitale che ne orienta il destino. Un arresto per crimine violento vale cinque punti, l’affiliazione a una gang, anche solo presunta, altri 5, come anche essere in libertà vigilata. Ma il vero moltiplicatore è altrove: anche un fermo con identificazione in una «zona calda» della città aggiunge punti, innescando un circolo vizioso in cui la sorveglianza genera altra sorveglianza. Chi supera una certa soglia di punteggio viene etichettato automaticamente come chronic offender. Il nome, il volto, l’indirizzo, la patente, la targa dell’auto e l’intera rete di contatti finiscono nel grande database di Gotham. Una lista di proscrizione aggiornata giorno per giorno.
Qui emerge chiaramente il nodo che inceppa ogni sistema di polizia predittiva: Palantir presenta Gotham come strumento neutrale, basato solo sui dati. Il Lapd, a sua volta, descrive l’Operazione Laser come un programma infallibile, libero dai pregiudizi. I riscontri sul campo, però, raccontano altro. L’algoritmo non è imparziale, perché viene addestrato su dati che riflettono la storia del dipartimento. Per decenni, la polizia di Los Angeles ha concentrato controlli e arresti nei quartieri «difficili» a maggioranza nera e ispanica. Gotham assorbe quella storia e la riproduce. In pratica, non prevede il crimine, ma indica dove la polizia avrebbe in ogni caso continuato a cercare, catalogando persone - in stragrande maggioranza giovani maschi - dentro quelle comunità. Ne esce un circolo vizioso: Gotham rispecchia e amplifica i pregiudizi del Lapd, dando loro una patina di scientificità, perché i dati arrivano da anni di pattugliamenti concentrati nelle aree povere a rischio. Il software di Palantir finisce insomma per legare il crimine a certi codici postali e a determinati gruppi demografici. Così, le liste dei chronic offenders contengono gli stessi nomi; le pattuglie, guidate dalle indicazioni, tornano nelle stesse strade; nuovi fermi e arresti rientrano nel sistema e rafforzano le «previsioni». Risultato: la pretesa e sbandierata oggettività finisce per fare da alibi a una pressione continua e opprimente su comunità già marginalizzate.
Continua a leggereRiduci
Peter Thiel (Ansa)
L’imprenditore-filosofo Peter Thiel, patron di Palantir, è un uomo chiave per il suo legame fortissimo con J.D. Vance.
Lo diceva magnificamente Baudelaire: il più bel trucco del diavolo è far credere che non esiste. Ebbene, quanto di demoniaco c’è nella nuova frontiera delle Big tech e dei suoi protagonisti? Tanta, troppa. Ma molti vogliono farsi vedere, da Zuckerberg a Musk che addirittura avevano in animo di sfidarsi al Colosseo in un delirio tra videogame e presunzione.
Tra questi padroni della sorveglianza, però, ce ne è uno che è il più perfettamente demoniaco secondo la definizione del poeta maledetto. Si chiama Peter Thiel ed è il patron di Palantir. A lui Luca Ciarrocca ha dedicato l’imperdibile L’anima nera della Silicon Valley, un libro mappa per conoscere quest’uomo che non si vede ma c’è dove bisogna esserci. Peter Thiel è invisibile nel potere della Casa Bianca perché ha il suo uomo, ossia J.D.Vance, il vicepresidente che è Maga ma è soprattutto il rappresentante di questo nuovo Credo che riporta al panopticon di Bentham; Peter Thiel è invisibile ma presente nella finanza che aggredisce il potere delle carte di credito con la rivoluzionaria PayPal (creata in tandem proprio con Elon Musk); Peter Thiel è invisibile e presente nelle evoluzioni di Facebook e di Airbnb. Ma soprattutto Peter Thiel è invisibile nel più potente network di controllo, quello che ruota attorno a Palantir e che per dirla con Ciarrocca «trasforma i dati nell’infrastruttura strategica del nostro tempo: dall’analisi dei sistemi sanitari alla sicurezza della sorveglianza basate sulla predizione dei crimini (stile Minority Report), fino ai teatri di guerra come Gaza».
Il più bel trucco di Thiel è far credere che non ci sia pericolo, che non ci sia nulla di demoniaco nel senso delle tentazioni del diavolo quando con l’inganno e la manipolazione ci induce a pensare che tutto porti a una vita migliore, più sicura e più tutelata. Insomma, tutto avverrebbe per il nostro bene. Non è così, perciò occorre conoscere a fondo la meccanica del capitalismo della sorveglianza come lo ebbe a definire la Zuboff (altri libri importanti arrivano da Morozov o dal nostro Chiusi, dal Careless People della Wynn-Williams alle analisi di Benanti o di Venanzoni) perché maggiore è il potere che concediamo a questa potentissima élite e maggiore è la compressione delle nostre libertà, del nostro libero arbitrio. Ciarrocca ha il merito di una scrittura scorrevole e della scelta narrativa: gli snodi della vita di Thiel sono raccontati come un romanzo e non è difficile - sempre che siamo aperti alla conoscenza - mettere a fuoco la rete di potere che intreccia Vance o Epstein, la grande finanza e il Pentagono.
Lui, l’«anima nera» della Silicon Valley, è il campione della nuova generazione delle Big Tech, la cui forza politica e finanziaria non è seconda alle potenze statali. Mentre noi discutiamo degli equilibri del nuovo ordine mondiale, delle nuove reti di alleanze, c’è un secondo livello non meno esplosivo poiché incide similarmente sui diritti e sulle libertà delle persone.
Se pensiamo che dietro la Ia o dietro lo sviluppo degli umanoidi non ci sia un progetto «politico» oltre che industriale, allora non abbiamo capito nulla dell’epoca che stiamo vivendo. Quella che viene spacciata per libertà è, nel nuovo paradigma della Silicon Valley, l’uso strumentale dei nostri dati. Poche settimane fa il fondatore di Anthropic Dario Amodei ci ha messo in guardia sul pessimo crinale dove hanno infilato il mondo. E se lo dice lui…
Continua a leggereRiduci
«Creatives» (Amazon Prime Video)
La serie di Amazon Prime Video racconta l’ascesa e la caduta di un’agenzia fondata su autonomia e benessere, ispirata al caso Velvet Media. Sei episodi che scelgono il registro dell’idealismo, lasciando sullo sfondo le ombre e le contestazioni emerse dalle cronache.
Quella di Velvet Media non è una storia semplice. Ha ombre a sufficienza da oscurare ogni più piccola luce. Vecchi dipendenti dell'agenzia di comunicazione, nata a Castelfranco Veneto con la promessa di sovvertire le regole alla base del lavoro dipendente, hanno giurato di aver riportato traumi permanenti. Niente che la psicoterapia sia riuscita a risolvere.
Avrebbero perso la salute, il sonno. I propri, legittimi proventi. Eppure, nonostante l'ambiguità del caso, nonostante le rimostranze di chi lo ha vissuto sulla propria pelle, Amazon Prime Video ha deciso di proporre una narrazione diversa di quel che è accaduto a Velvet Media.
Di intessere una trama romantica, corredata di sliding doors dall'esito felice. Creatives, serie televisiva cui è stato affidato il compito di rileggere l'intera vicenda senza mai farvi accenno diretto, nasce per dare forma all'ipotesi che sia una buona intenzione all'origine del tutto. Un'idea pura, quella di anime decise a creare un ambiente di lavoro basato sul rispetto e la comprensione delle persone che ne siano coinvolte.
Creatives, al debutto sulla piattaforma streaming venerdì 20 febbraio, torna nella provincia di Treviso, tra le sue strade strette. Torna a un gruppo di giovani, che, senza troppo badare agli esiti dell'impresa, specie a quelli nefasti, ha deciso di mettere in piedi un'agenzia sui generis, regalando ai propri dipendenti la più totale autonomia. L'agenzia di cui racconta la serie televisiva, non aveva un orario di lavoro. Ciascuno era libero di autogestirsi. C'era uno psicologo a disposizione dei lavoratori, un'attenzione rara al benessere delle persone. C'era la piena convinzione di come la felicità fosse condicio sine qua non per ottenere produttività. E c'era, pure, una sorta di prova empirica rispetto alla validità del metodo. In poco tempo, l'agenzia è cresciuta, e con lei il numero dei dipendenti, arrivato a superare il centinaio. Sembrava tutto funzionasse, specie l'idea che le persone potessero valere più dei numeri, delle regole. Ma, come spesso accade, la realtà ha fatto presto irruzione nel castello di sogni, svelandone le crepe, le ombre, le fragilità. Complice la pandemia, l'agenzia di cui racconta la serie tv di Amazon Prime Video s'è fermata. Una battuta d'arresto dolorosa e violenta, che, nell'economia del racconto, non ha tolto all'esperimento umano il suo romanticismo.
Creatives, in sei episodi, documenta gli sforzi del gruppo, il colpo di reni per rialzarsi, più forti di prima. Tace il resto, però: quello che le cronache hanno riportato, la disillusione di chi lì dentro ha lavorato, di chi giura di essere stato preso in giro. Tace e il confine rimane labile, sospeso tra verità giudiziaria e narrazione televisiva.
Continua a leggereRiduci