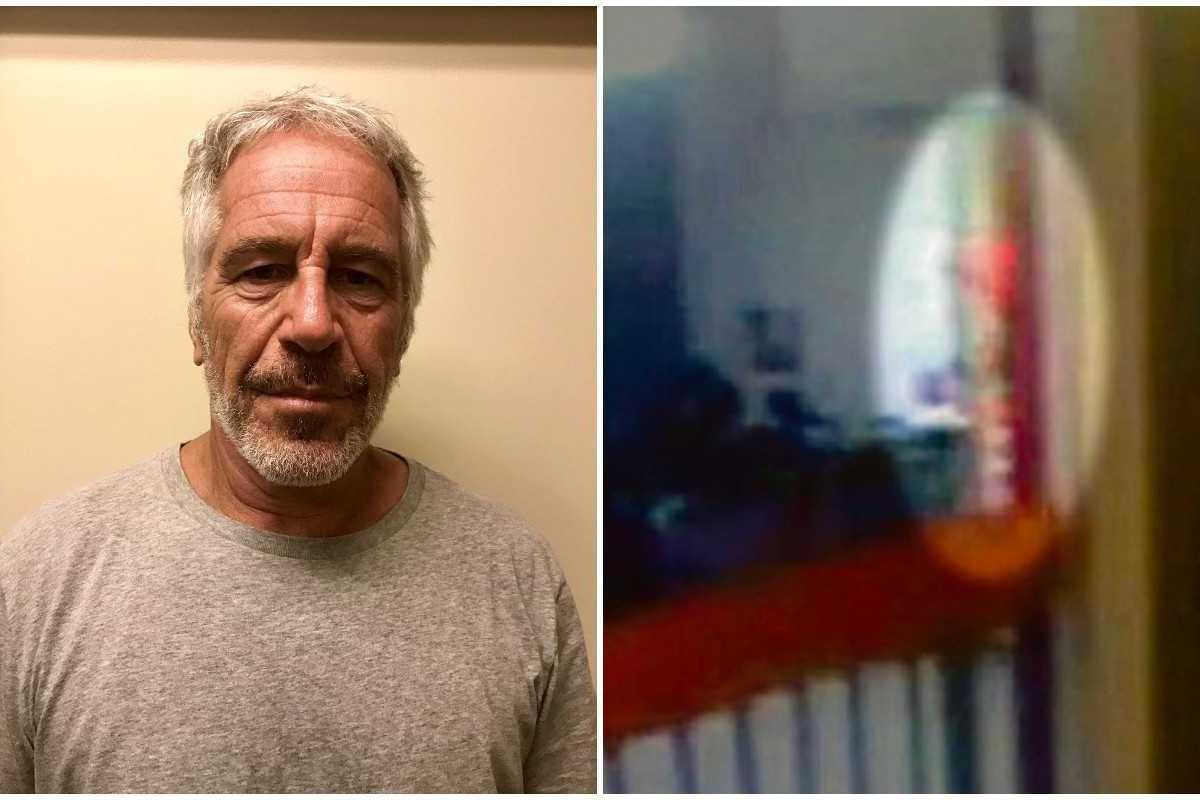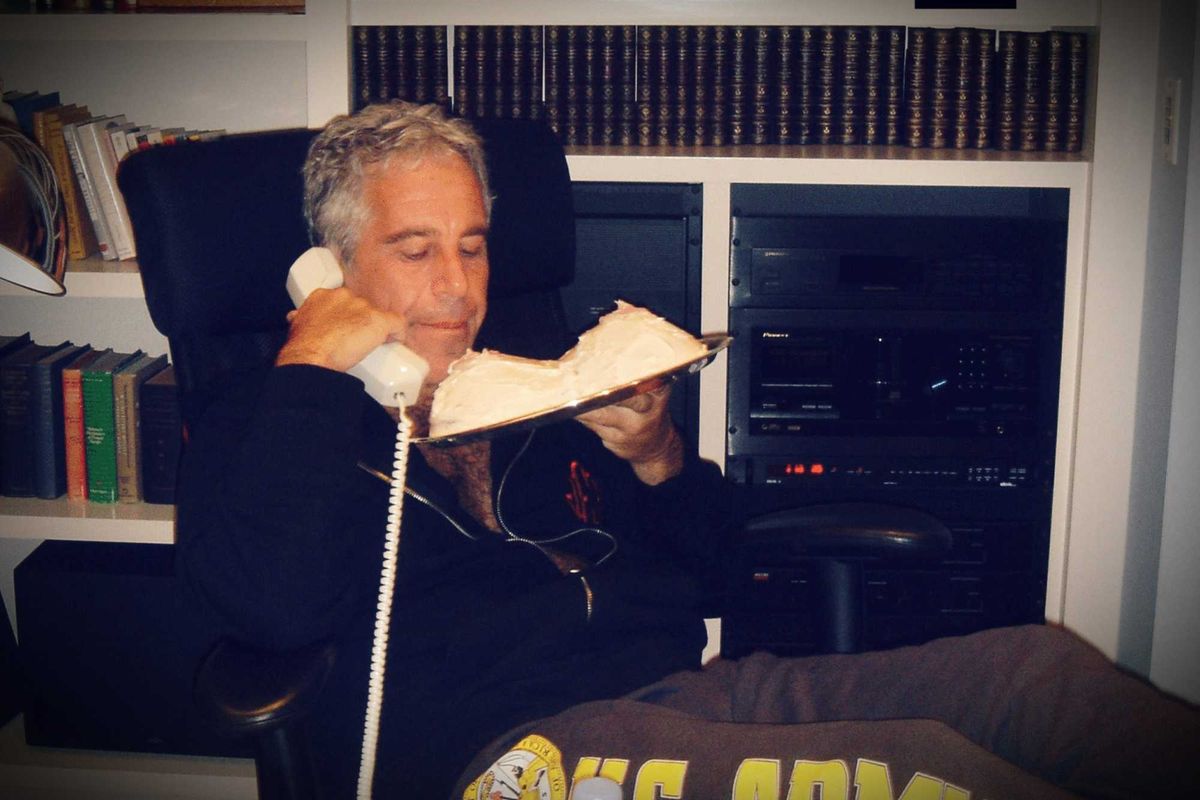Mentre i risparmiatori piangono, la Banca d'Italia ride. Il governatore di via Nazionale ieri ha infatti comunicato i dati di bilancio del 2017, annunciando - udite udite - che lo scorso anno l'istituto ha ottenuto «il risultato più elevato mai raggiunto prima». In soldoni fanno 3,9 miliardi di utile netto, mica spiccioli. Facendo la ruota come un pavone, Ignazio Visco ha spiegato che «il margine d'interesse è quasi raddoppiato rispetto al 2008, sfiorando gli 8 miliardi».
L'anno scelto per il confronto ovviamente non è casuale: essendo stato nominato nel 2011, in piena crisi economico-finanziaria, all'epoca il numero uno della banca non era ancora al timone dell'ente che governa sugli istituti di credito, ma ricopriva l'incarico di semplice capo dell'ufficio studi. Traduzione del messaggio: da quando c'è lui l'utile è esploso. Certo, il governatore ha precisato che «le misure di politica monetaria di natura straordinaria hanno determinato un aumento consistente del reddito della banca, nonostante i bassi tassi di interesse», ma il risultato non cambia. Nonostante sia il frutto straordinario del quantitative easing, ovvero dell'immensa liquidità pompata da Mario Draghi nel sistema, l'utile se lo intesta chi firma il bilancio, cioè Visco. Dell'utile boom sarà particolarmente grato il governo, perché la Banca d'Italia staccherà al ministero dell'Economia una sostanziosa cedola. Già, gran parte dell'utile se lo papperà lo Stato sotto forma di dividendi (circa 3,3 miliardi) e tasse. In totale fanno quasi 5 miliardi, 1,5 in più rispetto allo scorso anno, quando via Nazionale registrò un risultato da record. Mettendo insieme le cifre in positivo conseguite dal 2015 a oggi, si scopre che l'istituto guidato da Visco ha collezionato utili per un valore di quasi 10 miliardi. Mica noccioline. Questo mentre i risparmiatori che hanno investito il loro denaro negli istituti di credito li hanno visti sparire in una voragine che si è allargata sempre di più. Mps, Banca Etruria, Banca Marche, Carichieti, Cariferrara, Veneto Banca, Popolare di Vicenza, il buco che ha inghiottito i soldi di molti italiani ha lasciato senza speranza chi aveva sottoscritto azioni e obbligazioni. Eppure fino a pochi anni fa, dal ministero dell'Economia e anche dalla Banca d'Italia arrivavano messaggi tranquillizzanti. I nostri istituti di credito sono più sicuri degli altri, ripetevano a raffica: a differenza delle banche straniere, non hanno spinto l'acceleratore sull'internazionalizzazione e nemmeno si sono lanciate in operazioni finanziarie spericolate, con strumenti complessi. Dunque, concludevano, possiamo dormire sonni tranquilli.Quanto ci fosse di vero negli appelli rasserenanti lo abbiamo scoperto di lì a poco, quando le banche - piccole e grandi - hanno cominciato a cadere come birilli. Anche senza essersi spinti all'estero (forse per la cronica carenza di dirigenti che sapessero leggere e conversare in inglese), anche senza essersi avventurati in investimenti a rischio, gli istituti di credito si sono trovati con il fiato corto a causa dei parametri imposti dalla Bce e dai molti prestiti fatti ad amici degli amici senza alcuna garanzia.Risultato, in tre anni sono andati in fumo 4,3 miliardi investiti in obbligazioni, 18 miliardi di valore azionario e il salvataggio allo Stato, cioè a tutti i contribuenti, è costato la bellezza di 22 miliardi. Insomma, un disastro. Da cui certo la Banca d'Italia non può chiamarsi fuori lavandosene le mani. Per quanto Ignazio Visco abbia cercato di autoassolversi durante le audizioni disposte dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sui crac degli istituti di credito, le colpe della vigilanza sono evidenti. Se una banca occulta le perdite nelle pieghe di bilancio, i soli a poterlo sapere sono gli ispettori di via Nazionale, non certo i risparmiatori. Se i banchieri fingono di rafforzare il patrimonio finanziando senza garanzia chi compra le loro azioni, gli unici che hanno la possibilità di scoprirlo sono i funzionari di Visco, non i clienti. Dunque, se si sono bruciati tutti quei soldi le responsabilità vanno adeguatamente ripartite fra chi sedeva in consiglio di amministrazione, fra i politici che tenevano bordone ai banchieri, ma anche tra chi, per dovere, doveva tenere gli occhi aperti e invece li ha chiusi. Per questo credo che quei 3,9 miliardi di utile conseguiti dalla Banca d'Italia non dovrebbero essere spartiti fra i soci sotto forma di dividendo ma, almeno in parte, dovrebbero essere restituiti ai 400.000 risparmiatori che hanno perso tutto e non hanno ottenuto niente, se non le briciole. Visco non può celebrare l'utile record raggiunto da via Nazionale senza ricordare il record in negativo della liquidità bruciata sotto la sua gestione. Quindi, metta mano al portafogli. Altrimenti, se non vuole, metta mano alla penna per firmare le scuse e sparire.