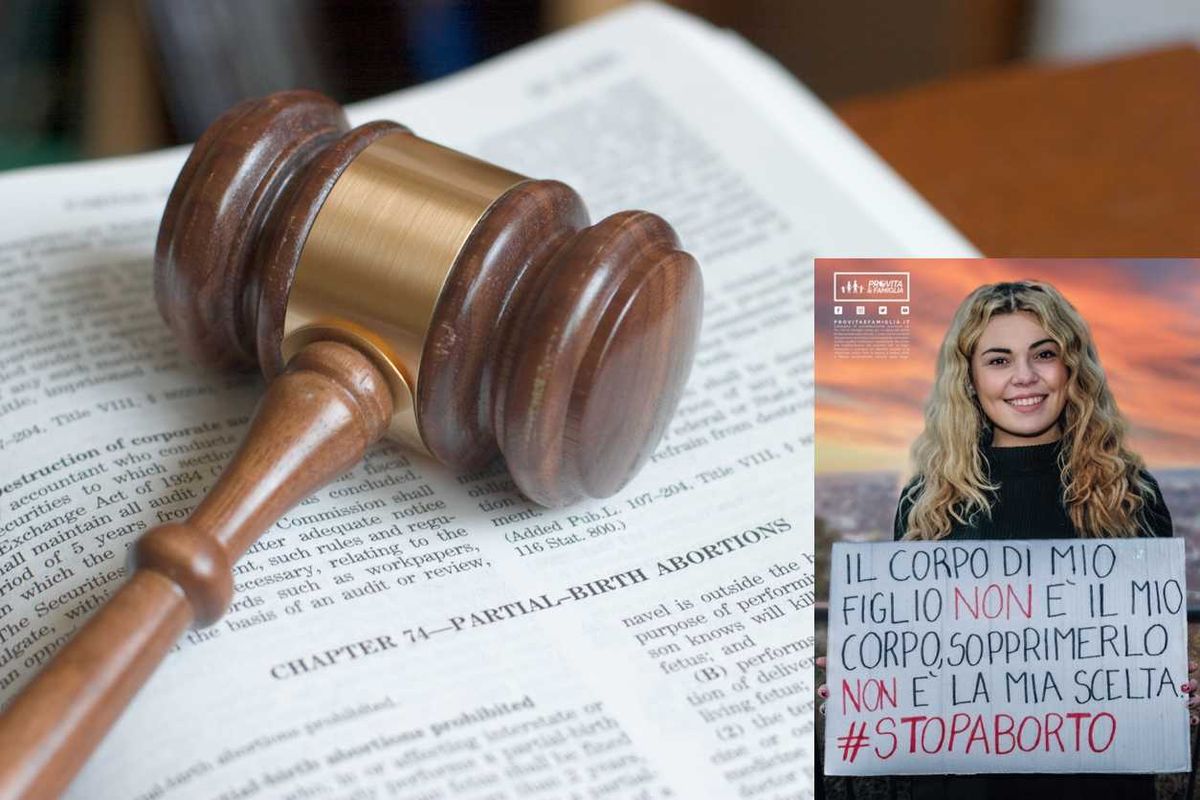I test sierologici? Non servono a nulla. E dunque ne stiamo comprando 150.000. Sono inattendibili. E dunque ne faremo i pilastri della fase due. Non ci possono dire se una persona è davvero immune. E quindi saranno la base per concedere la patente di immunità. L'ultimo caos nella gestione dell'emergenza coronavirus raggiunge sublimi vette di assurdità: alle opinioni diverse tra scienziati ci siamo purtroppo abituati, alle indicazioni contraddittorie su tamponi e mascherine ci abbiamo fatto il callo, sentire un virologo che un giorno dice bianco e il giorno dopo, con la stessa sicumera, dice nero è diventata prassi quotidiana. Ma avere rappresentanti delle istituzioni che nello stesso momento affermano tutto e il contrario di tutto rispetto a quella che dovrebbe essere l'arma decisiva per passare alla ormai attesissima fase due è sconfortante. E dimostra purtroppo che la ripartenza rischia di essere gestita persin peggio dell'emergenza, che pure è stata gestita malissimo. Tutto in mano a un unico comandante: il Generale Confusione.
Il punto della discordia sono gli ormai stracitati test sierologici, quelli che servono a verificare se una persona ha sviluppato gli anticorpi (immunoglobuline Igm e Igg), avendo contratto il coronavirus in tempi più o meno recenti. Perché si è cominciato a parlare di questi test? Semplice: perché non è possibile fare il tradizionale tampone a tutti, dal momento che le procedure sono troppo lunghe e costose, e i reagenti scarseggiano. Gli esami sierologici (che si possono fare con normale esame del sangue o con il più semplice pungidito) non sostituiscono il tampone, cioè non possono essere usati per individuare i malati e diagnosticare la cura, ma potrebbero essere utilizzati per dare la cosiddetta «patente di immunità», cioè per capire se una persona ha già contratto il Covid-19 e ne è guarita, diventando così inattaccabile, incapace di infettare e di essere infettata (almeno per qualche mese). A queste persone, si è detto, si potrebbe dare la possibilità di rientrare al lavoro per cominciare a far ripartire l'economia.
Se i test sierologici siano attendibili o no non spetta certo a me dirlo. Capisco il dibattito in corso e le divergenze d'opinione. Ma quello che si può e si deve pretendere è che, se davvero si pensa di usare questi come strumenti per dare il via alla cosiddetta fase due, a questo punto si abbiano idee chiare. E che si sia in grado di dare indicazioni precise su come farli funzionare. Per esempio: quali scegliere? Quelli pungidito sono da scartare? Fra gli altri ce ne sono di più attendibili? E poi: si usano da soli? O sono solo uno strumento per selezionare persone da sottoporre poi a tampone tradizionale? Ci vorrebbe, giunti a questo punto, un protocollo da seguire, una strada tracciata, un'indicazione certa. Invece, come dicevamo, nell'Italia dell'emergenza regna il caos: i prodotti si moltiplicano, le farmacie vendono i kit, i laboratori privati li eseguono attirando clienti, le aziende li comprano, alcuni Comuni sperimentano, alcune Regioni procedono con acquisti massicci, ma di linee guida non ne esistono. Ci sono oltre duecento tipi di test diversi, senza nessuna indicazione chiara su quali siano più o meno attendibili. E senza soprattutto che nessuno dica chiaramente come devono essere usati, che effetti avranno, in che modo, insomma, potranno agevolare la riapertura della nostra vita sociale ed economica, che è poi l'unico e vero obiettivo che dobbiamo porci.
L'altra sera, poi, si è raggiunto l'apice del paradosso. Alle 18, infatti, durante la tradizionale conferenza stampa contamorti della Protezione Civile, l'inevitabile domanda sui test sierologici è stata rivolta a Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto Superiore della Sanità. E quest'ultimo è parso quasi infastidito. In modo sprezzante ha definito la questione un «tormentone», poi si è avventurato in un pistolotto confuso dal quale però è emerso chiaro il suo convincimento: «A oggi patenti di immunità con i test sierologici è difficile darne». Certo, ha aggiunto, la situazione è in continua evoluzione ma comunque (cito testualmente) «quand'anche ci sarà un domani la possibilità di avere test più precisi, per il motivo di quantità di suscettibili presenti, questo è un fatto che influisce pesantemente sulle scelte che dobbiamo fare a livello di collettività». Supercazzola con scappellamento a destra per dire: io non credo che possa funzionare né oggi né domani. Sicuramente non funziona oggi perché non esistono test precisi, ma «quand'anche» esistessero domani noi non possono essere lo strumento su cui puntare «a livello di collettività». Benissimo. O malissimo, vedete voi.
Sia chiaro: italiano a parte, l'opinione di Brusaferro è ovviamente rispettabilissima. Cozza con quella di altri esponenti del suo stesso istituto (come potete leggere in questa pagina), oltre che con quella di altri esperti, ma tant'è: come dicevamo, alle divergenze tra scienziati ormai ci siamo abituati e non siamo certi noi titolati per discuterla dal punto di vista tecnico. L'unica cosa che proprio stona è che mentre il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità (organo istituzionale chiamato a dirci come uscire dall'emergenza) liquidava i test sierologici come «un tormentone», il commissario straordinario Domenico Arcuri (anche lui organo istituzionale chiamato a dirci come uscire dall'emergenza) andava al Tg1 a dichiarare: «Ne stiamo comprando 150.000, domani partirà il bando, a maggio saranno disponibili su tutto il territorio, ci diranno quante persone saranno immuni e diventeranno uno dei pilastri della fase due». Vaste programme per un «tormentone», non vi pare?
Ecco, tutto qui. Non vogliamo entrare nella disputa scientifica, non vogliamo giocare al Piccolo Virologo, siamo consapevoli che esistono materie delicate e complesse su cui bisogna procedere con cautela, ma proprio per questo ci chiediamo: è possibile che nello stesso momento due organi istituzionali, che dovrebbero lavorare insieme per tirarci fuori dal pantano, dicano l'esatto opposto su una questione così fondamentale? Perché i casi sono due: o i test sierologici sono attendibili e allora l'Istituto superiore della sanità racconta balle; oppure sono inattendibili e allora il Commissario straordinario deve dirci perché ne sta comprando 150.000. Non si scappa. Se questi esami servono bisogna dare subito indicazioni a tutti (Regioni, aziende, comuni) su quali scegliere e su come usarli; se non servono evitiamo di perdere tempo e soldi nel comprarli e metterli alla prova. La situazione è già piuttosto complicata, per uscirne fuori servirebbero idee chiare e rotte precise. Di tormenti e tormentoni ne abbiamo già fin troppi senza aggiungerci quelli di Brusaferro.