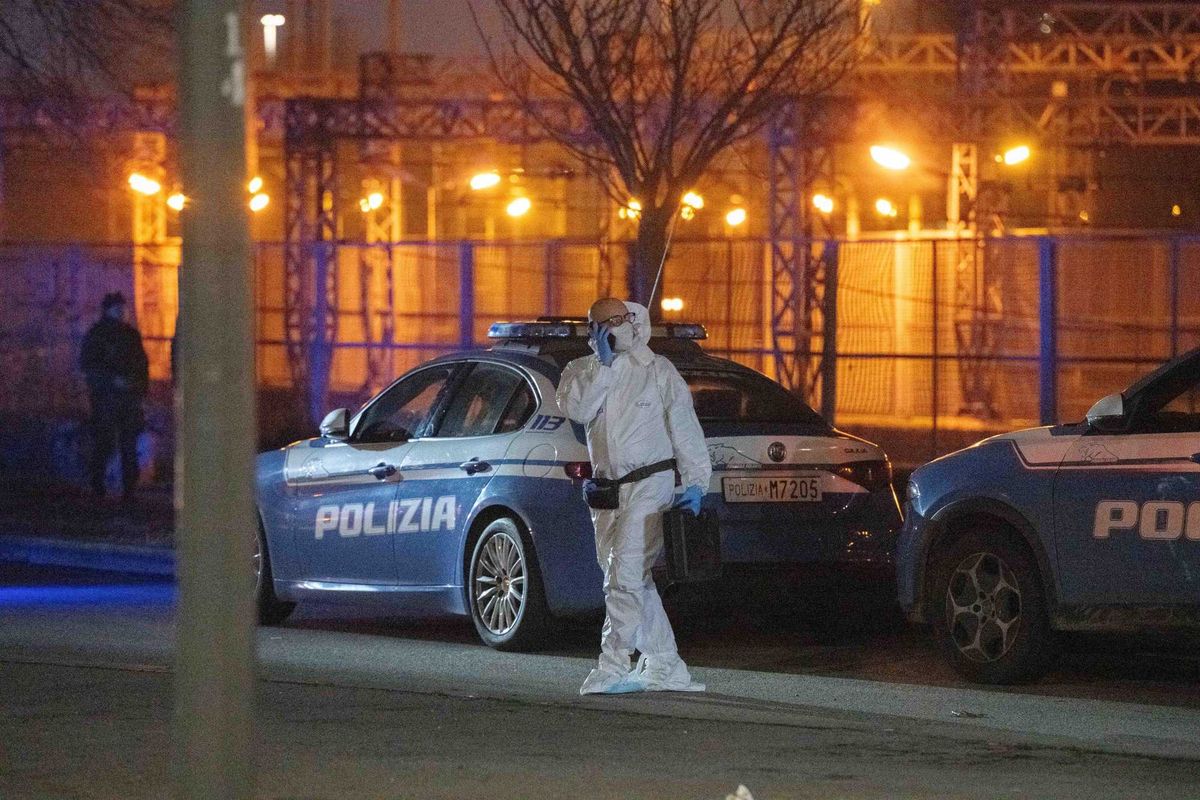Le drammatiche pagine dell'assedio alla Città eterna - e della successiva caduta della Repubblica romana - si aprono all'albeggiare del 3 giugno 1849. Nonostante Giuseppe Mazzini avesse poco prima concluso un trattato con Ferdinand de Lesseps, plenipotenziario del presidente della Repubblica, Luigi Napoleone Bonaparte, - nel quale la Francia aveva «assicurato il proprio appoggio alle popolazioni romane» - esso è stato infatti subdolamente rotto. La responsabilità è dello stesso Bonaparte, che intende rifarsi della sconfitta subita il 30 aprile, nonché consolidare la propria posizione in patria e rassicurare l'opinione pubblica cattolica, imponendosi come «restauratore dell'ordinamento pontificio». Pertanto, non esita a sconfessare la tregua trattata da Lesseps, ordinando al generale Victor-Charles Oudinot di prendere l'Urbe.
È appunto il 3 giugno quando l'esercito d'Oltralpe, forte di 30.000 unità, si lancia alla conquista del Gianicolo. Nell'attacco a Villa Corsini viene ferito Goffredo Mameli, il quale morirà un mese dopo. La difesa opposta dai soldati guidati da Giuseppe Garibaldi e dagli altri è straordinaria, ma deve fare i conti con la superiorità numerica degli invasori, che dilagano in seguito sui bastioni di Trastevere, su Ponte Milvio e in altri luoghi. La Repubblica romana, comunque, rifiuta di arrendersi. I bombardamenti si protraggono per giorni, mentre i bersaglieri volontari al comando di Luciano Manara, i garibaldini, la Legione polacca, il Battaglione universitario romano e tutti gli altri danno prova di un eroismo senza pari. Il 26 giugno viene assaltato nuovamente il Gianicolo, in particolare Villa del Vascello, e i nemici vengono respinti. Poco dopo, tuttavia, riescono a impadronirsi dei presidi più importanti fuori dalle mura aureliane, per tornare ad attaccare il Gianicolo, dove si combatte la battaglia finale. È Garibaldi con i suoi a difendere il Vascello: nonostante la loro bravura, la partita è perduta.
Il 1 luglio viene stabilita una tregua per raccogliere morti e feriti. Con un discorso all'Assemblea Costituente, Mazzini e Garibaldi spiegano la gravità della situazione, valutando le possibili alternative e soprattutto «l'uscita dalla città» delle forze combattenti. L'eroe dei due mondi è critico sulla gestione di quelle settimane e prende le distanze dall'ideologo genovese. Quindi, il 2 luglio, pronuncia un celebre discorso a piazza San Pietro, nel quale afferma: «Io esco da Roma: chi vuol continuare la guerra contro lo straniero, venga con me...». Allontanatosi dall'Urbe, si inoltra per il Centro Italia con i suoi volontari, braccato da 4 eserciti stranieri. Spera di raggiungere Venezia, ma non ci riuscirà.
Nel frattempo, l'Assemblea Costituente approva un decreto di resa, ribadendo però che essa «resta al suo posto». È un escamotage per evitare di dichiarare lo scioglimento, il decadimento formale, che tornerà utile in anni successivi. I francesi entrano quindi nella Città eterna, mentre papa Pio IX arriverà solo il 12 aprile 1850.
La triste conclusione di quei mesi di speranze e aneliti libertari non può cancellare il nome e le gesta di coloro che hanno lottato per la libertà. Oltre ai protagonisti maschili, le giornate della Repubblica romana sono contrassegnate dalla presenza di alcune donne straordinarie, appartenenti ai ceti sociali più disparati, Fra queste, c'é la giornalista statunitense Margaret Fuller, promessa a un tragico destino. Dopo le giornate dell'assedio a Roma - in cui ha scritto reportage, assistito Goffredo Mameli morente e offerto un passaporto a Mazzini - ella fugge infatti insieme al marito Angelo Ossoli e al figlio Angelino. Si rifugia a Firenze, dove inizia a scrivere la storia della rivoluzione italiana, quindi decide di tornare in America nel 1850. Il mercantile americano sul quale si è imbarcata con la famiglia si incaglia in una secca e viene disalberato, per poi calare a picco in vista di New York. Un marinaio si mette sulle spalle il piccolo Angelino, ma non resiste alla forza dei flutti. Anche Margaret e il marito tentano di raggiungere la riva, aggrappati a un relitto della nave, pur tuttavia vengono travolti dalle onde. I loro corpi non saranno mai ritrovati.
Meno drammatica è la sorte della principessa Cristina di Belgioioso, che a Roma assiste i feriti, organizza gli ospedali e cura un servizio infermieristico in anticipo su quello di Florence Nightingale. Dopo la caduta della Repubblica, fugge in Turchia con la figlia e lì mette in piedi una comunità agricola. Tornerà in Italia nel 1855.
Un'altra figura fuori dal comune, è quella della popolana Colomba Antonietti. Costei è nata a Bastia Umbra nell'ottobre 1826 ed è figlia di un fornaio. Trasferitasi a Foligno con la famiglia, ha conosciuto il conte Luigi Porzi, cadetto delle truppe pontificie, e se n'è innamorata. Dopo svariate traversie, è riuscita a sposarlo nel 1846, per poi spostarsi con lui nell'Urbe. Quando il conte ha aderito alla Repubblica romana, Colomba si è tagliata i capelli e si è travestita da bersagliere. Così vestita, ha affrontato le truppe straniere nella battaglia di Velletri e di Palestrina. Persino Garibaldi è rimasto colpito dal suo coraggio e il Monitore Romano ha scritto di lei: «Alla battaglia di Velletri si batté come un uomo, come un eroe, degno del suo marito e del suo cugino Luigi Masi».
Il 3 giugno, Colomba accorre con la baionetta in pugno per scacciare gli invasori, senza dimenticare di occuparsi dei feriti. Il 12 giugno i francesi intimano la resa, tuttavia la Repubblica romana non acconsente: a quel punto, l'assalto contro le mura e i cannoneggiamenti si fanno tremendi. Colomba e Luigi cercano di rinsaldare le difese e coprire ciò che è rimasto delle muraglie con sacchi di sabbia. Una palla di cannone batte contro gli spalti e, rimbalzando, colpisce la fanciulla a un fianco. Lei cade, l'arteria femorale recisa: quando arriva la barella per trasportarla all'ospedale, è già morta. Secondo la leggenda, prima di spirare stringendo la mano del marito, fa in tempo a mormorare: «Viva l'Italia». Garibaldi ne commemora il grande coraggio, mentre il Monitore commenta: «Francesi! Se gli italiani non si battono, bastino le nostre donne a insegnare il rispetto dovuto al nome e al valore romano. Fate fuoco, barbari, ma inchinatevi!». Luigi Porzi fuggirà in Sudamerica, dove morirà ben 50 anni dopo, senza mai risposarsi.
Quando si parla delle protagoniste femminili della Repubblica Romana, infine, è d'obbligo narrare la storia di una delle più note eroine del Risorgimento, cioè Anita Garibaldi. Costei si chiama in realtà Ana Maria de Jesus Ribeiro da Silva ed è nata in Brasile da una povera famiglia nel 1821. Libera, emancipata, sensibile ai temi della giustizia sociale sin da piccola, la futura Anita sposa a 14 anni un calzolaio. Nel 1839 conosce a un Te Deum nella cattedrale di Laguna Giuseppe Garibaldi, che resta folgorato e le dice: «Devi essere mia». Lei, evidentemente, acconsente, diventando la sua compagna e cominciando a seguirlo in tutte le battaglie. La coppia ha quindi un primo figlio, di nome Menotti: pochi giorni dopo la nascita, Anita viene catturata dall'esercito imperiale ma riesce a scappare col neonato in collo (al Gianicolo c'é una statua che ricorda la fuga). Nel 1841, Giuseppe e la moglie lasciano il Brasile per Montevideo, dove rimangono 7 anni, si sposano e hanno altri figli. Nel 1948, venuti a conoscenza delle rivoluzioni che sono scoppiate in Europa, i Garibaldi attraversano l'oceano; quindi il Generale si precipita a Roma, dove è stata proclamata la Repubblica, e la moglie lo raggiunge lì.
Dopo l'invasione francese e la resa, Garibaldi fugge con Anita e i volontari superstiti, tentando di raggiungere Venezia. Braccato dagli eserciti nemici, tocca San Marino, Cesenatico, si impadronisce di alcune imbarcazioni, poi le abbandona e si inoltra per le valli di Comacchio. Anita, tuttavia, sta malissimo, probabilmente a causa delle febbri malariche. Perde conoscenza, quindi muore il 4 agosto 1849 in una fattoria a Mandriole di Ravenna. Seppellita in tutta fretta fra mucchi di sabbia, per evitare che il suo corpo venga ritrovato dai nemici, viene successivamente portata nel cimitero di Mandriole. I suoi resti saranno poi spostati a Nizza - per volontà del marito - e quindi traslati a Roma, nel basamento del monumento a lei dedicato. Nonostante la fine drammatica e prematura, il coraggio, la tempra, la forza di combattente di Anita sono rimaste celebri. Così come è giusto che restino celebri il coraggio, l'eroismo, l'energia delle sue altre «sorelle» di battaglie risorgimentali. Anche loro hanno fatto l'Italia.