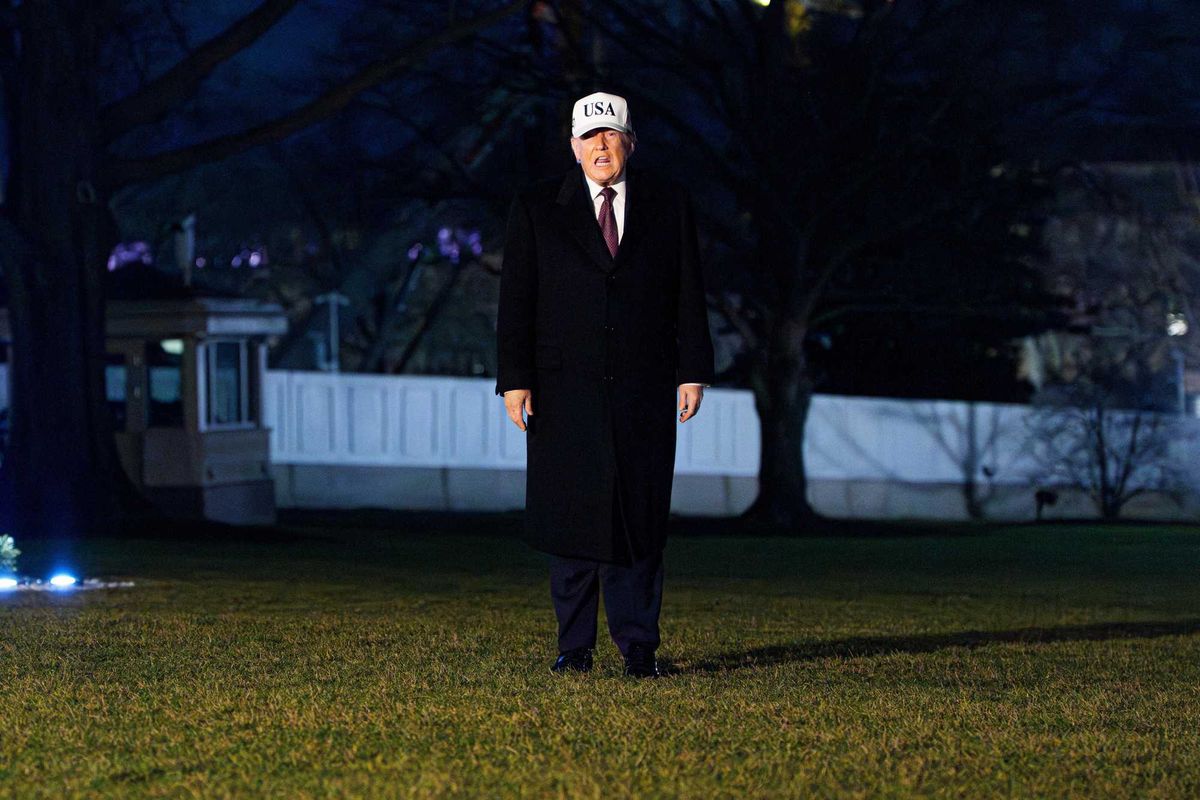Andrew Spannaus: «Zelensky sia realista. L’Ucraina non riavrà la Crimea e il Donbass»

Prima le uscite contro Vladimir Putin - «criminale di guerra e dittatore omicida», i commenti più gettonati - poi le imprudenze su Taiwan che hanno scatenato le reazioni della Cina, con i bombardieri strategici mandati a sorvolare i cieli dell’isola per esercitazioni di combattimento. «Nelle ultime settimane, il presidente americano Joe Biden non è in grado di nascondere i suoi veri pensieri», ragiona con La Verità Andrew Spannaus, analista e commentatore politico statunitense, fondatore del sito Transatlantico.info. «I suoi consiglieri preferirebbero parole più attente, ma Biden non ha linguaggio diplomatico. Pur avendo una grande esperienza nelle relazioni internazionali, è uno a cui piace parlare in modo diretto. Questo è il suo brand».
Andrew Spannaus, che significato hanno le fughe in avanti di Biden, con la Casa Bianca quasi sempre costretta a rincorrere per gettare acqua sul fuoco?
«Biden ha scelto una linea molto netta: nella sfida in corso tra democrazie e autocrazie non c’è spazio per la collaborazione».
Rischioso, non crede?
«Nel caso della Russia, persiste una convinzione ideologica, retaggio della Guerra Fredda, secondo cui Mosca non è un interlocutore valido. Gli Stati Uniti intendono promuovere un sistema ritenuto migliore rispetto a quello russo e, ancor di più, a quello cinese: la democrazia, il libero mercato, le libertà individuali. Si tratta di una visione idealista delle relazioni internazionali: c’è chi è convinto che l’unico modo per perseguire questo disegno sia sconfiggere gli altri, anche a costo di correre dei rischi molto alti. Le cose che dice Biden riflettono l’atteggiamento di alcune istituzioni americane, in questo momento maggioritarie nel Paese».
Di quali istituzioni sta parlando? Chi spinge per questo gioco al rialzo?
«Mi riferisco “al sistema della presidenza”, l’ampia rete di cui tutti i presidenti fanno parte. E poi ci sono le istituzioni permanenti, che qualcuno definirebbe apparati: sono il Dipartimento di Stato, pezzi dell’intelligence, il Pentagono, think tank e società di consulenza che hanno un orizzonte temporale spesso più lungo rispetto alla carica di un presidente. Una comunità di sicurezza nazionale che influisce sulle posizioni di una amministrazione presidenziale. Ci sono leader eletti che spesso cercano di cambiare la direzione di queste istituzioni, come abbiamo visto durante gli anni di Trump. Su alcuni dossier, come per esempio la Russia, cambiare idea è più difficile».
Eppure le premesse sembravano diverse.
«Una volta arrivato alla presidenza, Biden ha cominciato un processo di dialogo con Putin molto interessante. I due si sono visti a Ginevra nel giugno del 2021, si sono sentiti al telefono più volte. Non è un caso che il numero di truppe vicine all’Ucraina sia diminuito durante la scorsa estate. Poi il sistema americano ha deciso che, di fronte alla richiesta avanzata da Mosca di arrivare a un accordo sulla sicurezza, non si sarebbe trattato. E i toni sono radicalmente cambiati».
C’entra qualcosa la visita di Zelensky a Washington nel settembre del 2021?
«In quell’occasione sono stati firmati degli accordi, è stata ribadita la possibilità per l’Ucraina di entrare nella Nato e la disponibilità di Washington a fornire aiuti. A quel punto, la Russia ha cominciato a chiedere delle garanzie formali che gli Stati Uniti non hanno voluto concedere, quasi sfidando Mosca a fare qualcosa, a compiere quello che nel nostro Paese considerano un grosso errore, cioè l’invasione. Putin è stato messo in un angolo e ha reagito pensando di non avere altre vie d’uscita».
Cosa pensa del tentativo statunitense di portare la Russia al default?
«È quasi comico: gli Stati Uniti bloccano il meccanismo attraverso cui i russi possono onorare le scadenze e poi dicono che Mosca è prossima al fallimento. A livello più generale, la guerra economica procede spedita, con le sanzioni e il tentativo di isolare Putin a livello internazionale. Io non sono convinto che questa sia una strada particolarmente efficace, né che sia salutare per l’occidente nel medio-lungo periodo».
Per quale motivo?
«Per tre motivi, almeno. Innanzitutto perché le sanzioni si sono dimostrate inefficaci quando si punta a un cambio di regime: negli anni, si crea una sorta di compattamento interno che vanifica qualsiasi effetto punitivo. In più, fanno più male alla popolazione che alle élite governative».
E il terzo motivo?
«Le sanzioni precludono qualsiasi possibilità di interazione futura. Mosca ha chiaramente deciso di infischiarsene delle misure economiche annunciate, cercando di slegarsi dalla dipendenza occidentale e aumentando i rapporti con la Cina, con l’India e gli altri Paesi dell’Asia e dell’Africa. Sarà una strada difficile, che creerà delle divisioni. Questo pericolo spiega perché molti Paesi del mondo preferiscano restare a guardare, evitando di uniformarsi ai regimi sanzionatori per tenere aperti dei canali con Mosca e con Pechino».
Ritiene sia arrivato il momento di iniziare a trattare seriamente, entro un paio di mesi come chiede l’ex Segretario di Stato americano Henry Kissinger?
«Non so se il timing proposto da Kissinger sia corretto, ma è chiaro che il rischio di un allargamento della guerra c’è. La Russia sta guadagnando lentamente territorio, a un prezzo alto, certo, ma non è stata fermata. L’Ucraina conta sul massiccio invio di armi pesanti dagli Stati Uniti per poter fermare l’esercito di Putin e spingersi nella direzione opposta, magari. Bisogna capire quali saranno gli obiettivi finali».
Il presidente Zelensky esclude qualsiasi possibilità di cedere territori.
«Su questo punto, mi sembra che Zelensky non abbia una posizione realistica. Sarà anche sconveniente dirlo, ma l’Ucraina non avrà indietro la Crimea, né il Donbass. Più la guerra va avanti e più la Russia conquisterà territorio, questa è la situazione pratica adesso. Chiediamoci cosa è meglio fare oggi, quale compromesso attuare. L’Ucraina rimarrà un Paese indipendente e fortemente legato all’occidente, la questione è quanta Ucraina ci sarà».
Quanta ce ne sarà, secondo lei?
«Se l’Ucraina continua con il suo proposito di non cedere, penso che l’esito più probabile sia una divisione del Paese, con un conflitto a più bassa intensità».
Che idea si è fatto rispetto al piano di pace presentato all’Onu dall’Italia? La Russia lo ha praticamente stroncato, per l’Ucraina non è esattamente conveniente e Draghi ha preferito un silenzio distaccato.
«L’Italia, in collaborazione con la Francia, ha cominciato a esprimere una posizione in favore del dialogo. Avanzare delle proposte può essere un rischio, come effettivamente si è rivelato con il piano di pace per l’Ucraina. A parte il fallimento nel caso specifico, penso sia importante cominciare a ragionare in questi termini».
Come giudica l’idea del primo ministro inglese, Boris Johnson, di un nuovo sistema di accordi politici, economici e militari alternativo all’Unione Europea?
«Londra ha necessità di una alleanza occidentale indipendente dall’Unione Europea. La Ue ha delle significative contraddizioni interne, che possono frenare un’azione comune. Ciò che vorrebbero Francia, Germania e Italia è molto diverso, per esempio, da quello che pensano Polonia e Paesi Baltici. Senza dubbio, una organizzazione che non sia la Nato, cioè un’alleanza strettamente militare, e che non abbia le restrizioni dell’Europa può essere una soluzione interessante».
Che tipo di riflessi avrà la guerra in Ucraina nei rapporti tra Stati Uniti e Cina? La «dottrina» del Segretario di Stato Blinken non è piaciuta particolarmente a Pechino.
«La cosa non mi stupisce. La Cina resta il competitor strategico più importante per gli Stati Uniti. I cinesi non possono permettersi di vedere una Russia sconfitta, o peggio umiliata, perché ciò avrebbe delle conseguenze nel loro piano di riunificazione del Paese, che prevede anche Taiwan. Stati Uniti e Cina hanno molti rapporti economici, non è saggio sganciarsi completamente. Tuttavia, Pechino sta investendo molto per espandersi militarmente nel Pacifico e gli Usa non possono che limitare questa espansione: le tensioni saranno inevitabili».
Un dialogo è possibile?
«Non ancora. Nelle ultime settimane abbiamo assistito alle discussioni tra i vertici militari americani e quelli russi per scongiurare una escalation nucleare, lo stesso tipo di dialogo non è ancora stato avviato con la Cina. I cinesi non si fidano degli obiettivi americani, per questo restano nella loro ambiguità. La politica americana è cambiata: negli ultimi mesi, in merito a Taiwan, è diventata più esplicita. Biden, seppur non dovesse dirlo in modo così diretto, ha parlato in modo da riflettere questa realtà».