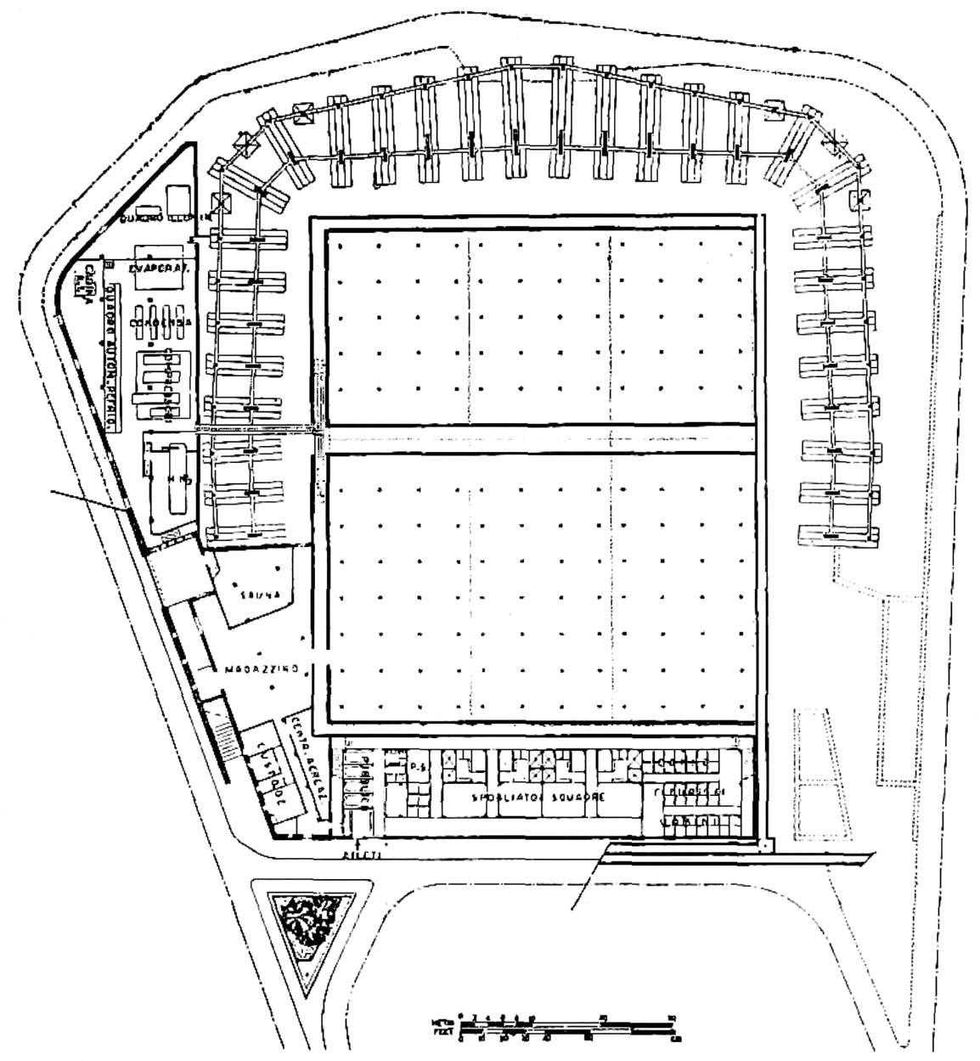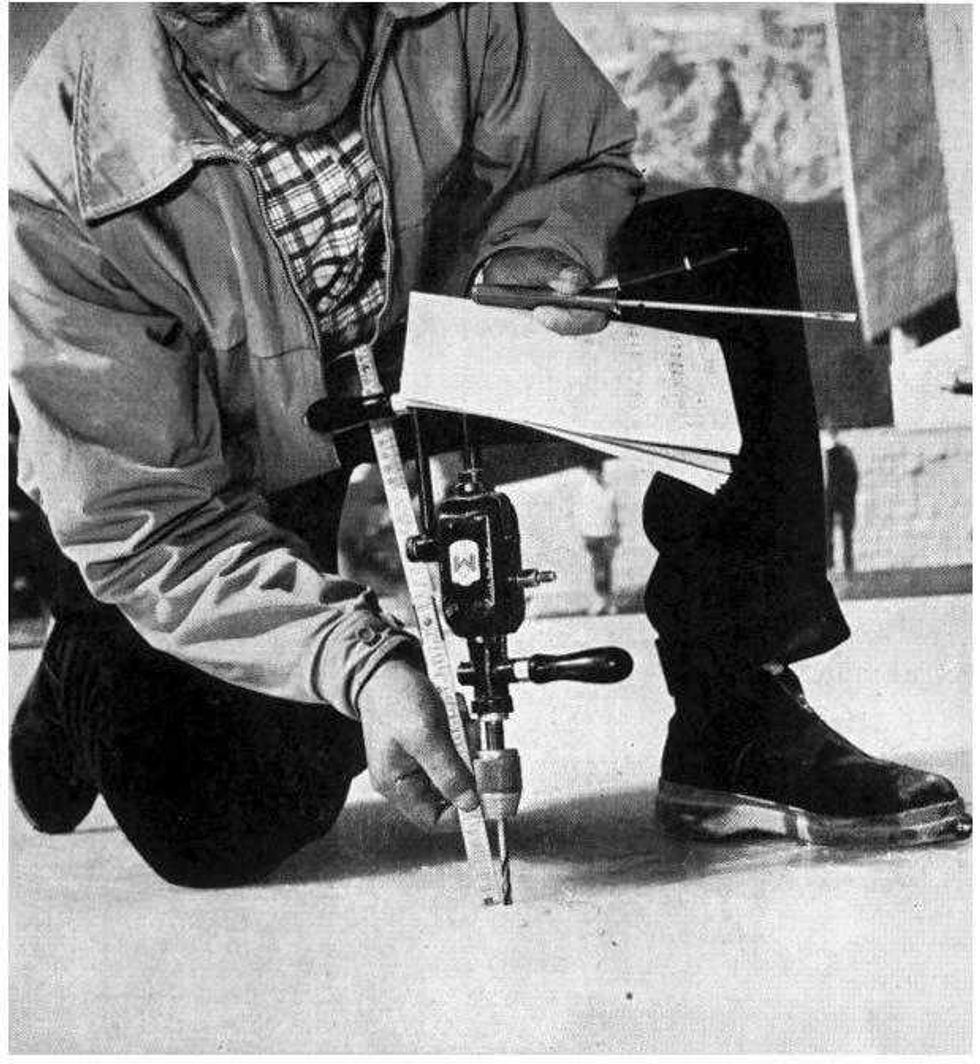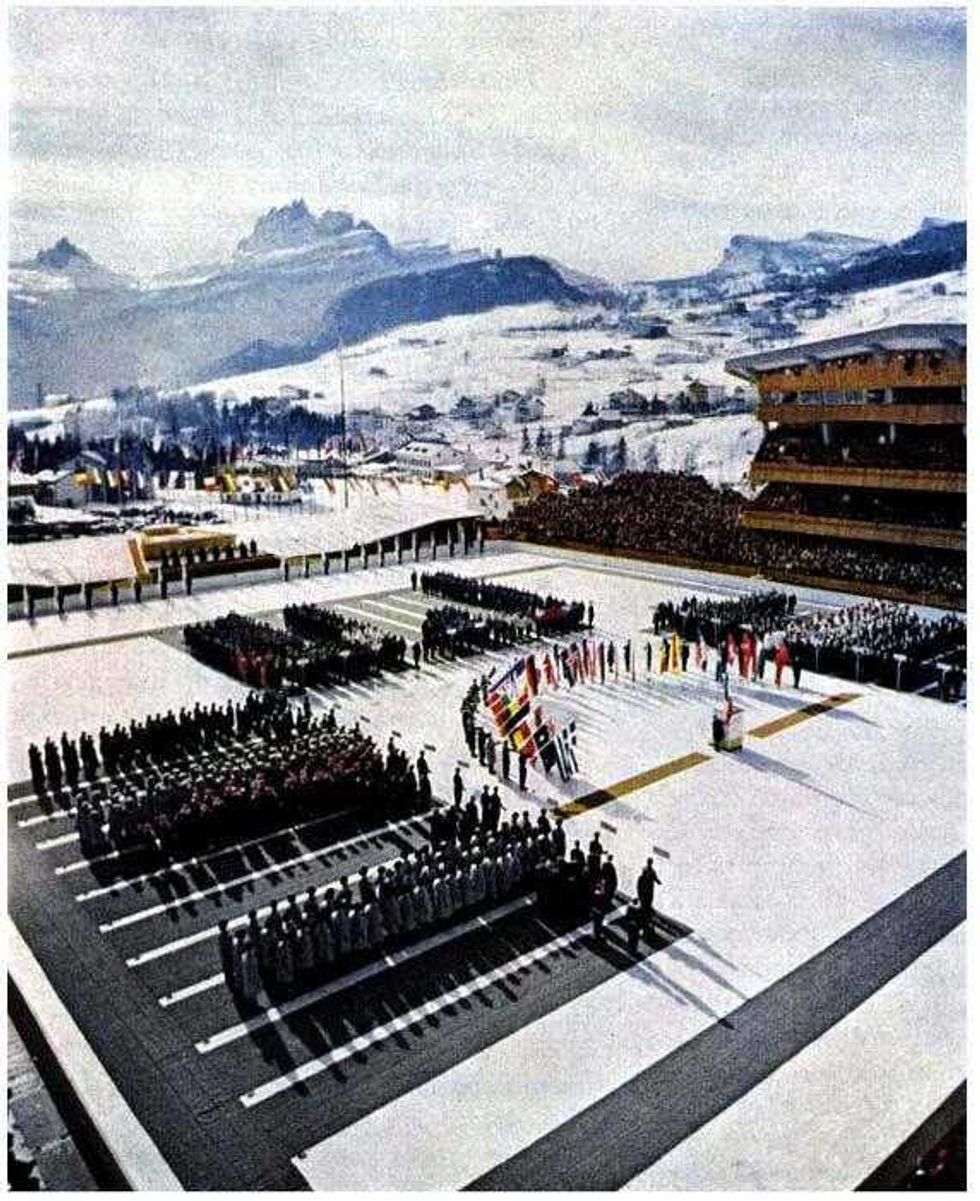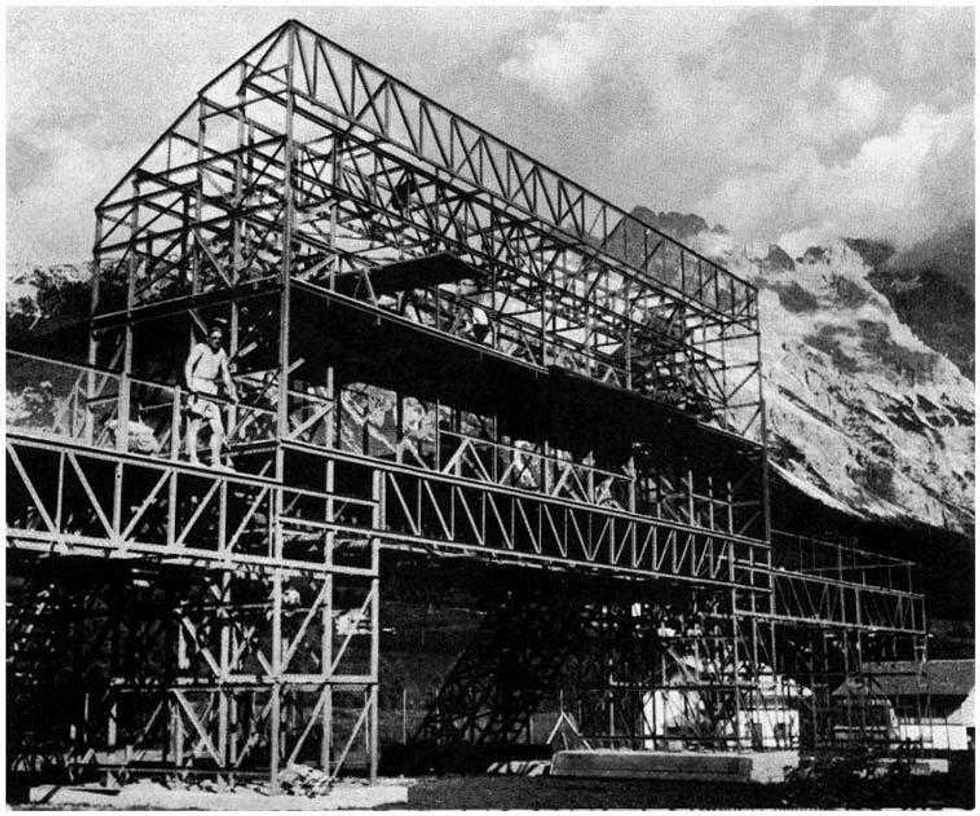True
2019-01-28
Violenze, omicidi e Isis. Ecco che cosa si nasconde in certi negozi degli egiziani
Le Iene
Insospettabili macellerie in Lombardia e nel Nord Italia, frutterie multiservice nella capitale, anonimi autolavaggi in Ciociaria. Si entra con una valigetta piena di contanti e grazie all'Hawala, un antico sistema che risale al medioevo e che si basa sull'onore e su una rete impressionante di broker, è possibile trasferire denaro sporco in Egitto, ma anche in altri Paesi del Nord Africa. Nella mala importata dal Medio Oriente è considerato più sicuro dei money transfer e anche del deep web (il lato oscuro di internet, che permette di navigare nella più completa illegalità e di mettere a punto qualsiasi traffico criminale, ndr). L'Hawala non lascia traccia. Il cliente raggiunge il mediatore in una anonima macelleria e gli consegna la somma da trasferire. Il broker, acquisite le banconote, dà l'ok al suo uomo di riferimento in Egitto che, come concordato dall'Italia, consegna il denaro alla persona indicata dal cliente. E il gioco è fatto. I magistrati della Direzione nazionale antimafia conoscono bene questo meccanismo finanziario illegale e monitorano le inchieste in cui compare. Non è sfuggito il servizio delle Iene sulle macellerie milanesi. Ma c'è un'inchiesta, affidata dal procuratore aggiunto che coordina il pool milanese antiterrorismo, Alberto Nobili, al pm Adriano Scudieri, che ha messo in luce, tracciato e accertato tutti i meccanismi dell'Hawala.
La notizia degli arresti, un anno fa, passò quasi in sordina. Ma insieme a 13 ordinanze di custodia cautelare (sei egiziani, cinque siriani e due marocchini, tutti ufficialmente imprenditori e in regola con i documenti) gli investigatori della Guardia di finanza sequestrarono un milione di euro in contanti che erano appena stati consegnati e che dovevano finire in Egitto. Nel fascicolo c'era anche una traccia inquietante, che i magistrati stanno ancora sviluppando: una parte di quei soldi sarebbero serviti a finanziare la rete del terrorismo internazionale dell'Isis. Il punto di contatto tra estremisti islamici e l'hub occulto di broker illegali milanesi, che avrebbe movimentato fino a 10 milioni di euro partiti dall'Italia, è un libico «contiguo ad ambienti di integralismo islamico»: Salem Bashir Mazan Rajah. Anche per lui c'era un mandato di cattura, ma non si è fatto acciuffare ed è ancora irreperibile.
La primula rossa, però, è monitorata ormai da oltre quattro anni: nel 2015, quando era ancora uno sconosciuto, la polizia dell'aeroporto lo fermò a Linate, dove era atterrato da Malta. Alla richiesta dei doganieri di indicare quanto contante c'era in una valigetta, su un pezzo di carta scrisse: 296.000 euro. Una cifra difficile da far passare in aeroporto senza una minima giustificazione. E, così, quell'uomo dall'aspetto molto religioso, con il Corano in una borsetta e un bel po' di bigliettoni in una 24 ore, venne denunciato a piede libero con l'accusa di riciclaggio di denaro. Gli sequestrarono anche il telefono cellulare. E da lì, grazie ai suoi contatti, si aprirono due piste: una internazionale, legata a nomi di importanti jihadisti, e una milanese che ha portato alla scoperta della centrale finanziaria dell'Hawala.
Il campanello d'allarme del terrorismo internazionale suonò sin dai primi istanti: sul telefonino, annotarono gli investigatori, c'erano «fotografie, video ed email dal chiaro contenuto religioso islamista, anche di tipo radicale». E da una piccola ricerca saltò fuori che il libico aveva effettuato in Germania, Francia e Olanda, tra il 2013 e il 2015, «dichiarazioni doganali per circa 50 milioni di euro». La banda che forniva il servizio di trasferimento di denaro illecito a carattere transnazionale, si scoprì, era organizzata in due gruppi tra loro collegati: il network Sadig e il network Haj Ibrahim. I clienti individuati, tra l'altro, in quel momento erano quasi tutti sotto inchiesta per le loro attività illecite in diverse città italiane: Genova, Torino, Como, Venezia, Brescia, Cagliari, Catania e Ascoli Piceno. Per Roma e per il Sud Italia, invece, c'è un altro hub. E si annida principalmente nelle frutterie. È meno frequentato da uomini d'affari e colletti bianchi e a volte risulta essere molto rozzo. Ma, soprattutto, ammazza. Proprio come la criminalità comune.
Sono diversi gli egiziani morti in circostanze all'apparenza mai chiarite. Il 28 ottobre 2013, ad esempio, trovarono il proprietario di tre frutterie, Mohamed Ebraim Leshein con le mani legate dietro la schiena e la faccia a terra, in zona Settebagni, a Roma. Gli investigatori della Squadra mobile si convinsero che il movente di quell'omicidio fosse un tentativo di estorsione o usura. Ma, si sa, nessun aguzzino ha interesse a far fuori la propria fonte di reddito. E allora si è fatta strada l'altra ipotesi, legata all'onore. Se spariscono i soldi dell'Hawala, allora sì che sono guai.
Nel 2015 la storia si ripete. Hashem El Sayed Gaafar, anche lui fruttivendolo, viene trovato incaprettato proprio davanti al suo negozio. Aveva appena ritirato 5.000 euro in contanti. Una rapina, ipotizzarono gli investigatori. Ma il fratello disse da subito che «doveva dei soldi alle persone sbagliate». E si addrizzò il tiro verso un giro d'usura. Dalla Squadra mobile spiegarono che la provenienza dei soldi che aveva addosso non era affatto chiara, ma precisarono che l'egiziano prima di morire era stato brutalmente picchiato. Quasi torturato. E anche questo delitto è diventato un cold case. Basta chiedere poi alla sala operativa della Questura per capire che casi di accoltellamento tra egiziani sono quasi all'ordine del giorno. E sono tutti regolamenti di conti. Poi, nel dicembre 2016, sette egiziani vennero arrestati con l'accusa di aver tentato di uccidere, nell'agosto 2015, due connazionali nel Centro agroalimentare romano, a Guidonia. Emerse che un gruppo di egiziani, per affermare la propria forza intimidatoria, aveva organizzato una spedizione punitiva nei confronti dei due ragazzi, che nel centro lavoravano come facchini, perché non volevano riconoscere l'autorità della banda che si occupava di approvvigionamento all'ingrosso di ortofrutticoli. La classica buccia di banana. Perché il vero affare era il controllo delle frutterie romane. Gli indizi: i negozi di frutta e verdura degli egiziani finiscono spesso in fumo. A qualcuno è capitato anche più di una volta. È il caso della Nabil frutta di Guidonia, gestita da egiziani, bruciata per ben tre volte. E infatti gli investigatori l'hanno definito il racket della frutta. La banda di egiziani controllava almeno 13 frutterie tra Roma, Guidonia, Montecelio, Monterotondo, Palombara Sabina, Lavinio e Orvieto.
Nell'ultimo anno, a Roma, stando ai dati della Camera di commercio, hanno chiuso i battenti 33 frutterie autoctone e altrettante in provincia. Molte sono state rilevate da egiziani che, occupandosi anche delle forniture, spesso, dopo essere riusciti a far indebitare le attività che riforniscono, alla fine le acquisiscono. Anche nel giro delle pizzerie, scoprì la Procura di Roma, c'erano bande che cercavano di estromettere i connazionali dalla gestione delle attività commerciali, dopo aver concesso prestiti usurai. Le pizzerie, una in via Pollenza e l'altra in via Ratto delle Sabine, furono oggetto di veri e propri raid.
Lo stesso meccanismo c'è dietro agli autolavaggi in Ciociaria. Lo ha svelato lo scorso anno l'operazione Gold wash, che ha disarticolato una banda che con la violenza aveva imposto il controllo esclusivo nella gestione degli autolavaggi di Cassino. Anche lì ci furono tentati omicidi e pestaggi, reati spia che spesso riescono a svelare ben altro.
I cinesi smerciano buoni spesa per migranti
Anche i cinesi, nel business sotterraneo dei minimarket, fanno la loro parte. Che vendano merce importata in modo non del tutto legale, contraffatta o poco sicura, sequestrata ogni anno a tonnellate, non fa certamente più notizia, ma non stanno tutte lì le furbizie messe in atto per aumentare i guadagni. A Lecce, per esempio, qualche giorno fa, i carabinieri hanno multato un negozio che aveva messo in vendita capi di abbigliamento adornati con pelliccia di gatto.
A Milano, qualche mese fa, in zona Paolo Sarpi, ben nascosti dietro barattoli di integratori erboristici la polizia locale aveva trovato farmaci di importazione, tra cui anche pillole abortive che venivano vendute illegalmente senza prescrizione medica.
E ancora, a Firenze, ogni settimana, si tiene puntualmente un mercato abusivo di frutta e verdura, coltivata nelle campagne toscane e proveniente da semi importati, che nel nostro Paese sono vietati. A Ferrara, invece, fino a qualche tempo fa, i negozi cinesi (e anche pakistani) si trasformavano, spesso e volentieri, in centri di riciclaggio per i buoni spesa della Coop, destinati ai richiedenti asilo, che preferivano acquistare superalcolici lì, piuttosto che andare a spenderli nei supermercati.
Il blitz che i carabinieri hanno messo in atto a Surano, in provincia di Lecce, lo scorso 19 gennaio, non è uguale a tutti gli altri: in un negozio gestito da cinesi hanno sequestrato decine di capi con inserzioni di pelo vero, proveniente con ogni probabilità da animali maltrattati prima di essere uccisi e poi scuoiati per ricavarne inserti di pelliccia da vendere a poco prezzo. Nel nostro Paese è vietato l'utilizzo di pellami e pellicce di animali come il gatto, il procione, la lince, il coyote e ovviamente il cane, provenienti da Paesi che non rispettano le normative anti sofferenza. In Cina, invece, come hanno testimoniato più volte i documentari di attivisti animalisti, è usuale l'utilizzo delle pelli di cane e di gatto, catturati per strada o nei cortili delle case e poi barbaramente uccisi, per l'industria dell'abbigliamento.
Nel 2018 tra i fenomeni di vendita abusiva negli esercizi gestiti da immigrati è spuntato anche quello della vendita dei farmaci. Prodotti di origine ignota, non commercializzati in Italia, e privi di indicazioni terapeutiche specifiche che vengono venduti sfusi, senza ricetta né prescrizioni del medico. Sono destinati soprattutto alla comunità cinese, che invece di rifornirsi in farmacia preferisce fare spesa dai connazionali. La primavera scorsa, durante un controllo del nucleo anti abusivismo, la polizia locale di Milano, in zona Paolo Sarpi, in un negozio di cineserie ha trovato migliaia di pillole occultate in barattoli etichettati come semplici integratori: si trattava in realtà di antibiotici, antinfiammatori e altri presidi medici non commercializzati in Italia e di provenienza ignota. Tra i farmaci illegali, tutti sequestrati e distrutti, sono state trovate persino confezioni della pillola del giorno dopo, ben nascoste in barattoli che pubblicizzavano prodotti a base di erbe e radici.
Spostandoci a Firenze, nella periferia della città, precisamente in via Di Vittorio, da anni possiamo trovare ogni settimana un mercato della frutta e della verdura, gestito da cinesi, completamente abusivo. Cassette a terra o su banconi improvvisati in barba a qualsiasi regola sanitaria, nessun permesso per occupazione di suolo pubblico e niente scontrini, ovviamente, visto che di registratori di cassa non c'è nemmeno l'ombra.
A parte qualche multa ogni tanto, il fenomeno è ben noto e tollerato dalle istituzioni, nonostante si tratti dell'ultimo passaggio di una filiera abusiva che rischia di danneggiare la nostra agricoltura e il mercato. Sui banchi dell'improvvisato market si trovano infatti «ortaggi di dimensioni anomale, non tracciati e modificati in laboratorio», con ogni probabilità provenienti da coltivazioni ricavate da «semi importati illegalmente dalla Cina e coltivati in Lazio, Sicilia e Campania», probabilmente «modificati geneticamente o ibridati», dunque potenzialmente pericolosi per le coltivazioni autoctone.
A Ferrara, fino a qualche tempo fa, andava di gran moda un giro d'affari illecito che utilizzava come moneta di scambio i buoni pasto della Coop forniti ai richiedenti asilo, ospiti delle strutture di accoglienza. Funzionava così: nel pacchetto da 35 euro al giorno, previsto per il mantenimento dei finti profughi, erano compresi anche i buoni spesa per l'approvvigionamento autonomo dei soggetti sistemati presso appartamenti o stanze delle cooperative locali. I buoni venivano consegnati direttamente agli immigrati e avevano stampigliato, oltre al marchio del supermercato convenzionato, anche il logo della coop ospitante, in modo da diventare tracciabili. Per evitare di incorrere in qualche controllo sugli acquisti, però, i finti profughi avevano trovato una strada alternativa: svendevano i buoni spesa nei market gestiti da cinesi a un prezzo inferiore al loro valore e in cambio ottenevano la possibilità di rifornirsi liberamente di alcol o cibi etnici. E anche per i gestori si trattava di un affare: una volta accumulati i buoni, pagati la metà del valore, questi si recavano nei supermercati a marchio Coop per fare incetta, a loro volta, di articoli scontati, da rivendere poi negli stessi minimarket, a prezzo pieno.
Cibi non tracciati, igiene carente: gli stranieri ci rovinano la tavola
Ogni anno, gli italiani ordinano sulle piattaforme di Food delivery oltre 25.000 chili di sushi. I ristoranti etnici, nel nostro Paese, sono più di 50.000. Ci sono 13.000 minimarket gestiti da bengalesi e più di 6.000 frutterie egiziane. Ma dietro la proliferazione di pesce crudo, involtini primavera, alimentari aperti 24 ore e arance a buon mercato, spesso c'è del marcio. Letteralmente. Cibo non tracciabile o mal conservato. Locali laidi. Dipendenti in nero. E, addirittura, spaccio di droga. Per Coldiretti, il 20% delle merci straniere non rispetta le norme italiane su ambiente, sanità e lavoro.
A novembre, a Modena, i Nas hanno sequestrato 122 chili di carne e pesce congelati in un minimarket etnico. Gli alimenti erano totalmente privi di etichette. Impossibile stabilire da dove venissero e quando scadessero. Stessa scena, poche settimane dopo, nel Chietino: 2.800 euro di merce non etichettata. A fine novembre, in Friuli Venezia Giulia, i Nas hanno visitato i market gestiti da romeni, ucraini e ungheresi. Nell'Europa dell'Est, infatti, è in atto un'epidemia di peste suina. La malattia non è trasmissibile all'uomo, ma se si trasporta bestiame infetto, si rischiano di contagiare altri animali. Dai controlli non è emersa traccia del virus. Ma di 200 chili di carne era impossibile conoscere provenienza e scadenza.
Con la carne, i negozi etnici hanno un rapporto complicato. Il caso più eclatante a Latina. I Nas avevano dovuto mettere i sigilli a un minimarket con annesso laboratorio di sezionamento di carni congelate, allestito in un bagno fatiscente e ovviamente lurido. Pure con il pesce si casca male. La scorsa primavera, nell'Aquilano, i Nas avevano sequestrato ben 300 chili di sushi e sashimi, prodotti senza notifica alle autorità (che è obbligatoria nel caso di prodotti ittici da consumare crudi).
Non bisogna fidarsi nemmeno degli ingrossi cinesi. A fine ottobre, i Nas di Roma e Parma hanno trovato, in confezioni di brodo aromatizzato al pollo vendute da un grossista, «ingredienti di origine animale non dichiarati in etichetta». Insomma, nel brodo di pollo non c'era solo il pollo.
Non mancano le irregolarità neppure nelle rivendite di frutta e verdura. A Pavia, due commercianti egiziani sono stati multati per la mancata tracciabilità dei prodotti ortofrutticoli. A Pescara, i Nas hanno documentato gravi carenze igienico-sanitarie in un'ortofrutta gestita da nordafricani.
C'è pure il capitolo dei lavoratori in nero. Nella zona di Mantova, a novembre, la Guardia di finanza ha disposto lo stop per un negozio etnico che impiegava vari dipendenti irregolari. Ad Alba Adriatica, in Abruzzo, i carabinieri avevano sorpreso un dipendente in nero in un esercizio commerciale gestito da uno straniero. Sul litorale Catanzarese, i Nas ne avevano trovati altri in un ristorante orientale. Al Lido di Venezia era scattata la sospensione per alcuni negozi etnici di cittadini del Bangladesh.
I market stranieri sono, notoriamente, luogo di bivacco. Matteo Salvini aveva promesso una stretta sugli orari di chiusura nel dl Sicurezza. Ma di questa disposizione, nel testo finale si sono perse le tracce. E così, i negozietti di cingalesi, indiani e bangladesi continuano a rifornire di alcol a poco prezzo il popolo della notte. E c'è persino chi, dietro la vetrina, nasconde il traffico di droga. È successo a Prato, dove, ad agosto, era stata disposta la sospensione per un minimarket etnico. La titolare, una nigeriana di 32 anni, consentiva agli spacciatori del luogo di smerciare gli stupefacenti all'interno del suo punto vendita. Sarà stato per solidarietà: le forze dell'ordine avevano già arrestato suo fratello, sorpreso con due dosi di eroina mentre usciva dal negozio.
La colonizzazione del nostro Paese passa per i sushi bar alla moda e i più modesti minimarket etnici. I commercianti italiani lo denunciano da anni: dove prima c'erano vetrine eleganti, adesso compaiono frutterie-bugigattolo. Le attività degli stranieri crescono a ritmi cinque volte superiori rispetto a quelle dei nostri connazionali. Di questo passo, tra pochi anni resteranno solo loro. Visti i cibi che somministrano, faranno prima a sostituirci o ad avvelenarci?
Continua a leggereRiduci
Macellerie che diventano centrali per il finanziamento dei terroristi. Traffici di soldi, prestiti a usura, business illeciti di ogni tipo. Le Procure indagano. I cinesi smerciano buoni spesa per migranti. A Ferrara, gli immigrati li cedevano ai gestori di un alimentari orientale in cambio di alcolici. I titolari li usavano per comprare prodotti che rivendevano a prezzo pieno in negozio. A Milano, gli asiatici vendevano pillole abortive senza prescrizione medica. Cibi non tracciati, igiene carente: gli stranieri ci rovinano la tavola. Dal centro per lavorazione della carne allestito in un wc, al minimarket nigeriano dove si spacciavano droghe. Proliferano ristoranti e locali etnici ma per molti le regole sono un optional. Lo speciale contiene tre articoli. Insospettabili macellerie in Lombardia e nel Nord Italia, frutterie multiservice nella capitale, anonimi autolavaggi in Ciociaria. Si entra con una valigetta piena di contanti e grazie all'Hawala, un antico sistema che risale al medioevo e che si basa sull'onore e su una rete impressionante di broker, è possibile trasferire denaro sporco in Egitto, ma anche in altri Paesi del Nord Africa. Nella mala importata dal Medio Oriente è considerato più sicuro dei money transfer e anche del deep web (il lato oscuro di internet, che permette di navigare nella più completa illegalità e di mettere a punto qualsiasi traffico criminale, ndr). L'Hawala non lascia traccia. Il cliente raggiunge il mediatore in una anonima macelleria e gli consegna la somma da trasferire. Il broker, acquisite le banconote, dà l'ok al suo uomo di riferimento in Egitto che, come concordato dall'Italia, consegna il denaro alla persona indicata dal cliente. E il gioco è fatto. I magistrati della Direzione nazionale antimafia conoscono bene questo meccanismo finanziario illegale e monitorano le inchieste in cui compare. Non è sfuggito il servizio delle Iene sulle macellerie milanesi. Ma c'è un'inchiesta, affidata dal procuratore aggiunto che coordina il pool milanese antiterrorismo, Alberto Nobili, al pm Adriano Scudieri, che ha messo in luce, tracciato e accertato tutti i meccanismi dell'Hawala. La notizia degli arresti, un anno fa, passò quasi in sordina. Ma insieme a 13 ordinanze di custodia cautelare (sei egiziani, cinque siriani e due marocchini, tutti ufficialmente imprenditori e in regola con i documenti) gli investigatori della Guardia di finanza sequestrarono un milione di euro in contanti che erano appena stati consegnati e che dovevano finire in Egitto. Nel fascicolo c'era anche una traccia inquietante, che i magistrati stanno ancora sviluppando: una parte di quei soldi sarebbero serviti a finanziare la rete del terrorismo internazionale dell'Isis. Il punto di contatto tra estremisti islamici e l'hub occulto di broker illegali milanesi, che avrebbe movimentato fino a 10 milioni di euro partiti dall'Italia, è un libico «contiguo ad ambienti di integralismo islamico»: Salem Bashir Mazan Rajah. Anche per lui c'era un mandato di cattura, ma non si è fatto acciuffare ed è ancora irreperibile. La primula rossa, però, è monitorata ormai da oltre quattro anni: nel 2015, quando era ancora uno sconosciuto, la polizia dell'aeroporto lo fermò a Linate, dove era atterrato da Malta. Alla richiesta dei doganieri di indicare quanto contante c'era in una valigetta, su un pezzo di carta scrisse: 296.000 euro. Una cifra difficile da far passare in aeroporto senza una minima giustificazione. E, così, quell'uomo dall'aspetto molto religioso, con il Corano in una borsetta e un bel po' di bigliettoni in una 24 ore, venne denunciato a piede libero con l'accusa di riciclaggio di denaro. Gli sequestrarono anche il telefono cellulare. E da lì, grazie ai suoi contatti, si aprirono due piste: una internazionale, legata a nomi di importanti jihadisti, e una milanese che ha portato alla scoperta della centrale finanziaria dell'Hawala. Il campanello d'allarme del terrorismo internazionale suonò sin dai primi istanti: sul telefonino, annotarono gli investigatori, c'erano «fotografie, video ed email dal chiaro contenuto religioso islamista, anche di tipo radicale». E da una piccola ricerca saltò fuori che il libico aveva effettuato in Germania, Francia e Olanda, tra il 2013 e il 2015, «dichiarazioni doganali per circa 50 milioni di euro». La banda che forniva il servizio di trasferimento di denaro illecito a carattere transnazionale, si scoprì, era organizzata in due gruppi tra loro collegati: il network Sadig e il network Haj Ibrahim. I clienti individuati, tra l'altro, in quel momento erano quasi tutti sotto inchiesta per le loro attività illecite in diverse città italiane: Genova, Torino, Como, Venezia, Brescia, Cagliari, Catania e Ascoli Piceno. Per Roma e per il Sud Italia, invece, c'è un altro hub. E si annida principalmente nelle frutterie. È meno frequentato da uomini d'affari e colletti bianchi e a volte risulta essere molto rozzo. Ma, soprattutto, ammazza. Proprio come la criminalità comune. Sono diversi gli egiziani morti in circostanze all'apparenza mai chiarite. Il 28 ottobre 2013, ad esempio, trovarono il proprietario di tre frutterie, Mohamed Ebraim Leshein con le mani legate dietro la schiena e la faccia a terra, in zona Settebagni, a Roma. Gli investigatori della Squadra mobile si convinsero che il movente di quell'omicidio fosse un tentativo di estorsione o usura. Ma, si sa, nessun aguzzino ha interesse a far fuori la propria fonte di reddito. E allora si è fatta strada l'altra ipotesi, legata all'onore. Se spariscono i soldi dell'Hawala, allora sì che sono guai. Nel 2015 la storia si ripete. Hashem El Sayed Gaafar, anche lui fruttivendolo, viene trovato incaprettato proprio davanti al suo negozio. Aveva appena ritirato 5.000 euro in contanti. Una rapina, ipotizzarono gli investigatori. Ma il fratello disse da subito che «doveva dei soldi alle persone sbagliate». E si addrizzò il tiro verso un giro d'usura. Dalla Squadra mobile spiegarono che la provenienza dei soldi che aveva addosso non era affatto chiara, ma precisarono che l'egiziano prima di morire era stato brutalmente picchiato. Quasi torturato. E anche questo delitto è diventato un cold case. Basta chiedere poi alla sala operativa della Questura per capire che casi di accoltellamento tra egiziani sono quasi all'ordine del giorno. E sono tutti regolamenti di conti. Poi, nel dicembre 2016, sette egiziani vennero arrestati con l'accusa di aver tentato di uccidere, nell'agosto 2015, due connazionali nel Centro agroalimentare romano, a Guidonia. Emerse che un gruppo di egiziani, per affermare la propria forza intimidatoria, aveva organizzato una spedizione punitiva nei confronti dei due ragazzi, che nel centro lavoravano come facchini, perché non volevano riconoscere l'autorità della banda che si occupava di approvvigionamento all'ingrosso di ortofrutticoli. La classica buccia di banana. Perché il vero affare era il controllo delle frutterie romane. Gli indizi: i negozi di frutta e verdura degli egiziani finiscono spesso in fumo. A qualcuno è capitato anche più di una volta. È il caso della Nabil frutta di Guidonia, gestita da egiziani, bruciata per ben tre volte. E infatti gli investigatori l'hanno definito il racket della frutta. La banda di egiziani controllava almeno 13 frutterie tra Roma, Guidonia, Montecelio, Monterotondo, Palombara Sabina, Lavinio e Orvieto. Nell'ultimo anno, a Roma, stando ai dati della Camera di commercio, hanno chiuso i battenti 33 frutterie autoctone e altrettante in provincia. Molte sono state rilevate da egiziani che, occupandosi anche delle forniture, spesso, dopo essere riusciti a far indebitare le attività che riforniscono, alla fine le acquisiscono. Anche nel giro delle pizzerie, scoprì la Procura di Roma, c'erano bande che cercavano di estromettere i connazionali dalla gestione delle attività commerciali, dopo aver concesso prestiti usurai. Le pizzerie, una in via Pollenza e l'altra in via Ratto delle Sabine, furono oggetto di veri e propri raid. Lo stesso meccanismo c'è dietro agli autolavaggi in Ciociaria. Lo ha svelato lo scorso anno l'operazione Gold wash, che ha disarticolato una banda che con la violenza aveva imposto il controllo esclusivo nella gestione degli autolavaggi di Cassino. Anche lì ci furono tentati omicidi e pestaggi, reati spia che spesso riescono a svelare ben altro. <div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem2" data-id="2" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/violenze-omicidi-e-isis-ecco-che-cosa-si-nasconde-nei-negozi-degli-egiziani-2627246208.html?rebelltitem=2#rebelltitem2" data-basename="i-cinesi-smerciano-buoni-spesa-per-migranti" data-post-id="2627246208" data-published-at="1770307524" data-use-pagination="False"> I cinesi smerciano buoni spesa per migranti Anche i cinesi, nel business sotterraneo dei minimarket, fanno la loro parte. Che vendano merce importata in modo non del tutto legale, contraffatta o poco sicura, sequestrata ogni anno a tonnellate, non fa certamente più notizia, ma non stanno tutte lì le furbizie messe in atto per aumentare i guadagni. A Lecce, per esempio, qualche giorno fa, i carabinieri hanno multato un negozio che aveva messo in vendita capi di abbigliamento adornati con pelliccia di gatto. A Milano, qualche mese fa, in zona Paolo Sarpi, ben nascosti dietro barattoli di integratori erboristici la polizia locale aveva trovato farmaci di importazione, tra cui anche pillole abortive che venivano vendute illegalmente senza prescrizione medica. E ancora, a Firenze, ogni settimana, si tiene puntualmente un mercato abusivo di frutta e verdura, coltivata nelle campagne toscane e proveniente da semi importati, che nel nostro Paese sono vietati. A Ferrara, invece, fino a qualche tempo fa, i negozi cinesi (e anche pakistani) si trasformavano, spesso e volentieri, in centri di riciclaggio per i buoni spesa della Coop, destinati ai richiedenti asilo, che preferivano acquistare superalcolici lì, piuttosto che andare a spenderli nei supermercati. Il blitz che i carabinieri hanno messo in atto a Surano, in provincia di Lecce, lo scorso 19 gennaio, non è uguale a tutti gli altri: in un negozio gestito da cinesi hanno sequestrato decine di capi con inserzioni di pelo vero, proveniente con ogni probabilità da animali maltrattati prima di essere uccisi e poi scuoiati per ricavarne inserti di pelliccia da vendere a poco prezzo. Nel nostro Paese è vietato l'utilizzo di pellami e pellicce di animali come il gatto, il procione, la lince, il coyote e ovviamente il cane, provenienti da Paesi che non rispettano le normative anti sofferenza. In Cina, invece, come hanno testimoniato più volte i documentari di attivisti animalisti, è usuale l'utilizzo delle pelli di cane e di gatto, catturati per strada o nei cortili delle case e poi barbaramente uccisi, per l'industria dell'abbigliamento. Nel 2018 tra i fenomeni di vendita abusiva negli esercizi gestiti da immigrati è spuntato anche quello della vendita dei farmaci. Prodotti di origine ignota, non commercializzati in Italia, e privi di indicazioni terapeutiche specifiche che vengono venduti sfusi, senza ricetta né prescrizioni del medico. Sono destinati soprattutto alla comunità cinese, che invece di rifornirsi in farmacia preferisce fare spesa dai connazionali. La primavera scorsa, durante un controllo del nucleo anti abusivismo, la polizia locale di Milano, in zona Paolo Sarpi, in un negozio di cineserie ha trovato migliaia di pillole occultate in barattoli etichettati come semplici integratori: si trattava in realtà di antibiotici, antinfiammatori e altri presidi medici non commercializzati in Italia e di provenienza ignota. Tra i farmaci illegali, tutti sequestrati e distrutti, sono state trovate persino confezioni della pillola del giorno dopo, ben nascoste in barattoli che pubblicizzavano prodotti a base di erbe e radici. Spostandoci a Firenze, nella periferia della città, precisamente in via Di Vittorio, da anni possiamo trovare ogni settimana un mercato della frutta e della verdura, gestito da cinesi, completamente abusivo. Cassette a terra o su banconi improvvisati in barba a qualsiasi regola sanitaria, nessun permesso per occupazione di suolo pubblico e niente scontrini, ovviamente, visto che di registratori di cassa non c'è nemmeno l'ombra. A parte qualche multa ogni tanto, il fenomeno è ben noto e tollerato dalle istituzioni, nonostante si tratti dell'ultimo passaggio di una filiera abusiva che rischia di danneggiare la nostra agricoltura e il mercato. Sui banchi dell'improvvisato market si trovano infatti «ortaggi di dimensioni anomale, non tracciati e modificati in laboratorio», con ogni probabilità provenienti da coltivazioni ricavate da «semi importati illegalmente dalla Cina e coltivati in Lazio, Sicilia e Campania», probabilmente «modificati geneticamente o ibridati», dunque potenzialmente pericolosi per le coltivazioni autoctone. A Ferrara, fino a qualche tempo fa, andava di gran moda un giro d'affari illecito che utilizzava come moneta di scambio i buoni pasto della Coop forniti ai richiedenti asilo, ospiti delle strutture di accoglienza. Funzionava così: nel pacchetto da 35 euro al giorno, previsto per il mantenimento dei finti profughi, erano compresi anche i buoni spesa per l'approvvigionamento autonomo dei soggetti sistemati presso appartamenti o stanze delle cooperative locali. I buoni venivano consegnati direttamente agli immigrati e avevano stampigliato, oltre al marchio del supermercato convenzionato, anche il logo della coop ospitante, in modo da diventare tracciabili. Per evitare di incorrere in qualche controllo sugli acquisti, però, i finti profughi avevano trovato una strada alternativa: svendevano i buoni spesa nei market gestiti da cinesi a un prezzo inferiore al loro valore e in cambio ottenevano la possibilità di rifornirsi liberamente di alcol o cibi etnici. E anche per i gestori si trattava di un affare: una volta accumulati i buoni, pagati la metà del valore, questi si recavano nei supermercati a marchio Coop per fare incetta, a loro volta, di articoli scontati, da rivendere poi negli stessi minimarket, a prezzo pieno. <div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem1" data-id="1" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/violenze-omicidi-e-isis-ecco-che-cosa-si-nasconde-nei-negozi-degli-egiziani-2627246208.html?rebelltitem=1#rebelltitem1" data-basename="cibi-non-tracciati-igiene-carente-gli-stranieri-ci-rovinano-la-tavola" data-post-id="2627246208" data-published-at="1770307524" data-use-pagination="False"> Cibi non tracciati, igiene carente: gli stranieri ci rovinano la tavola Ogni anno, gli italiani ordinano sulle piattaforme di Food delivery oltre 25.000 chili di sushi. I ristoranti etnici, nel nostro Paese, sono più di 50.000. Ci sono 13.000 minimarket gestiti da bengalesi e più di 6.000 frutterie egiziane. Ma dietro la proliferazione di pesce crudo, involtini primavera, alimentari aperti 24 ore e arance a buon mercato, spesso c'è del marcio. Letteralmente. Cibo non tracciabile o mal conservato. Locali laidi. Dipendenti in nero. E, addirittura, spaccio di droga. Per Coldiretti, il 20% delle merci straniere non rispetta le norme italiane su ambiente, sanità e lavoro. A novembre, a Modena, i Nas hanno sequestrato 122 chili di carne e pesce congelati in un minimarket etnico. Gli alimenti erano totalmente privi di etichette. Impossibile stabilire da dove venissero e quando scadessero. Stessa scena, poche settimane dopo, nel Chietino: 2.800 euro di merce non etichettata. A fine novembre, in Friuli Venezia Giulia, i Nas hanno visitato i market gestiti da romeni, ucraini e ungheresi. Nell'Europa dell'Est, infatti, è in atto un'epidemia di peste suina. La malattia non è trasmissibile all'uomo, ma se si trasporta bestiame infetto, si rischiano di contagiare altri animali. Dai controlli non è emersa traccia del virus. Ma di 200 chili di carne era impossibile conoscere provenienza e scadenza. Con la carne, i negozi etnici hanno un rapporto complicato. Il caso più eclatante a Latina. I Nas avevano dovuto mettere i sigilli a un minimarket con annesso laboratorio di sezionamento di carni congelate, allestito in un bagno fatiscente e ovviamente lurido. Pure con il pesce si casca male. La scorsa primavera, nell'Aquilano, i Nas avevano sequestrato ben 300 chili di sushi e sashimi, prodotti senza notifica alle autorità (che è obbligatoria nel caso di prodotti ittici da consumare crudi). Non bisogna fidarsi nemmeno degli ingrossi cinesi. A fine ottobre, i Nas di Roma e Parma hanno trovato, in confezioni di brodo aromatizzato al pollo vendute da un grossista, «ingredienti di origine animale non dichiarati in etichetta». Insomma, nel brodo di pollo non c'era solo il pollo. Non mancano le irregolarità neppure nelle rivendite di frutta e verdura. A Pavia, due commercianti egiziani sono stati multati per la mancata tracciabilità dei prodotti ortofrutticoli. A Pescara, i Nas hanno documentato gravi carenze igienico-sanitarie in un'ortofrutta gestita da nordafricani. C'è pure il capitolo dei lavoratori in nero. Nella zona di Mantova, a novembre, la Guardia di finanza ha disposto lo stop per un negozio etnico che impiegava vari dipendenti irregolari. Ad Alba Adriatica, in Abruzzo, i carabinieri avevano sorpreso un dipendente in nero in un esercizio commerciale gestito da uno straniero. Sul litorale Catanzarese, i Nas ne avevano trovati altri in un ristorante orientale. Al Lido di Venezia era scattata la sospensione per alcuni negozi etnici di cittadini del Bangladesh. I market stranieri sono, notoriamente, luogo di bivacco. Matteo Salvini aveva promesso una stretta sugli orari di chiusura nel dl Sicurezza. Ma di questa disposizione, nel testo finale si sono perse le tracce. E così, i negozietti di cingalesi, indiani e bangladesi continuano a rifornire di alcol a poco prezzo il popolo della notte. E c'è persino chi, dietro la vetrina, nasconde il traffico di droga. È successo a Prato, dove, ad agosto, era stata disposta la sospensione per un minimarket etnico. La titolare, una nigeriana di 32 anni, consentiva agli spacciatori del luogo di smerciare gli stupefacenti all'interno del suo punto vendita. Sarà stato per solidarietà: le forze dell'ordine avevano già arrestato suo fratello, sorpreso con due dosi di eroina mentre usciva dal negozio. La colonizzazione del nostro Paese passa per i sushi bar alla moda e i più modesti minimarket etnici. I commercianti italiani lo denunciano da anni: dove prima c'erano vetrine eleganti, adesso compaiono frutterie-bugigattolo. Le attività degli stranieri crescono a ritmi cinque volte superiori rispetto a quelle dei nostri connazionali. Di questo passo, tra pochi anni resteranno solo loro. Visti i cibi che somministrano, faranno prima a sostituirci o ad avvelenarci?
Bill Clinton e Jeffrey Epstein (Ansa)
Dai documenti declassificati spuntano però altri orrori: secondo i documenti rilasciati dal Doj, Epstein sarebbe stato implicato anche in un folle progetto di eugenetica, costringendo vittime minorenni a portare in grembo suoi figli attraverso maternità surrogata per creare un «pool genetico superiore», così riferisce una presunta vittima in un diario straziante in cui si lamenta di essere stata una «incubatrice umana» per Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell. I due avrebbero sottratto alla donna la sua neonata pochi minuti dopo il parto. Già nel 2019 il New York Times aveva raccontato che Epstein pianificava di utilizzare la sua tenuta fuori Santa Fe per «ingravidare» le sue vittime, «20 alla volta», nel tentativo di «inseminare la razza umana con il suo Dna».
Dai file desecretati oggi emerge anche che Jeffrey Epstein è stato contattato nel 2018 dal bio-hacker Bryan Bishop per finanziare segretamente la creazione del primo bambino geneticamente modificato, o addirittura clonato, entro 5 anni. Esperimenti preliminari (test e modificazioni embrionali) erano già in corso in un laboratorio in Ucraina. Bishop chiedeva 1,7 milioni di dollari all’anno per un massimo di 5 anni per un totale di 9,5 milioni, oltre a un ulteriore milione per la configurazione del laboratorio, garantendo il totale anonimato degli investitori: in caso contrario, il bambino sarebbe stato visto dai media come un «mostro» o un «fenomeno da baraccone». «Abbiamo una serie di domande su quanto fai sul serio», scriveva Bishop a Epstein nel luglio 2018, «la maggior parte di queste domande riguarda i tuoi requisiti di segretezza e privacy, il rischio reputazionale e anche qualsiasi coinvolgimento finanziario». Il faccendiere non aveva fretta, «no rush», ma rispondeva a Bishop di non aver problemi a investire, «il problema è soltanto se vedono che dietro ci sia io».
Non soltanto lui, a dire il vero: una delle parti più interessanti dei file riguarda le relazioni di Epstein con il mondo della scienza. Anche se ci sono poche prove che il suo programma transumanista sia andato avanti, scienziati di spicco, tra cui Stephen Hawking, hanno partecipato regolarmente a cene, pranzi e conferenze tenute da Epstein. «Tutti si sono domandati se questi scienziati fossero più interessati alle sue opinioni o ai suoi soldi», ha dichiarato l'avvocato Alan Dershowitz, che ha difeso Epstein nel 2008. Fatto sta che la cerchia del faccendiere includeva pezzi grossi della comunità scientifica: il pioniere della genomica e della biologia sintetica George Church, Murray Gell-Mann, il biologo evoluzionista Stephen Jay Gould, il neurologo Oliver Sacks e il premio Nobel per la fisica Frank Wilczek.
Epstein ha anche generosamente finanziato l’università di Harvard con 6,5 milioni di dollari, ma il prestigioso ateneo si è rifiutato di restituire i soldi nonostante il regolamento preveda di rifiutare i contributi dei donatori che hanno guadagnato i propri soldi in modo immorale. L’arma del faccendiere, insomma, era la corruzione attraverso sesso e soldi: nessun esponente dell’élite progressista sembra essere sfuggito alla sua rete d’influenza.
Continuano nel frattempo le reazioni dopo le dimissioni a catena degli ex amici di Epstein, a cominciare da Lord Peter Mandelson, laburista: «Ha mentito ripetutamente al mio staff, mi pento di averlo nominato», ha dichiarato il premier britannico Keir Starmer che, sotto gli attacchi della leader dell’opposizione conservatrice Kemi Badenoch, ha dovuto riconoscere formalmente di essere stato a conoscenza dei rapporti tra Epstein e Mandelson. Anche Bill Gates, minimizzando l’entità delle relazioni con il faccendiere, ha ammesso in un’intervista di essere stato «sciocco» e di essersi pentito di averlo mai conosciuto, pur liquidando come «falsa» l’email mandata da Epstein a sé stesso, in cui il faccendiere si rivolgeva a Gates: «Mi implori di cancellare le email sulla tua malattia sessualmente trasmissibile, sulla tua richiesta che io ti fornisca antibiotici che puoi dare di nascosto a Melinda e sulla descrizione del tuo pene». «Non sono mai andato all’Isola, non ho mai incontrato donne», si è difeso Gates. Sarà, ma la ex moglie Melinda French Gates ha esortato l’ex marito Bill a «rispondere del suo comportamento» aggiungendo che «nessuna ragazza dovrebbe mai essere messa in una situazione del genere». «Le domande in sospeso sono per il mio ex marito, non per me», ha aggiunto, esprimendo «un’enorme tristezza «per le vittime dei crimini del defunto finanziere.
Continua a leggereRiduci
Il volto dell'angelo con le fattezze di Giorgia Meloni rimosso dall'affresco di San Lorenzo in Lucina (Ansa)
Considerando che per pulire gli obbrobri dei writer dalle pareti dei palazzi passano anni, a stupire sono la rudezza del gesto e la fretta. Scoperta venerdì, la somiglianza dell’angelo che regge una pergamena dell’Italia era stata oggetto nell’ordine: del consueto malpancismo dell’opposizione, del sorriso divertito della modella involontaria, della promessa di sopralluogo della Soprintendenza, necessario nel caso di beni artistici. E infine della decisione del Rettore del Pantheon e della basilica romana, monsignor Daniele Micheletti, di pianificare un’approfondita verifica. Quest’ultima è durata tre minuti. Come se si dovesse far fronte a un allarme sociale per lo sfregio alla Vergine delle Rocce o il profilo pittato fosse quello di Giordano Bruno o della Papessa Giovanna.
La faccenda è inutilmente in evoluzione, l’architetto Cino Zucchi ha rivelato su Instagram di avere trovato il profilo originale pre-restauro nell’account di «Roma Aeterna» e sarebbe diverso, ma con le bufale digitali vatti a fidare. Prima di toccare l’affresco di solito è necessaria una perizia ufficiale con un rigoroso iter istituzionale. In questo caso no, via con la cara procedura Stalin, che cancellava dalle foto i gerarchi caduti in disgrazia. «Ho coperto quel volto perché me lo ha chiesto il Vaticano», ha allargato le braccia Valentinetti. In effetti le pressioni sono state micidiali.
Ha cominciato il cardinal Baldo Reina: «Provo profonda amarezza, le immagini di arte sacra non possono essere oggetto di utilizzi impropri o di strumentalizzazioni, essendo destinate esclusivamente a sostenere la vita liturgica e la preghiera personale e comunitaria». Ha continuato padre Giulio Albanese, responsabile della comunicazione del Vicariato di Roma: «L’originale era diverso, tutto ciò è imbarazzante». Così monsignor Micheletti, che adesso rischia il posto, guardacaso solo ieri si è accorto che «l’opera presentava fisionomie non conformi all’iconografia originale e al contesto sacro». E ha ordinato l’imbiancata.
L’ha fatto togliere di torno e buonanotte, occhio non vede cuore non duole. Soprattutto quello della fazione turbo-progressista del cattolicesimo in ambasce, dal cardinal Matteo Zuppi ad Andrea Riccardi della comunità Sant’Egidio, dalle Caritas alla galassia cattodem già sul piede di guerra e solitamente poco dotata di ironia. Eppure proprio la Chiesa dovrebbe avere metabolizzato quelle che chiama «contaminazioni», cominciate quando Leonardo Da Vinci nel Cenacolo diede a Giuda il volto dell’abate domenicano che lo stava sfrattando da Santa Maria delle Grazie per la lentezza nell’avanzamento (capo)lavori.
Quanto all’indignazione del cardinal Reina per l’«uso improprio delle immagini di arte sacra», sarebbe interessante sapere perché non è rimasto egualmente scosso quando nella cattedrale di Terni è comparso un enorme affresco omoerotico con gruppi laocoontici di corpi intrecciati e con l’allora vescovo Vincenzo Paglia raffigurato felicemente con lo zucchetto episcopale nella «Resurrezione genderfluid». O peggio quando si scoprì che il crocifisso della cappella dell’ospedale Papa Giovanni di Bergamo aveva il volto di Claudio Galimberti, capo ultrà dell’Atalanta, pregiudicato con record di daspo. L’artista Andrea Mastrovito ha sempre rivendicato la burla. Da un decennio, il paziente che si raccoglie in preghiera prima di un intervento chirurgico salvavita, non prega Gesù ma il Bocia. Non risultano note vibranti della Santa Sede.
Accortasi che l’affresco in San Lorenzo in Lucina è diventato la lavagna della Terza C, la Soprintendente di Roma, Daniela Porro, in accordo con il ministero della Cultura ha fatto sapere agli zelanti sacerdoti che «alla luce della cancellazione del volto della decorazione, per qualsiasi intervento di ripristino è necessaria una richiesta di autorizzazione non solo al Vicariato ma al Fondo edifici di culto del ministero dell’Interno, proprietario dell’immobile, con accluso bozzetto». Così, per evitare che compaia il profilo di Ilaria Salis, sul quale nessuno avrebbe nulla da ridire.
Come spesso accade i più delusi sono i fedeli, che domenica hanno affollato la chiesa come non accadeva da anni anche per via di quel cherubino dall’aspetto tanto famigliare. Monsignor Micheletti ha dovuto ammettere: «È stata un’autentica processione, ma venivano per vederlo e non per pregare». Dovrebbe essere contento, visto che le vie del Signore sono infinite.
Continua a leggereRiduci