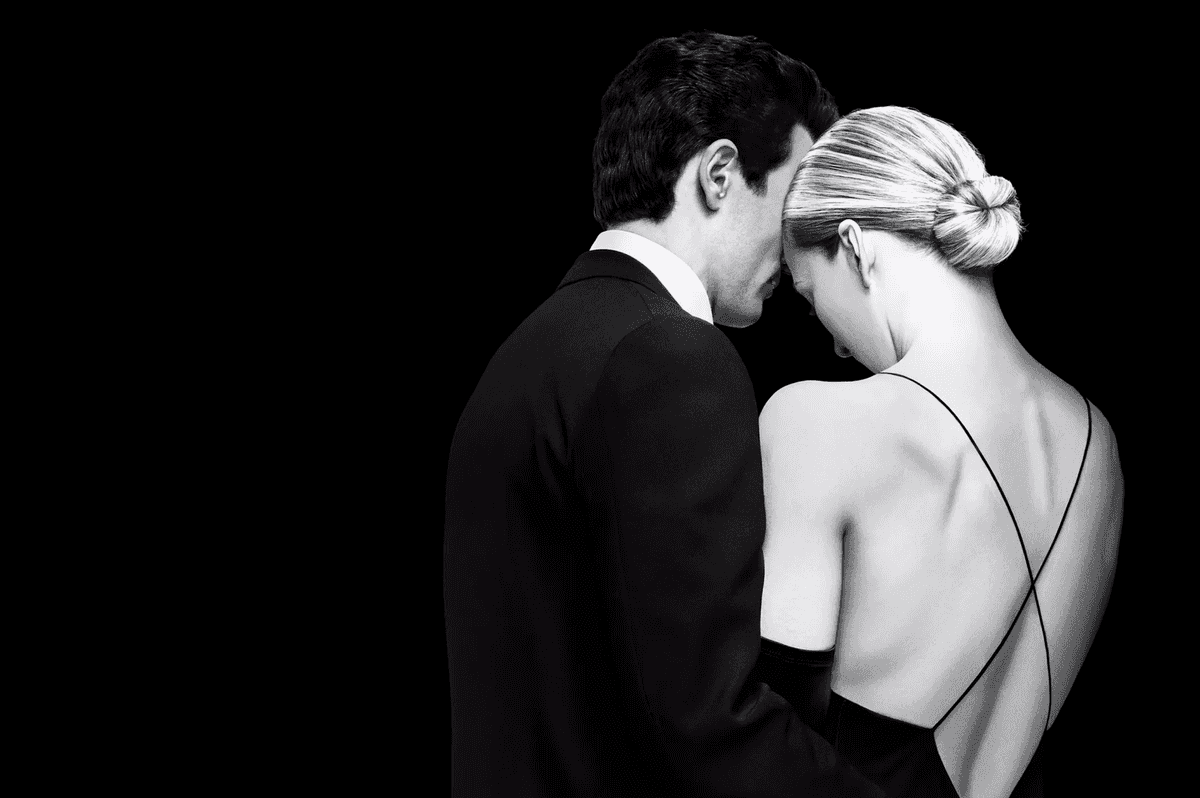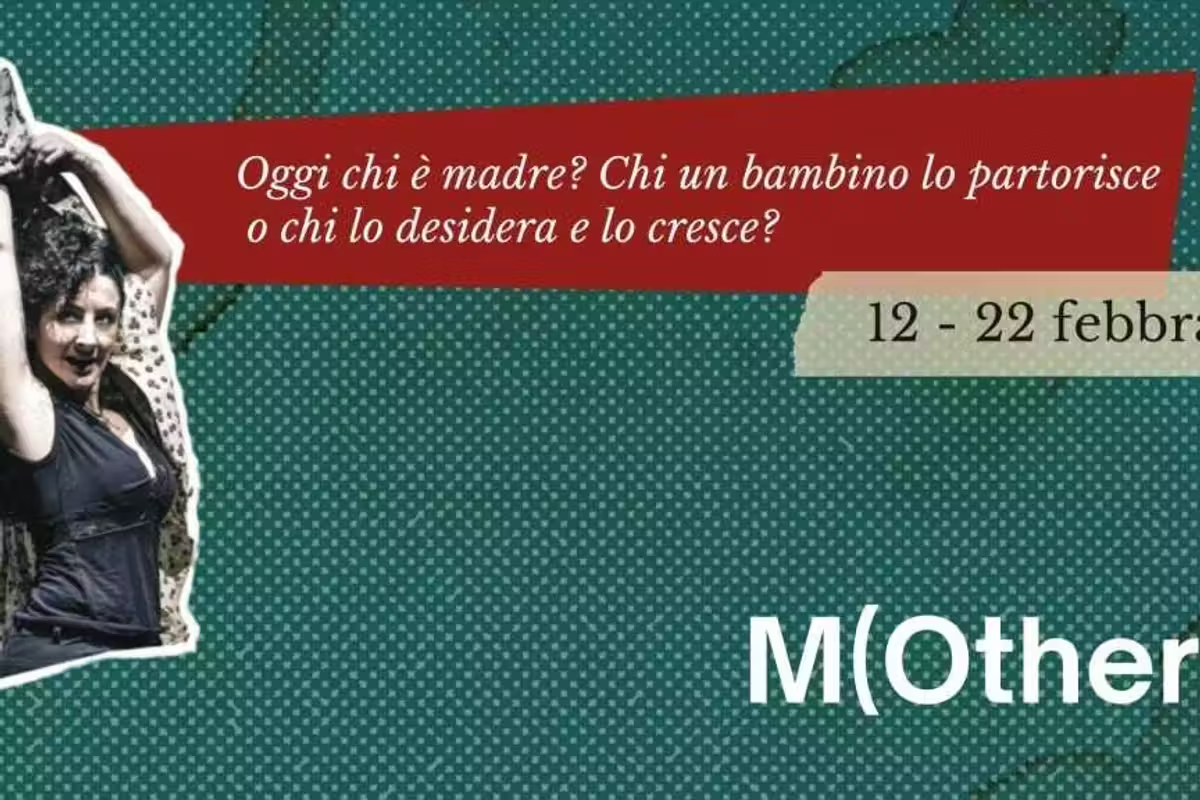«Oh com'è bella l'uva fogarina/ Oh com'è bello saperla vendemmiar/ A far l'amor con la mia bella/ A far l'amore in mezzo al pra'». La canzone dell'uva fogarina, cantata e suonata dal Duo di Piadena, era la chiave d'accensione della festa dell'uva sull'aia. Bastavano poche note e i vendemmiatori si allacciavano nella polka. Orietta Berti rispose con La Vendemmia: «L'amor si fa in campagna e non al mare,/ venite tutti quanti qui a ballare».
Un tempo - fino a 60-70 anni fa- vendemmia faceva rima con amore, amicizia, allegria, canzoni, cori, balli, pigiature a piedi nudi e gambe di belle contadinotte scoperte fino alle cosce. Ci si inebriava a raccogliere l'uva prima ancora di berne il vino. Marie Laforêt, la «ragazza dagli occhi d'oro», chiamata così per gli scintillanti riflessi gialli delle pupille, cantava con voce innamorata: «Quest'autunno noi faremo/ sotto il cielo più sereno/ la vendemmia dell'amore./ Tu cadrai nelle mie braccia/ come i grappoli dell'uva che teniamo nelle mani...». Erano gli inizi degli anni Sessanta. Giovani e adolescenti, sognando di vedersi piombare l'amore tra le braccia come i grappoli di merlot, cabernet e chardonnay cadevano nei bigonci, accorsero in campagna ad offrirsi come vendemmiatori. A quei tempi le scuole cominciavano il 1° ottobre. C'era tutto il tempo di vendemmiare l'uva e raccogliere qualche passioncella.
Da che mondo è mondo c'è sempre stata una componente erotica nella vendemmia. Il veronese Milo Manara, fumettista di fama mondiale, ne sa qualcosa se è vero che ha scoperto da ragazzino l'eros che elettrizza le sue vignette guardando le gambe delle ragazze che pigiavano l'uva durante una vendemmia. «Non è andata proprio così», racconta, «perché quand'ero ragazzino l'uva non si pigiava più con i piedi. È vero, però, che i ricordi erotici più remoti sono legati alla vendemmia. Alle portarine. Erano ragazze floride, giovani donne che scendevano dalle montagne dell'alta Valpolicella per la vendemmia. Avevano l'incarico di trasportare plateau di molinara, rondinella e corvina. Si spostavano dai vigneti ai fruttai delle cantine riempendo la valle con i loro canti. Di notte le portarine dormivano sotto i portici delle ville e nei fienili dai quali si alzavano bisbigli, sussurri, mormorii. Le ragazze erano in compagnia di qualcuno. Bastavano quelle voci basse e quei rumori sommessi a scatenare la mia fantasia, a sollecitare l'immaginario erotico. La vendemmia e l'odore del mosto che riempiva l'aria di quelle notti facevano da contorno. Erano stagioni esaltanti».
Fin dall'antichità la vendemmia è stata fonte di gioiosa spontaneità popolare. Parecchia, se non quasi tutta, oggi si è persa. La meccanizzazione della raccolta delle uve ha cancellato cori, balli e sguardi complici che s'incrociavano tra i tralci e i grappoli di garganega, sangiovese, passerina... Poi ci si è messa la burocrazia che impedisce a vicini e allegri compagnoni di accorrere a dare una mano agli amici vignaioli. Pretendendo che siano messi in regola anche i parenti, ha frantumato quella ubriacante socialità che, in nome del vino, durava da millenni. Giovanni Pascoli ne dà una pennellata nella poesia La vendemmia: «Così staccavi la dolce uva, alfine,/ co' tuoi vicini, ché i vicini sono/ mezzo parenti, e con le tue vicine, o Rigo...». Com'è successo con le feste spontanee, sono finite nell'albo dei ricordi anche molte varietà di uva. La stessa uva fogarina del Duo di Piadena, uva a bacca rossa coltivata intensamente in Emilia ai primi del Novecento è stata lì lì per sparire. Se c'è ancora è grazie alla Cantina sociale di Gualtieri (il paese del pittore Antonio Ligabue) che in questi ultimi anni ha recuperato vitigno, uva e vino.
La stagione della vendemmia conserva, comunque, un entusiasmo antico anche se le esultanti ed esaltanti atmosfere vendemmiali di una volta si sono concentrate in folkloristiche feste locali della vendemmia e dell'uva. Sono le eredi delle Giornate della frutticultura e del vino e delle successive Feste nazionali dell'uva istituite dal regime fascista (come quelle del pane e del gelso) per «diffondere il consumo dell'uva, di cui sono note le benefiche qualità nutritive e dietetiche e di dare incremento ad un importante ramo della produzione agraria».
Quando avvenne la prima vendemmia? I miti e le leggende dei popoli antichi la fanno risalire ad eroi o patriarchi. Per gli ebrei fu Noè che dopo il Diluvio piantò, 5400 anni fa, la vite alle falde del monte Ararat, dove si era incagliata l'arca una volta finito il diluvio. Noè fu anche il primo a gustare il succo dell'uva e a conoscere l'ebbrezza che esso procurava. Per i Sumeri fu il re-eroe Gilgamesh (secolo più, secolo meno, siamo a 4000 anni fa) a far conoscere il vino dopo l'incontro con Siduri, la «donna della vigna», l'»ostessa sacra», che stava raccogliendo il vino in una coppa d'oro nel suo vigneto sacro. I Greci identificarono nell'orgiastico Dionisio, figlio di Zeus e di Sèmele, il divino vendemmiatore. Stesso dio per i Romani che lo chiamarono Bacco e in suo onore inventarono i Baccanali, riti propiziatori nei quali non esistevano più freni morali, tanto che alla fine il Senato li proibì.
Coltivavano la vite gli Egizi che ne lasciarono traccia negli affreschi delle tombe dei faraoni, i popoli mesopotamici, gli Etruschi che consumavano vino in abbondanza nei loro banchetti raffigurati nelle sepolture: partire per l'aldilà senza il giusto carburante non era buona cosa: si rischiava di non arrivare.
Gli ampelografi, cioè gli archeologi e gli storici che studiano la vite (in greco ampelos) indicano nell'Anatolia orientale, dove si alza il monte Ararat (quello di Noè) l'origine della vitis vinifera, cioè della vite comune, quella che ci dà le uve a bacca bianca o rossa che rivestono tutte le colline italiane. Furono i Greci a introdurre la vite in Italia dove crebbe talmente bene che quegli uomini provenienti dall'Arcadia chiamarono Enotria, e cioè il paese della vite, le terre da essi colonizzate.
Le vendemmie e il vino scandiscono le stagioni della letteratura fin dall'antichità. Socrate loda la temperanza: «I piccoli sorsi sono come la rugiada». Omero prima di lui, nell'Odissea, chiama il vino «pazzo» perché rende allegri i saggi, ma fa dir loro anche qualche castroneria. Euripide, nelle Baccanti, dice che «Dove non c'è vino non c'è amore». Platone ringrazia gli dèi per il dono «eccellente e prezioso». Anche i letterati latini vendemmiano citazioni e perle di saggezza. Da Plinio («In vino veritas») a Lucrezio, da Marziale a Orazio, da Virgilio a Catullo, a Cicerone («O bevi o vattene»). Marco Terenzio Varrone dà indicazioni precise sulla vendemmia. «Quando nei vigneti l'uva sarà matura, è opportuno vendemmiare, ma scegli bene da quali generi di uve e da quale parte del vigneto iniziare». Secoli dopo il sobrio Dante Alighieri spiega l'essenza dell'anima usando la vite e il vino come esempio: «E perché meno ammiri la parola,/ guarda il calor del sole che si fa vino,/ giunto a l'omor che de la vite cola».
Ma la vendemmia e il vino, non sono solo letteratura: sono arte, musica, cinema, fotografia, scienza, tecnica, chimica. Sono religione. E se San Giovanni nell'Apocalisse ci spaventa sulla vendemmia finale («Un altro angelo uscì dall'altare e gridò a gran voce a quello che aveva la falce affilata: “Metti mano alla tua falce affilata e vendemmia i grappoli della vigna della terra, perché le sue uve sono mature". L'angelo lanciò la sua falce sulla terra e vendemmiò la vigna della terra e gettò l'uva nel grande tino dell'ira di Dio»), meno male che Gesù nel Vangelo, ci rincuora nella parabola dei vignaioli: «Gli ultimi saranno primi» e definendosi «vite» chiama noi «tralci» invitandoci a dare frutto. Nell'ultima cena, poi, trasformando il vino nel suo sangue, ci invita a berlo come «bevanda di salvezza».