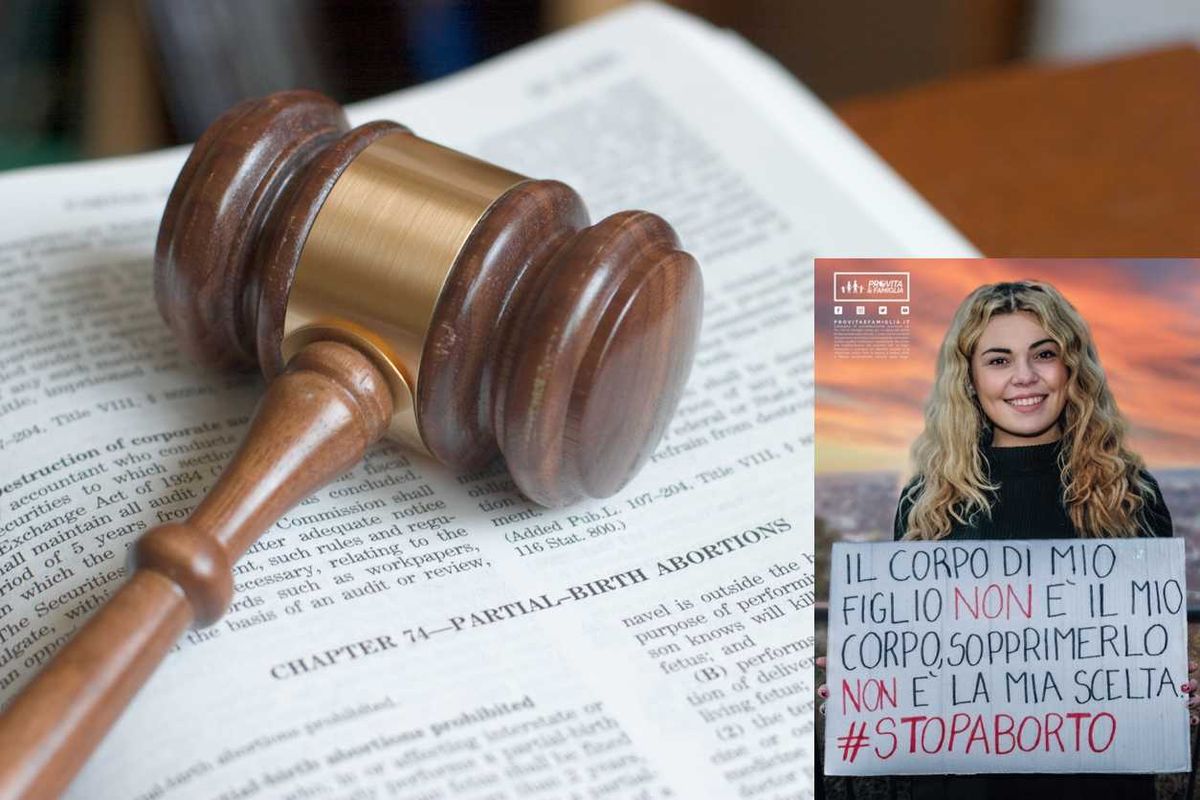Uva dai mille usi. Tutte le virtù di un orgoglio italiano di cui non si butta via niente

Notoriamente, cade tra la fine di agosto e l'inizio di settembre il periodo cosiddetto della vendemmia, parola che viene dal latino vindemia, è composta da vinum (vino) e demere (levare) e indica la «levata» - dalla pianta - dell'uva da vino, gemella diversa dell'uva da tavola: la raccolta di quest'ultima non ha un sostantivo specifico com'è invece per quella da vino. Si raccoglie a settembre anche l'uva da tavola e infatti la saggezza popolare ha consacrato vari proverbi che giustappongono questo bel tipo di frutta al mese appena cominciato: da «Settembre, l'uva è fatta e il fico pende» a «Se fa bello a SSan Gorgone, la vendemmia va benone» (San Gorgone è il 6 settembre) passando per «Da settembre prima la bianca che di pendere è già stanca» (cioè va raccolta prima l'uva bianca, poi quella nera).
Noi italiani siamo magistrali produttori di uva da tavola, di uva da vino e di vino. Deteniamo infatti lo scettro mondiale della produzione di vino, essendo i primi produttori al mondo con 48,5 milioni di ettolitri (dati Federvini 2018), seguiti da Francia, Spagna e Stati Uniti. Quanto alla produzione di uva, la Cina è la prima produttrice mondiale con 13,7 milioni di tonnellate nel 2017 (19% del totale), seguita però da noi (6,9 milioni di tonnellate), Stati Uniti (6,7) e Francia (5,5). Sono i dati del rapporto sullo stato della vitivinicoltura mondiale elaborato da Oiv nel 2018 e sono confermati da quelli Istat relativi al 2019: abbiamo adibito alla coltivazione di uva da vino 646.473 ettari per una raccolta di 68.537.495 quintali, mentre per l'uva da tavola abbiamo impiegato 46.725 ettari e raccolto ben 10.091.089 quintali.
La «doppia vita» dell'uva, come base per il vino oppure frutta da mangiare come tanta altra, nasce nell'antichità. La Vitis vinifera è stata scoperta in Asia oltre 9.000 anni fa e già a partire dal 7000 a.C. i cinesi facevano fermentare quella selvatica per ottenere una bevanda che si può considerare antenata dell'attuale vino. Nei millenni seguenti, l'uva, ormai addomesticata, si diffuse a Sud e a Ovest della Cina, così giungendo fino al Medio Oriente, l'Egitto e l'Europa. I sumeri e i babilonesi mangiavano uva fresca e secca, poi usavano quest'ultima e il succo d'uva fresca come dolcificanti. Si tratta di una pratica in uso ancora oggi: guardando gli ingredienti di molte marmellate «senza zucchero» (intendendo senza zucchero da barbabietola o canna) troverete che sono spesso preparate con succo d'uva, che come quello di mela dolcifica e gelifica perfettamente. In Egitto, il vino era riservato alle cerimonie e all'élite della società, i greci dedicarono alla raccolta dell'uva il dio Dioniso che i romani, adoratori anche in senso figurato dell'uva in ogni forma, chiamarono Bacco.
Usata, passa, in molte salse per il pesce vario lesso, l'uva diventa ingrediente culinario a tutti gli effetti nel De re coquinaria di Apicio (dove, anche, si spiega come conservare i grappoli in acqua per gustarla fresca oltre la raccolta e come fare mosti da impiegare a mo' di dolcificanti come caroenum, defrutum e sapa). Tale è confermata dal Medio Evo nel piatto di nome frumenty, un porridge a base di grano bollito con latte e brodo e servito accanto a carne e pesce molto diffuso in Europa occidentale. E poi anche da preparazioni «dolci» natalizie come lo stollen tedesco e il panettone con uva passa milanese, oltre al dolce, però pasquale, russo kulich.
L'uva è un esempio perfetto di prodotto agricolo del quale non si butta via niente o quasi. Il grappolo d'uva è l'infruttescenza della vite; le sue bacche, che chiamiamo anche acini o chicchi, sono attaccate al complesso di ramificazioni di nome raspo. Anche detto rachide, il raspo (o graspo) è l'asse centrale del grappolo che si sviluppa in racimoli e pedicelli sui quali prima nascono i fiori e poi i frutti, cioè, appunto, gli acini, su di esso raggruppati (cercate immagini della vite in fiore, se non potete vederla dal vero, è bellissima). Se i chicchi si mangiano freschi, coi raspi dell'uva passati ai trinciaraspi si ottiene un fertilizzante. Dai semi, poi, si estrae l'olio di vinaccioli.
Anche le foglie si mangiano: non soltanto in Grecia, nei deliziosi involtini di foglie di vite ripieni di riso speziato detti dolmades, antipasto talmente caratteristico che le foglie per prepararlo si trovano al supermercato conservate in barattolo. Questi begli involtini si sono diffusi anche nell'Est Europa (in Romania si chiamano sarmale e sono un piatto tipico nazionale) e in Medio Oriente (in Turchia si chiamano sarma). Anche in alcune zone d'Italia le foglie di vite potate e non reinterrate come concime vengono usate per ricette tanto antiche quanto saporite: in Puglia, per esempio, ci si prepara il pesto.
L'uva si mangia anche conservata, elaborata in forma di confettura d'uva oppure intera nella classica preparazione dell'uva sotto spirito. Si mangia poi secca, in forma di uva passa anche detta uvetta o zibibbo, soprattutto nei dolci ma non solo, lo testimonia la ricetta campana della pizza di scarola. Si mangia, ancora, «liquida», cioè in forma di succo d'uva.
Questo composito consumo dell'uva probabilmente deriva dal fatto che essa è ricchissima in ogni sua parte. I semi, anche detti vinaccioli, contengono protoantocianidine oligomeriche, vitamina E e acido linoleico, tanto che se da una parte si preferiscono le varietà senza semi perché sono più semplici da mangiare, dall'altra c'è chi invece cerca quelle con tanti semi, che non toglie dagli acini ma mangia proprio per fare il pieno di quei bioflavonoidi anche noti con l'acronimo Opc.
Presenti anche nella corteccia di pino marittimo, nei semi di ippocastano, nelle bacche di mirtillo nero e mirtillo rosso americano, nonché in quelle di cipresso, gli Opc dell'uva hanno però la caratteristica di trovarsi in un alimento molto più consumato dei precedenti. Ricordiamoci che i vinaccioli vengono anche pressati nella realizzazione del vino e annotiamo che gli Opc sono utili innanzitutto a chi soffre di insufficienza venosa cronica, varici, sindrome emorroidaria e disturbi circolatori in generale.
Gli Opc inoltre proteggono i tessuti dalla degradazione del collagene e dell'elastina, che sono importanti proteine costitutive del tessuto connettivo, proteggono dai danni dei radicali liberi, sono antiossidanti, immunostimolanti, proteggono i vasi sanguigni e potenziano il microcircolo, risultando di aiuto nei casi di edema, e in generale, contro le infiammazioni. Anche se non si ama bere vino e non si usa mangiare uva coi vinaccioli, si può beneficiare del loro effetto positivo usando ogni tanto, per esempio, l'olio di vinaccioli al posto di quello di oliva per condire.
Importante per la salute è anche l'uva passa: sicuramente, ai fanatici dei soli superfood esotici essa parrà un residuato di una concezione antiquata dell'alimentazione e anche colpevolmente zuccherosa, quando i suoi zuccheri sono naturali e non aggiunti, tanto che da qualche anno vediamo in commercio i panettoni senza uvetta. In realtà, tramite l'essiccazione, l'uvetta vede trasformarsi il fruttosio in fructan, «fibra solubile che assorbe ed elimina il colesterolo e alimenta la flora batterica intestinale», ci spiega il libro I cibi della salute. Mangiare sano per stare bene. Cercate un prebiotico che non sia un latticino? Mangiate uvetta.
Anche le foglie della vite sono ricche di proprietà salutari e infatti, oltre agli integratori che ne contengono estratti, si iniziano a trovare conservate intere anche nei negozi nostrani. Sono ricche di antociani, un tipo di polifenoli con effetto antiossidante, antinfiammatorio, antitumorale, antimicrobico e cardioprotettivo. Proteggono il fegato e lo stomaco dalle infiammazioni che possono degenerare in altre patologie, allo stesso modo difendono il sistema nervoso centrale riducendo stress ossidativo e infiammazione in malattie neurodegenerative come morbo di Parkinson e morbo di Alzheimer, stimolano la vascolarizzazione con azione vasoattiva e vasoprotettiva, tanto che l'estratto di foglie di vite viene utilizzato nella terapia ormonale sostitutiva a lungo termine in donne con flebopatia agli arti inferiori.
E i chicchi? Anche qui, dovendo decidere una classifica delle proprietà salutari c'è solo l'imbarazzo della scelta, tanto che la dieta monotematica a base di uva non è una dieta dimagrante ma una terapia. Si chiama ampeloterapia ed è una cura di due-tre giorni a base di soli chicchi d'uva già in uso presso gli antichi arabi, greci e romani per disintossicare, depurare e ricostituire l'organismo e riattivare le funzioni epatiche e intestinali, da non provare assolutamente col fai da te, ma la cui esistenza è indicativa delle numerose proprietà salutari dei nostri acini.
Con 61 calorie ogni 100 grammi, gli acini d'uva presentano 80,3 grammi di acqua, circa 15 di zuccheri solubili e 1,5 di fibra: idratano, saziano, aiutano la motilità intestinale e contrastano la stanchezza, non solo per gli zuccheri, anche per il favonolo quercetina. Si potrebbe pensare che mangiare uva ingrassi per via degli zuccheri: no, perché l'uva aumenta nel sangue il livello di leptina, cioè l'ormone che comunica la sazietà, quindi concedetevene un po' anche se siete a dieta.
Mangiate sempre gli acini con la buccia: è ricca di resveratrolo, uno stilbene che protegge innanzitutto il cuore e fluidifica il sangue (da qui il detto che il vino faccia buon sangue, ma lo fa anche l'uva in chicchi e analcolica). Con tanto potassio (192 milligrammi) e poco sodio (1 milligrammo) aiuta l'organismo a espellere l'acqua in eccesso e le tossine, equilibra la pressione sanguigna e il battito cardiaco.
L'uva nera è più ricca di antocianine, mentre quella bianca è più ricca di flavonoidi. In entrambi i casi parliamo di antiossidanti, quindi mangiate entrambi «i colori». Flavonoidi, antocianine, stilbeni e altri antiossidanti, tutti appartenenti alla categoria dei polifenoli, sono veri e propri scudi contro l'ossidazione e i radicali liberi e costituiscono un grande aiuto a livello epidermico (l'uva fa buon sangue ma anche bella pelle), cardiovascolare, nel contrasto di malattie legate all'invecchiamento e della crescita tumorale.
Aiutano i polifenoli a svolgere questo importante compito difensivo della nostra salute anche le vitamine dei chicchi d'uva, in particolare la C, la K, la A, la B1, la B2 e la B3, che rafforzano il sistema immunitario e conferiscono energia.