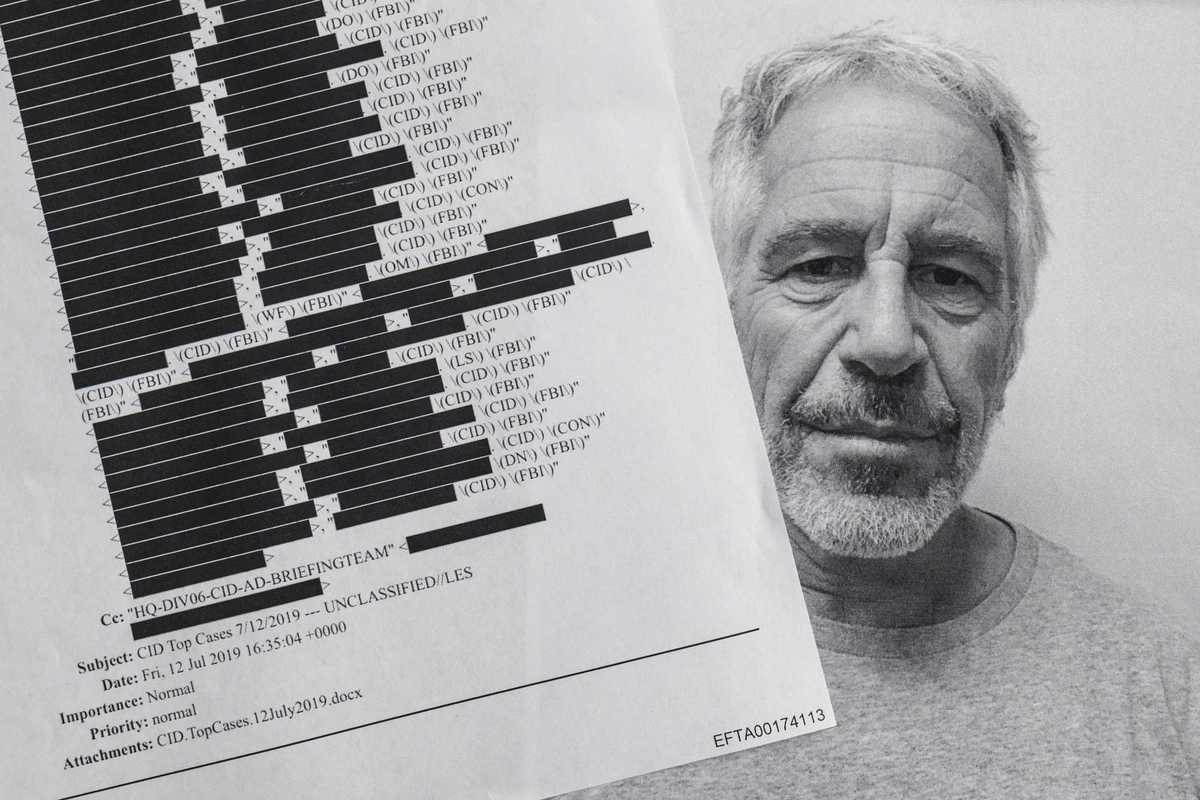Nuove speranze di una terapia genica che aiuti a prevenire l'Alzheimer ci arrivano dai risultati di un esperimento, il primo in assoluto, condotto su persone sane. Aveva preso il via nel 2013 in Colombia, nella regione di Antioquia dove almeno 6.000 abitanti presentano mutazioni che riguardano il gene della presenilina 1 (Psen1), associate alla malattia familiare a esordio precoce. La variante genetica può essere arrivata dalla Spagna con i conquistadores del Nuovo mondo, cinque secoli fa. In questi colombiani che vivono nella regione montuosa con capitale Medellín, la più comune forma di demenza degenerativa è estremamente diffusa e si presenta presto, tra i 40 e 50 anni anziché oltre i 65 come accade nella media delle persone colpite dall'infermità.
Trecento abitanti hanno accettato di farsi trattare con Crenezumab, prodotto dalla società americana di biotecnologie Genentech, consociata di Hoffmann-La Roche. Il farmaco «attacca le placche amiloidi nel cervello che molti studiosi, ma non tutti, ritengono la causa prima dell'Alzheimer», precisa la Fondazione Veronesi. Dei trecento, due terzi erano portatori di mutazione: cento si sono sottoposti a due iniezioni al mese di Crenezumab, cento hanno ricevuto un placebo. Ai cento senza mutazione sono state somministrate sostanze prive di princìpi attivi specifici, per garantire che i partecipanti allo studio non sapessero se erano o meno portatori. Nessuno presentava sintomi di demenza quando ha partecipato all'esperimento.
Altri due test sono stati fatti dopo il 2013, i risultati si conosceranno entro un paio d'anni ma c'è già una notizia incoraggiante. Una donna di 73 anni è la prima ad aver manifestato sintomi leggeri della malattia quasi tre decenni dopo il previsto periodo di insorgenza. Gli studiosi, esaminando il suo cervello, hanno sì trovato una presenza massiccia delle cosiddette placche senili (costituite da aggregati di proteina beta amiloide), specifica dei malati di Alzheimer, ma la paziente aveva livelli molto bassi di tau, la proteina che rende stabili i microtubuli all'interno dei neuroni sani. Il cervello di chi soffre di demenza la produce in grandi quantità, con il progredire dell'Alzheimer le molecole di questa sorta di collante si staccano, formano grovigli e arrivano a interrompere le connessioni neuronali. La distruzione e morte delle cellule nervose causa il crollo della memoria, cambiamenti della personalità, crea problemi.
Se la donna colombiana non presentava alterato quest'altro marker dell'Alzheimer, secondo i ricercatori era perché, oltre alla rara mutazione Presenilin 1 comune a molti colombiani di Antioquia, possedeva due copie della variante del gene Apoe3, chiamata Christchurch, che la proteggono. I risultati di questo studio pubblicato su Nature Medicine suggeriscono che due copie della variante Apoe3ch possono essere la chiave per sviluppare un farmaco che arresti il processo degenerativo che colpisce progressivamente le cellule e le connessioni cerebrali. O permettere una terapia genica anche per prevenire la malattia, che nel mondo colpisce 47 milioni di persone, oltre 1.200.000 in Italia.
Proprio nel nostro Paese, la recente scoperta dell'anticorpo A13 che all'interno delle cellule staminali riuscirebbe a intercettare e neutralizzare gli aggregati tossici (detti oligomeri) che danno inizio all'Alzheimer, sta offrendo nuove speranze di individuare precocemente la patologia e di riattivare nel contempo i neuroni. Lo studio italiano, sviluppato all'interno dell'Ebri (European brain research institute) e coordinato da Antonino Cattaneo, Giovanni Meli e Raffaella Scardigli, al momento solo sul cervello di un topo malato di Alzheimer, lascia prevedere che si possa arrivare a breve a monitorare la neurogenesi nella popolazione adulta. L'osservazione di problemi del cervello umano a produrre nuovi neuroni, in una fase molto precoce della malattia neurovegetativa e prima della comparsa dei segni patologici tipici, consentirà nuove strategie di diagnosi e cura. Interessante anche quanto è emerso dal convegno «Neurodegenerazione e cancerogenesi: quali possibili cause di un'associazione inversa?», organizzato ai primi di dicembre dall'Istituto superiore di sanità. Sono state presentate le evidenze scientifiche epidemiologiche che documentano una relazione inversa tra le malattie neurodegenerative e i tumori. Già da alcuni anni sappiamo che una persona affetta da demenza, o da malattia di Parkinson, ha un rischio quasi dimezzato, rispetto alla popolazione in generale, di ammalarsi di tumori e che «la stessa probabilità al 50% viene stimata per le persone con neoplasie maligne di ammalarsi di malattie neurodegenerative», come si è ricordato durante l'incontro. Oggi però si stanno concentrando gli studi per scoprire i legami tra queste due patologie, cercando di comprendere quali meccanismi biologici ci siano alla base nella lunga fase di latenza, prima che insorgano segni e sintomi. Senza escludere il ruolo che possono svolgere genotossicità, ovvero la capacità di alcune sostanze (come medicinali, prodotti chimici industriali, additivi alimentari e cosmetici) di danneggiare l'informazione genetica all'interno di una cellula e il ruolo degli oncogeni, geni normali che hanno subìto mutazioni e possono favorire la comparsa dei tumori.



 iStock
iStock iStock
iStock