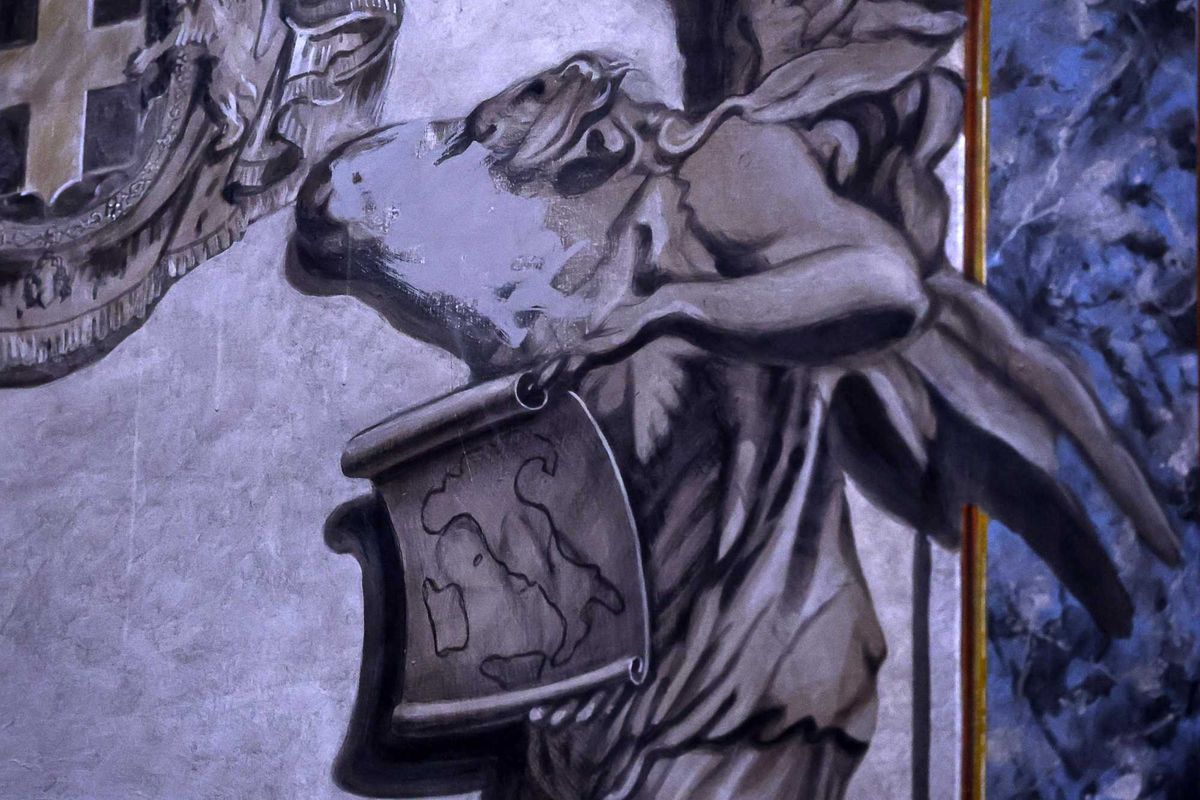Dovranno essere installati su tutti gli edifici pubblici e sulle nuove case. Obiettivo: consumi giù del 16% entro il 2030. Al bando le caldaie a gas, incertezza sui finanziamenti. Imballaggi: la filiera italiana torna in pericolo.
La Commissione Ue ha chiuso il cerchio dei lavori con il Parlamento e il Consiglio. In ballo il futuro delle nostre abitazioni, degli edifici pubblici e di tutti gli immobili non residenziali. Ieri è stato infatti raggiunto un accordo sulla direttiva per le case green. L’ultima versione del testo, abbandonata la filosofia degli obiettivi legati alle classi energetiche minime degli edifici, punta su un percorso di riduzione del consumo medio di energia da parte degli edifici residenziali dei singoli Paesi membri. Il percorso parte nel 2020 e arriva al 2050, quando l’obiettivo è azzerare le emissioni. Saranno le singole nazioni a dover stabilire come raggiungere gli obiettivi stabiliti dalla direttiva, secondo un percorso che diventa più flessibile rispetto alle prime proposte del Parlamento.
Flessibilità non significa, però, passi indietro rispetto alla transizione green tanto bramata dai socialisti europei. Significa che bisognerà da un lato farsi furbi per sfruttare i margini ed evitare che milioni di cittadini vengano penalizzati direttamente o indirettamente per via dei numerosi obblighi sugli edifici pubblici e su quelli commerciali. Dall’altro che se non si vuole arrivare al 2030 e al 2040 con dei macigni green insostenibili, dovremo lanciare nuove tecnologie. Ad esempio per tutto ciò che riguarda i sistemi di riscaldamento degli immobili. Nel complesso, anche se il testo viene definito un compromesso porta con sé grosse novità. La prima riguarda la prestazione energetica del complesso immobiliare di singole regioni o nazioni. Gli Stati dovranno garantire che a partire dal 2020 l’energia primaria media dell’intero parco edilizio residenziale diminuisca. Almeno del 16% entro il 2030 (il Consiglio voleva il 10%, la Commissione il 20% e il Parlamento il 28%). Almeno il 20-22% entro il 2035. Sono esclusi dagli obblighi edifici ufficialmente protetti o altri edifici storici, dove la ristrutturazione non è tecnicamente o economicamente fattibile. Salve le proprietà delle forze armate e le chiese. Ed esenzioni pure per le seconde case. Certo, sarà da comprendere come verranno gestiti tali criteri nel perimetro dei condomini dove insistono sia prime che seconde case.
La seconda novità riguarda i pannelli solari. Tra il 2026 e il 2030 dovranno dotarsi obbligatoriamente di energia rinnovabile tutti gli immobili pubblici e non residenziali. Seguendo uno schema progressivo in base alle superfici. Dopo il 2030 tutte le case costruite ex novo, incluse quelle dei privati, non potranno non avere pannelli solari. Una botta incredibile al sistema tradizionale e pure al paesaggio. Immaginate grandi città come le nostre trasformate in imponenti impianti solari. Nel frattempo c’è pure da mettere in cantiere la sostituzione delle caldaie a gas con le nuove pompe di calore. Qui l’obiettivo è stato spostato dal 2035 al 2040. Inoltre va segnalato che la Commissione è stata incaricata di pubblicare una guida sulla «nozione di caldaie a combustibile fossile per chiarire che è l’input di combustibile fossile che conta e non la tecnologia». Tradotto. Nel frattempo si potranno implementare tecnologie meno costose rispetto a quelle attuali. Una magra consolazione che viene meno se si passa ad analizzare gli aspetti finanziari di tutto questa enorme macchina chiamata transizione.
Ieri, il trilogo è intervenuto pure sul tema mutui. Specificare che il portafoglio di prestiti per incoraggiare le ristrutturazione degli edifici dovrà essere adottato dalle banche su base volontaria, è stato uno degli elementi che ha permesso di chiudere la trattativa. La non obbligarietà si trasformerà però in un aumento dei costi. Ovviamente il pacchetto di ristrutturazioni e l’aggiornamento rispetto alle nuove normative creerà un doppio standard. E quindi due distinti mercati. Serie A e serie B. Chi starà nella categoria più bassa vedrà svalutarsi il proprio immobile. È nell’ordine delle cose. L’abbiamo scritto numerose volte, ma anche oggi vale la pena ripeterlo. Tant’è che il settore dei fondi immobiliari è pronto a grandi investimenti, non appena il mercato prezzerà - come si dice in gergo tecnico l’adeguamento dei prezzi alle nuove situazioni regolatorie - i valori minimi. I piccoli proprietari non ne trarranno certo beneficio. A questo punto non resta che attendere le direttive future, compresa quella sul certificato energetico europeo. L’intesa dovrà essere confermata dagli ambasciatori degli Stati (Coreper) e dalla commissione Ambiente (Envi). Ci saranno sorprese. Probabilmente sì, ma non sostanziali. La strada è tracciata e non ne sentivamo certo l’esigenza. Anche perché le insidie del modello legislativo europeo sono sempre dietro l’angolo. Vale per tutti i dossier. Mercoledì sera il Consiglio, guidato dalla presidenza spagnola, ha tirato al nostro Paese una sonora sberla. Da quanto risulta alla Verità, i socialisti di Pedro Sanchez hanno chiuso un accordo con Berlino con l’obiettivo di rimettere in discussione la direttiva sugli imballaggi. Il risultato si è palesato alla riunione del Coreper. Madrid ha presentato un testo che cancella metà dei miglioramenti elaborati per le norme sul packaging. Di fatto viene smontato l’esenzione sulle bioplastiche e rivista la definizione di riciclo. Per essere considerato su larga scala, dovrà produrre una quantità annua di materiale riciclato a livello Ue pari o superiore al 30% per il legno e 55% per tutti gli altri materiali. Anche questo è un passo indietro rispetto al testo del Parlamento che salvava nazioni leader del riciclo come l’Italia. Spagna e Germania così facendo hanno azzerato sei mesi di lavori, nei quali l’industria italiana si era messa al riparo dalle follie green. Tutelando tecnologia e occupazione. L’Europa, nei suoi equilibri dentro il trilogo, prevede che singoli Stati possano accordarsi e pugnalarne altri. Un meccanismo che andrebbe rivisto. Nel frattempo, politica e imprese devono rimboccarsi le maniche e rispondere con forza a Madrid e Berlino.