
- Si abbassa ancora l'età del primo contatto con le sostanze. Hashish, marijuana, cocaina acquistate con la paghetta. I centri di recupero: il fenomeno ci sta sfuggendo di mano.
- Il neurochirurgo Giulio Maira: «Gli stupefacenti provocano danni permanenti al cervello, i ragazzi cercano lo sballo subito. La scuola ha abbassato la guardia. Avevo chiesto alla Azzolina di dedicarvi 2 ore all'anno: nessuna risposta».
Giovani, giovanissimi. A volte, ancora dei bambini. Per la Generazione Z, quella cresciuta a pane e digitale, il primo contatto con la droga può arrivare molto presto, già negli anni di passaggio tra le scuole elementari e le medie. Hashish e marijuana, prima di tutto. Poi droghe sintetiche. Sempre più spesso, la cocaina, accessibile ormai a prezzi irrisori. Per acquistare le dosi, bastano i soldi della paghetta: il mercato della droga ha cambiato fisionomia, i più piccoli devono essere fidelizzati sin da subito. «C'è una stretta correlazione tra la quantità di denaro che i ragazzi hanno a disposizione e la propensione a commettere comportamenti disfunzionali», spiega Franco Taverna, segretario generale della fondazione Exodus, che da anni indaga sugli stili di vita dei ragazzi, insieme con agli operatori della comunità Casa del giovane di Pavia. «Spesso si può arrivare anche a più di 50 euro a settimana.
I genitori, incapaci di instaurare relazioni serene, hanno una propensione ad accontentare i propri figli a tutti i costi». Tra i ragazzi che settimanalmente spendono per comportamenti disfunzionali, il campione più significativo si lascia attrarre dall'alcol. Poi cannabis, cocaina e sostanze sintetiche. Per finire con l'eroina.
«Siamo di fronte a un fenomeno che ci sta sfuggendo di mano», racconta un operatore di una casa di recupero per tossicodipendenti in Lombardia. L'età media dei ragazzi che si avvicinano alle sostanze stupefacenti si è abbassato di colpo. Per capirlo, è sufficiente considerare quello che nelle strutture chiamano «tasso finestra», cioè il tempo che passa prima di compiere il salto dalle droghe leggere a quelle pesanti.
«Venti anni fa, i tempi erano dilatati: prima di approdare alle sostanze che ti rendono fortemente dipendente, come la cocaina o l'eroina, passavano 3 anni. Oggi, il salto avviene in 3 mesi». A raccontarlo è Simone Feder, che coordina l'Area giovani e dipendenze della comunità Casa del giovane di Pavia e da anni lavora per ricomporre le storie dei ragazzi che entrano nella struttura. «C'è un disagio nei giovani da interpretare. Vediamo genitori che non riescono a gestire i propri ragazzi. Quando arrivano alla cura, li abbiamo già persi. Dobbiamo intervenire prima».
Il termometro del disagio si misura in base alla presenza dei minori nelle strutture di recupero. A Pavia, le richieste di ingresso sono ormai quotidiane, i posti attivi sono interamente occupati. «Alla Casa del giovane non abbiamo mai avuto così tanti minori polidipendenti, nemmeno negli anni Ottanta, il periodo della devastazione dovuta all'eroina». Arrivano a 16 anni, quando ormai hanno già sperimentato sostanze diverse e la dipendenza va avanti da tempo. Ci sono ragazzi che entrano nel tunnel della droga ad appena 10 anni, come quelli che hanno deciso di raccontarsi in queste pagine e per i quali sono stati scelti nomi di fantasia per tutelarne l'identità.
«Quando vivi in una famiglia che sdogana la pippata di cocaina, cresci in un contesto adolescenziale in cui puoi permetterti di tutto», spiega ancora Feder. Uno degli ultimi colloqui è ancora lì, fisso nella sua mente: «Ricordo questo ragazzo portato dal papà. Era coartato, non parlava. Quando abbiamo iniziato il colloquio, ho capito il motivo per cui aveva imboccato la strada sbagliata: il padre faceva un uso quotidiano di cocaina, per il diciottesimo compleanno del figlio ha avuto il coraggio di regalargli 5 grammi di hashish».
A chiedere aiuto, oggi, non sono solo le famiglie disagiate. «Il fenomeno è ormai trasversale, non si tratta più dei soli emarginati», spiega alla Verità Veronica Giannone (Forza Italia), segretario della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza. Nelle strutture finiscono tanti ragazzi della classe medio-alta: figli di medici, avvocati, professionisti. I ragazzi sono spesso lasciati da soli nel percorso di crescita, come conferma Enrico Coppola, presidente dell'Associazione genitori antidroga. «Quando sei nella classe dirigente, la testa è fissa alla carriera. Dalla sera alla mattina, puoi perdere tutto. I beni materiali prendono il sopravvento: l'unica preoccupazione è non far mancare nulla ai figli, gli aspetti personali passano in secondo piano. Così i genitori smarriscono il ruolo educativo: fanno gli amici e non sono più in grado di prendere una decisione, quando serve. I ragazzi di oggi non sono responsabilizzati». Di fronte ai problemi, la famiglia viene messa da parte: secondo una rilevazione dell'indagine Selfie, condotta da Exodus e Casa del giovane di Pavia, in caso di difficoltà gli interlocutori privilegiati diventano gli amici.
A loro, si rivolgerebbe più dell'80% degli studenti intervistati nelle scuole superiori. Tra le figure adulte con cui i ragazzi sarebbero disposti a confidarsi, al primo posto c'è lo psicologo. Solo dopo, i genitori. I professori sono gli ultimi a cui esprimere un disagio. «C'è un gap di comunicazione tra gli studenti e il mondo degli adulti», spiega ancora Franco Taverna di Exodus. «A volte, genitori e insegnanti non conoscono neanche i social che i ragazzi usano». Di fronte alla sensazione di vuoto, ci si rifugia altrove.
«Piuttosto che esteriorizzare un bisogno, si preferisce staccare la spina, racconta Simone Feder. «Così si arriva alla droga». La paura, tra gli operatori delle diverse strutture per l'accoglienza dei ragazzi è che nei prossimi mesi l'ondata di disagio possa crescere, alimentata della pandemia. La chiusura delle scuole, la preclusione dello sport, la rarefazione degli incontri potrebbero essere terreno fertile per la rabbia e l'ostilità che molti adolescenti hanno maturato negli ultimi anni. «È stato tolto loro un pezzo di vita fondamentale per completare il percorso di formazione», raccontano. L'immagine che usano è emblematica: «Ci troveremo di fronte a uno tsunami di disagio sempre più marcato, che faremo fatica a contenere perché in Italia non ci sono abbastanza strutture, né un sufficiente numero di operatori».
«Questa epidemia non si sconfigge con la legalizzazione della cannabis»
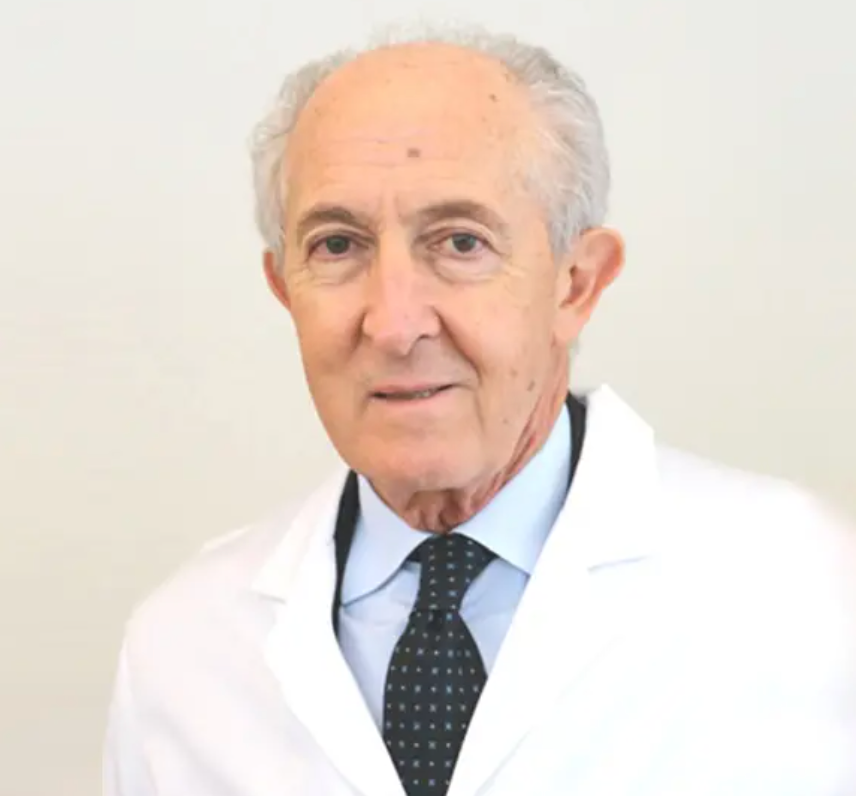
Giulio Maira (www.humanitas.it)
«La normalizzazione dei comportamenti sbagliati ci ha reso ciechi di fronte ai rischi che i ragazzi stanno correndo. La droga è diventata parte della nostra società, non ci stupisce quasi più la sua diffusione. La scuola non ne parla, i genitori neanche. Senza i corretti insegnamenti, lasciamo che i giovani saltino nel vuoto a occhi chiusi, abbindolati da chi promette paradisi artificiali che non esistono». Il professor Giulio Maira conosce bene gli effetti degli stupefacenti sul cervello dei ragazzi, specie sui più piccoli. Neurochirurgo dell'istituto Humanitas di Milano, presiede la fondazione Atena onlus, che si occupa anche di promuovere campagne informative tra i ragazzi.
L'età media di chi assume per la prima volta alcol e droghe si sta sensibilmente abbassando. Sul piano neurologico, che cosa rischiano i ragazzi?
«Sostanze come la cannabis determinano disturbi di tipo cognitivo, con ricadute sulla memoria e l'attenzione. Ciò comporta inevitabili ripercussioni sul ciclo scolastico e sulle attività quotidiane. Queste sostanze sono pericolose a lungo andare, perché provocano modificazioni che si ripercuotono sul funzionamento del cervello. A volte, però, basta anche una sola assunzione a generare danni permanenti: alcune droghe sintetiche o la cocaina possono provocare aumenti di pressione gravissimi, che potrebbero sfociare in emorragie cerebrali».
Nelle strutture che curano la tossicodipendenza, si verifica un fenomeno nuovo: l'arrivo di soggetti polidipendenti: a 16 anni hanno già sperimentato hashish, droghe sintetiche, spesso cocaina. Come si spiega?
«Il mix di droghe è sempre più diffuso, i ragazzi ne assumono diversi tipi tutti insieme per raggiungere lo sballo in un tempo ridotto. Si arriva a fare uso di droghe anche senza conoscerne la composizione».
Per quale motivo si va oltre?
«Nella ricerca del divertimento, questi ragazzi sono prepotentemente condizionati dalla cultura dello sballo: non ci si diverte senza sballarsi. Dobbiamo cercare di far capire loro che lo sballo è un surrogato del divertimento».
I ragazzi hanno perso del tutto la coscienza del pericolo?
«Per loro natura, gli adolescenti cercano la trasgressione. Usciti dall'età dell'infanzia, non hanno ancora sviluppato un sufficiente grado di razionalità. Ci vogliono le relazioni, le esperienze, i maestri. I ragazzi stanno perdendo tutto questo».
Quanto ha inciso lo sdoganamento culturale degli ultimi anni?
«Ci si è talmente abituati alla droga che si è smesso di considerarla un problema. Ci sono casi di criminalità in cui l'assunzione di stupefacenti viene inquadrata come una questione collaterale. Nessuno pensa, invece, che potrebbe essere la causa principale. E poi, si pensa davvero di indebolire i trafficanti di droga legalizzando la cannabis?».
Perché non ci crede?
«La legalizzazione della cannabis riguarderebbe solamente i ragazzi più grandi, ma noi dobbiamo intervenire sui bambini di 10 anni, prima che possano entrare in contatto con i trafficanti. Stiamo combattendo una epidemia culturale, che non si cura con gli antivirali. Serve conoscenza e attenzione».
Il punto di partenza è la scuola. Sono sufficientemente pronti gli istituti italiani?
«Per quello che ho potuto vedere andando nelle scuole a incontrare i ragazzi, assolutamente no. I presidi non hanno materiale didattico, l'attenzione che le scuole avevano verso l'universo della droga si è sensibilmente ridotta. Manca una solida organizzazione. Avevamo chiesto al ministro Lucia Azzolina di dedicare almeno due ore all'anno al tema e di inserirlo nelle discussioni d'esame».
Qual è stata la risposta?
«Nessuna. Per questo, vorrei rilanciare la proposta anche al nuovo ministro, Patrizio Bianchi. Questa è la generazione alla quale affideremo il nostro futuro: se non la proteggiamo, non potremo lamentarci quando i professionisti di domani non saranno all'altezza delle sfide che si troveranno ad affrontare».
Quanto pesa la chiusura delle scuole in questi mesi di pandemia?
«Il lockdown ha privato i ragazzi della figura del maestro, proprio quando ne hanno più bisogno. La didattica a distanza è una iattura, inibisce qualsiasi forma di contatto con gli insegnanti, che hanno il compito di educare gli studenti ai pericoli presenti nella vita di tutti i giorni: dalle droghe al Web».
Alle difficoltà della scuola, si aggiungono le mancanze delle famiglie. Perché non c'è un sufficiente grado di comunicazione con i ragazzi?
«Le famiglie sono molto superficiali, basta vedere come affrontano l'esposizione dei figli ai social network. Ai bambini viene dato un tablet perché si divertano, perché stiano tranquilli. Non vengono presi in considerazione i rischi».
Avviene altrettanto con le droghe?
«Le famiglie hanno abbassato la guardia, altrimenti non si spiegherebbe l'ingresso dei ragazzi nelle comunità sin da adolescenti. I genitori vogliono essere amici dei loro figli. Non si può essere amici di un bambino giovanissimo, che ha tutt'altre esperienze e che non riesce ancora a capire. Un genitore è prima di tutto un educatore».
I ragazzi stanno crescendo senza desiderio? Tutte le richieste vengono immediatamente appagate e soddisfatte: si può spiegare anche così la scelta di rifugiarsi nelle droghe, per cercare qualcosa di più forte?
«Educare non significa soddisfare i piaceri della vita quotidiana. Significa insegnare l'attenzione alle regole, il rigore. Talvolta, ciò può causare anche un dispiacere».






