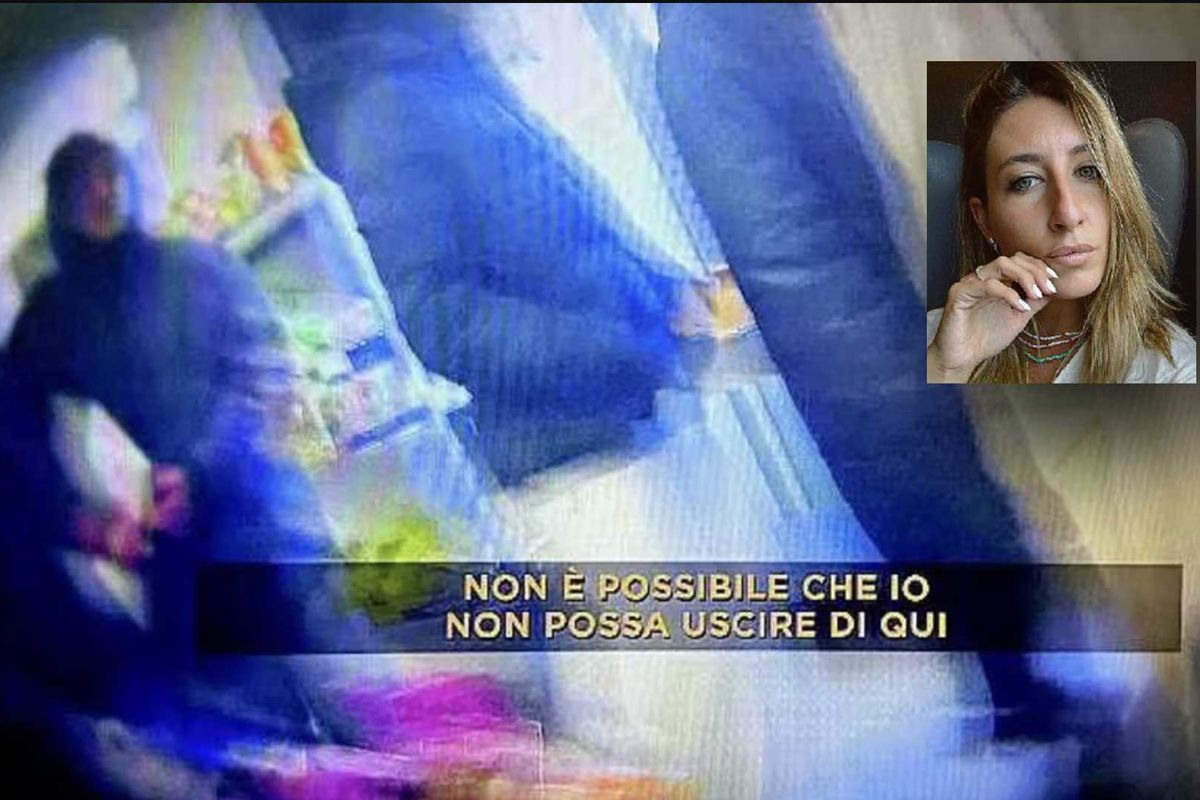2021-04-19
Tesoretto dimenticato. Tolto ai delinquenti ma sempre in mano loro
Hotel Paradiso (Architetti Pistoia)
A 25 anni dalla legge che restituisce alla collettività le ricchezze sottratte ai racket, 20.000 immobili su 37.000 restano sospesi. Preda di incuria e vandali o perfino rimasti in possesso degli illegittimi proprietari. Dopo la mafia, va sconfitta anche la burocrazia.L'ex toga antimafia Gian Carlo Caselli: «Per far funzionare la norma del '96 serve semplificare e investire, ma manca la volontà politica. Le aziende confiscate potrebbero essere motore di sviluppo. Invece ci si arrende al loro fallimento».Lo speciale contiene due articoli.Una guerra a metà, impantanata tra la mancanza dei fondi e la scarsa volontà politica. La lotta dello Stato alla criminalità organizzata si ferma ancora alla sua prima fase, quella repressiva, con i sequestri e le confische dei patrimoni accumulati dai clan. Il secondo momento, quello della restituzione dei beni alla collettività, continua a zoppicare tra le lungaggini burocratiche. L'analisi dell'attività svolta dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati (Anbsc) parla chiaro. Secondo il dossier FattiPerbene, elaborato da Libera a 25 anni dalla legge che prevede il riutilizzo sociale dei beni confiscati, 5 immobili su 10 restano ancora da destinare; le aziende confiscate e destinate sono state quasi tutte liquidate.Su 37.300 immobili sottratti definitivamente ai clan, 17.316 sono tornati alla collettività. Gli altri (19.984) restano ancora in pancia all'Agenzia. Di quelli destinati, «circa la metà attende ancora una effettiva rifunzionalizzazione», si legge nell'ultima relazione disponibile redatta dall'Agenzia. «Fin qui la legge ha prodotto importanti esperienze, ma ci sono ancora troppe criticità nei processi amministrativi, risolvibili solo se questo tema diventa una priorità nell'agenda politica», spiega alla Verità Gianpiero Cioffredi, presidente dell'Osservatorio per la legalità e la sicurezza della Regione Lazio. «Per troppo tempo, l'agenzia è stata una sorta di scatola vuota, con pochi fondi e risorse. Di fatto, avevano le mani legate». La concentrazione territoriale dei beni finisce per complicare anche il processo di gestione in mano agli enti: «Ci sono Comuni che si trovano a gestire un numero spropositato di immobili, e sono costretti a farlo con risorse che non hanno», continua Cioffredi. «Basterebbe investire nella ristrutturazione dei beni confiscati una parte del Fondo unico giustizia, nel quale convergono tutti i soldi sequestrati con le operazioni antimafia. Sono anni che le amministrazioni e le associazioni chiedono un sostegno maggiore da quel fondo». I ritardi nella gestione del patrimonio ne hanno spesso causato la perdita di valore: ci sono palazzi, alberghi negozi abbandonati da anni, saccheggiati e spogliati di ogni cosa. Come raccontato in queste pagine, a volte sono le stesse organizzazioni a vandalizzare le strutture, approfittando dei tempi lunghi che separano il sequestro dalla confisca definitiva. In altre occasioni, addirittura, capita che la confisca non sia sufficiente: le famiglie dei clan continuano a utilizzare appartamenti, ville e terreni come se nulla fosse. Nella relazione della commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e della corruzione in Sicilia, per esempio, è spuntato fuori il paradosso di Gravina di Catania, dove le abitazioni confiscate in via definitiva nel 2018 alla famiglia Zuccaro «hanno continuato ad essere impunemente e tranquillamente occupate dai vecchi proprietari».Si tratta delle case del boss Maurizio Zuccaro, clan Ercolano-Santapaola, messe a bando dall'Agenzia per i beni confiscati: villa con piscina e una serie di appartamenti in cui hanno abitato i figli, la madre e altri familiari. Tutte tranquillamente abitate, come rivelato dall'amministratore giudiziario contattato dall'associazione interessata a rilevare i beni: «Voi dovete sapere», ha spiegato ai membri dell'organizzazione I Siciliani giovani, «che se volete andare a fare il sopralluogo, dobbiamo andare a farlo con i carabinieri perché l'immobile è occupato». E ancora, in una seconda telefonata riportata nei verbali della commissione d'inchiesta regionale: «Fermiamo tutto perché noi non possiamo permetterci di effettuare un sopralluogo prima dell'avvenuto sgombero dei locali». Meglio è riuscita a fare la funzionaria dell'Agenzia per i beni confiscati, che, di fronte all'occupazione, ha dato una risposta senza appello: «L'amministratore giudiziario avrebbe dovuto dissuadere dall'effettuare il sopralluogo. L'associazione avrebbe potuto tranquillamente scegliere altri beni da avere affidati visto che c'erano quei problemi».<div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem1" data-id="1" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/tesoretto-dimenticato-tolto-ai-delinquenti-ma-sempre-in-mano-loro-2652624759.html?rebelltitem=1#rebelltitem1" data-basename="lo-stato-ci-mette-faccia-e-risorse-non-puo-permettersi-certe-figure" data-post-id="2652624759" data-published-at="1618771126" data-use-pagination="False"> «Lo Stato ci mette faccia e risorse. Non può permettersi certe figure» Dottor Gian Carlo Caselli, il processo per la valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata è ancora in ritardo. Lei che conosce la mafia e che, da magistrato, ha speso tanti anni per combatterla, a cosa attribuisce queste incertezze? «Manca la volontà politica per far funzionare adeguatamente la legge del 1996 sul riutilizzo dei beni e delle imprese confiscati, sia a livello nazionale che nei singoli territori. Troppo spesso, prevalgono logiche burocratiche». Eppure si tratta di uno strumento di valore per portare a compimento la lotta ai clan. «Molto apprezzato anche all'estero, aggiungerei. Ha avuto una infinità di applicazioni estremamente positive, tanto che i mafiosi hanno fatto di tutto per ostacolarne l'applicazione. Un buon funzionamento del sistema dimostra che le mafie possono essere battute non solo con le “manette", ma anche colpendole in ciò che sta loro maggiormente a cuore: il denaro». L'Agenzia nazionale per l'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati dispone di una sufficiente capacità manageriale per gestire un numero enorme di immobili e aziende sottratti alle mafie? «Tenuto conto della scarsità di uomini e risorse disponibili, l'Agenzia sta facendo bene. Certamente la gestione di immobili e imprese, dal momento del sequestro a quello della destinazione, richiede competenze specialistiche». Il ritardo nella destinazione dei beni indebolisce il lavoro della magistratura e delle forze dell'ordine? «Per sequestrare e confiscare occorrono indagini complesse e tre lunghi gradi di giudizio. Oltre ai costi e al tempo, lo Stato ci mette “la faccia". Se poi i beni si coprono di ragnatele o muffa, restando abbandonati e inutilizzati, lo Stato ci fa una magra figura». Ciò incide sulla fiducia dei cittadini nelle istituzioni? «In maniera negativa, purtroppo. Il consenso verso l'azione dello Stato diminuisce e può lasciare spazio all'indifferenza ostile. Non possiamo permetterci il lusso che qualcuno, a fronte di queste disfunzioni, possa bestemmiare dicendo che “la mafia dà lavoro" o che “andava meglio prima"». In che modo si potrebbero velocizzare le procedure? «Le prassi amministrative di trasmissione delle notizie da parte degli uffici giudiziari, di destinazione e di assegnazione vanno semplificate in alcuni punti e accompagnate da tempi certi e più brevi. Per ottenere tutto ciò, occorrono investimenti in risorse materiali e umane». In una lettera indirizzata al premier Mario Draghi, lei scrive: «Molti Comuni non intendono farsi carico di un immobile confiscato per via della loro indifferenza verso il significato dell'antimafia». A chi si riferisce? «A tutti quei Comuni che si dichiarano non interessati a prendere in carico un immobile appartenuto a un mafioso per trasformarlo in qualcosa di utile sul territorio, nonostante l'oggettivo vantaggio economico dell'operazione; oppure, alle amministrazioni che, dopo essersi dichiarate interessate, tentennano o “ci ripensano". A volte manca la “metabolizzazione" dei valori dell'antimafia». L'altro asset fondamentale dell'Agenzia nazionale sono i beni aziendali. Come si legge nell'ultima relazione disponibile, «il percorso di rigenerazione per una percentuale altissima di aziende è del tutto impercorribile». Siamo di fronte a un vicolo cieco? «È lo stesso direttore dell'Agenzia, Bruno Corda, a segnalare il “grosso problema" delle imprese confiscate “senza futuro", cioè “destinate quasi sempre al fallimento". Abituate a lavorare sul mercato nero, quando si confrontano con il mercato reale, “soccombono". Un disastro per la credibilità dello Stato, da scongiurare rendendo le imprese confiscate i motori di un nuovo sviluppo nella legalità». Come? «Il codice antimafia stabilisce che, fin dal momento del sequestro, l'amministratore nominato dal giudice, anche d'intesa con l'Agenzia, debba delineare la prospettiva di impiego o riutilizzo di quanto sequestrato. Nei casi di imprese prive di prospettive, si potrebbe pensare a una rapida liquidazione. Quando ha voluto, lo Stato ha invece sostenuto con lungimiranza l'imprenditoria giovanile e ha potuto misurare i risultati dei suoi interventi. Se un'impresa già in mano a un clan passa a una cooperativa di giovani che riescono a farla funzionare, vi è sviluppo nella legalità. Con conseguenti ricadute positive sul territorio, che ci guadagna nella qualità e nella quantità dei servizi».
Un frame del video dell'aggressione a Costanza Tosi (nel riquadro) nella macelleria islamica di Roubaix
Scontri fra pro-Pal e Polizia a Torino. Nel riquadro, Walter Mazzetti (Ansa)
Mohamed Shahin (Ansa). Nel riquadro, il vescovo di Pinerolo Derio Olivero (Imagoeconomica)