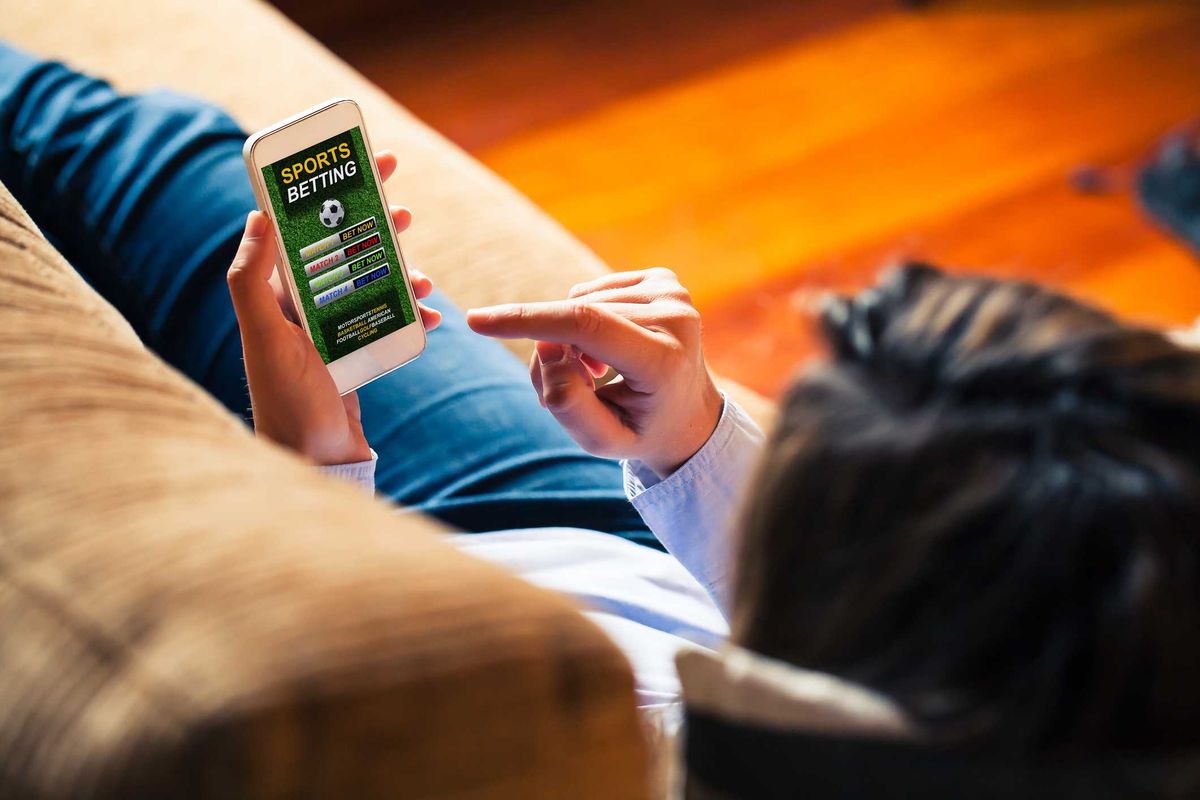2024-12-15
Basilicata, 16 dicembre 1857: il terremoto visto dalla letteratura e dalla scienza
True
Le rovine di Montemurro dopo il terremoto del 16 dicembre 1857
Charles Dickens raccolse la testimonianza di un volontario inglese che aiutò la popolazione della Val d'Agri, regalando uno spaccato crudo della società al tramonto dell'era borbonica. L'evento fu studiato dalla nascente sismologia e fissato per sempre dai pionieri della fotografia.Charles Dickens volle raccontare ai lettori degli effetti di un terremoto accaduto l’anno precedente in una terra lontana tra i tanti articoli del periodico Household Words da lui edito, nell’edizione datata 19 dicembre 1858. Il grande romanziere riportava l’esperienza diretta a lui raccontata dal signor Major, un imprenditore della seta con uno stabilimento a Portici che si era recato nei luoghi della tragedia, rimanendovi per quasi tre mesi spinto da puro spirito di beneficenza. Il reportage regalò ai lettori non solo la descrizione degli effetti della calamità ma anche uno spaccato sociale del popolo e della reazione delle istituzioni del morente regno borbonico. Assicurato ad una scorta di gendarmi concessa dal ministro dell’Interno Lodovico Bianchini, Major arrivò in terra campana il 30 gennaio 1858. La terra aveva tremato la notte del 16 dicembre precedente, con epicentro nella zona di Montemurro in provincia di Potenza. Dopo appena sei settimane, il benefattore inglese si avventurava con la sua scorta verso le zone più colpite dell’entroterra al confine tra Campania e Lucania da Salerno verso Auletta e Polla, su strade sempre meno agevoli che diventavano poi mulattiere e sentieri sconnessi spesso coperti dalla neve in direzione della Val d’Agri, dove il sisma aveva generato la massima distruzione e la cancellazione di interi paesi. Qui Major notò subito gli effetti devastanti, oltre che del terremoto, della condizione economica e sociale della popolazione lucana. Il governo di Napoli era intervenuto blandamente negli aiuti, e le baracche in legno erano andate quasi tutte ai funzionari o alla chiesa. Così come una parte del denaro donato dai benefattori britannici, che rimase nelle tasche della gerarchia ecclesiastica campana. Major ne fu profondamente colpito e, tra le tende che il gentleman descrisse come stracci simili più ad ombrelli che a rifugi provvisori, ebbe tempo di scrivere al vescovo sollecitandolo a versare tutto il dovuto. Ma l’arretratezza e la radicata e diffusa superstizione di quelle genti misere si rivelò un ostacolo pressoché insormontabile, tanto che Major si vide negata la proposta di finanziare baracche in legno all’interno di un monastero il cui chiostro si era parzialmente salvato dal crollo perché sarebbe stato «grave peccato» ospitare famiglie, in quanto la coabitazione di donne e uomini in un luogo sacro non era ammissibile. Fu così che il benefattore, sotto la protezione dei gendarmi borbonici, si mise a distribuire cibo pagandolo di tasca propria non senza rischi, tanto che in un’occasione si trovò senza scorta alla mercé della folla affamata e di un prete che aveva intenzione di derubarlo. La disperazione causata dal sisma del dicembre 1857 non risparmiò neppure le famiglie nobili, come raccontò lo stesso Major incontrando due nobildonne a Sarconi che non esitarono a spogliarsi della propria dignità di lignaggio per accettare gli aiuti in denaro dell’inglese. Le trovò seminude e atterrite, dopo che il sisma aveva portato via tutti i loro averi e immobili. A Saponara vide il salvataggio del giudice locale, rimasto sotto le macerie corpo a corpo con la moglie ed un figlio, entrambi deceduti nel crollo della loro abitazione. A Montemurro, epicentro del terremoto, Major descriveva così la distruzione totale: «Non rimaneva più niente. L’odore pungente dei corpi era insopportabile, perché erano stati interrati sommariamente e i maiali riuscivano a disseppellirli per cibarsene». I gendarmi inviati dal Governo borbonico, invece di aiutare la popolazione, saccheggiavano le cantine locali per ubriacarsi. Il caos aveva preso il sopravvento insieme alla morte del 90% degli abitanti. Nei mesi trascorsi ad aiutare in modo febbrile la popolazione terremotata, Major colse appieno il malcontento diffuso che accompagnò gli ultimi anni del regno borbonico. A Charles Dickens l’imprenditore raccontò che «Da nessuna parte (nei luoghi colpiti ndr.) la popolazione era soddisfatta del governo. Anzi, quasi ovunque la gente era fortemente avversa. Se dovessi descrivere le condizioni del popolo direi che si trova in uno stato semi barbarico, simile forse a quello dell’Inghilterra di secoli fa. E neppure ho potuto rilevare qualcosa, nell’amministrazione civile e negli organi ecclesiastici, che avesse potuto in qualche modo elevarne le condizioni. E in quanto alla religione, è più una forma di paganesimo (…) I preti, non ho remore a dirlo, sono debosciati e ignoranti. I cognomi Projetti e Muli sono diffusi, perché si tratta di figli illegittimi degli ecclesiastici che vengono accuditi dalla comunità fino ai dodici anni. In seguito, se non adottati o soppressi dopo aver ricevuto il battesimo, diventano vagabondi di strada (…)»Major, dopo aver prestato la sua opera caritatevole tra quelle genti derelitte, lasciò i luoghi del sisma nella primavera del 1858. Appena tre anni più tardi crollava il regno dei Borboni, così come erano crollate le fragili dimore degli abitanti della Val d’Agri.Ancora l’Inghilterra, dopo la testimonianza del benefattore Major raccolta da Dickens, fu protagonista nella storia del sisma del 16 dicembre 1857. Ad occuparsi del terremoto fu nientemeno che la prestigiosa Royal Society di Londra, nella persona dell’ingegnere civile Robert Mallet. Tra i padri della sismologia moderna, Mallet all’epoca della catastrofe si stava occupando dello studio della propagazione delle onde sismiche. La catastrofe della Basilicata era un’occasione per poter testare sul campo le teorie che lo scienziato aveva formulato a Londra. Le caratteristiche del terremoto, particolarmente violento e considerato allora il più forte degli ultimi secoli in Italia. Per rendere l’idea della violenza delle scosse, il terremoto della Basilicata ebbe le seguenti caratteristiche. La terra tremò per la prima volta alle 22:15 del 16 dicembre 1857. Alla prima scossa, durata circa 30 secondi, ne seguì una seconda molto più intensa che raggiunse la magnitudo 7.1 della scala Richter. Il sisma, con epicentro nella zona di Montemurro a 15 km nel sottosuolo, spazzò via interi paesi. I morti stimati furono oltre 11mila.Robert Mallet sbarcò a Napoli giunto via Marsiglia il 5 febbraio 1858. Per raggiungere i luoghi del sisma, fu costretto ad una cavalcata durata lunghe ore sotto le intemperie.Durante la sua missione nelle aree colpite dal terremoto del 16 dicembre 1857, Robert Mallet fece diverse osservazioni significative. Mallet osservò e documentò i danni agli edifici, notando come le strutture fossero state colpite e distrutte, analizzò le direzioni delle crepe e delle dislocazioni per determinare la direzione delle onde sismiche. Per quanto riguardava gli effetti sul terreno rilevò frane, smottamenti e spaccature nel terreno, studiando come il terremoto avesse alterato la geologia locale. Mallet misurò inoltre la velocità di propagazione delle onde sismiche nel terreno, utilizzando le sue osservazioni per calcolare la profondità dell'ipocentro del terremoto, poi stimato nel suo rapporto presentato alla Royal Society nel 1860 in una distanza variabile tra i 12 e i 15 Km.Raccolse infine numerose testimonianze orali dagli abitanti delle zone colpite per comprendere meglio l'intensità e la durata delle scosse. Lo studio di Mallet si avvalse per la prima volta nella storia degli studi sismici della fotografia, grazie all’opera di due rinomati fotografi francesi di stanza a Napoli. Claude Grillet e il collega Alphonse Bernoud (fotografo ufficiale dei Borbone e in seguito dei Savoia) realizzarono una serie di scatti stereoscopici che rappresentano la prima testimonianza per immagini di un sisma, riuscendo a fissare per sempre la realtà di quella gravissima catastrofe che colpì la Lucania alla vigilia della nascita dello Stato unitario.