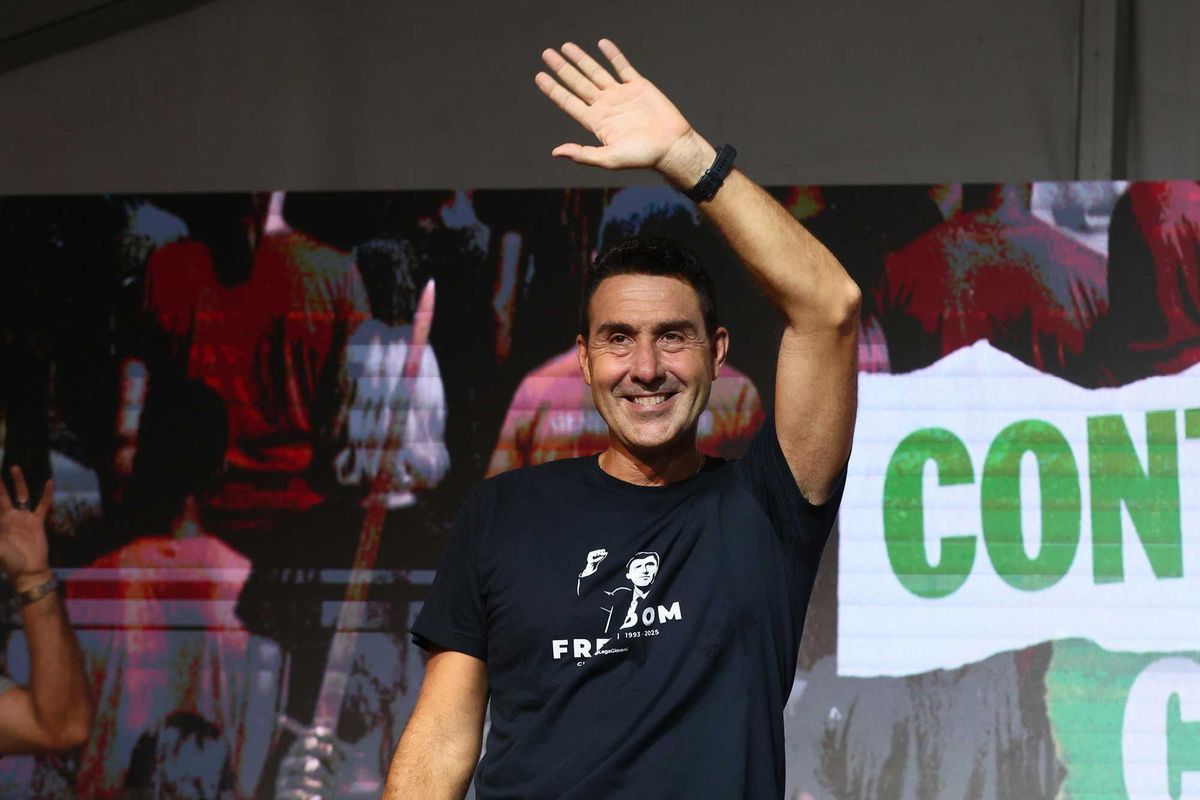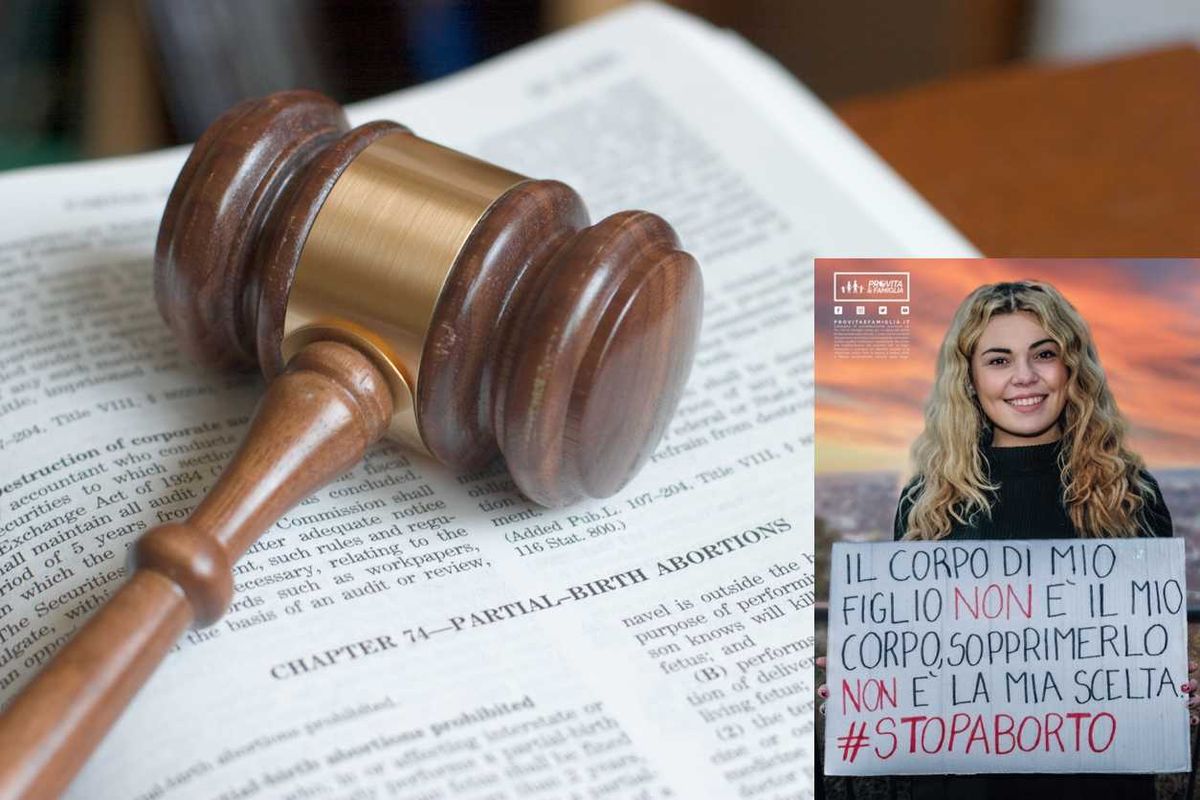Focesi, chi erano costoro? La Treccani dice che erano una popolazione di origine greca stanziata nell’Asia Minore, una stirpe di ulissidi, di argonauti, commercianti, colonizzatori. Sempre pronti, pur di trafficare, a salpare per l’ignoto con lo stesso entusiasmo con cui noi partiamo per un pic-nic. Una rotta tirrenica li portò all’Elba dove fondarono una colonia attiva nei commerci e nell’agricoltura oltre due millenni e mezzo fa.
La più grande isola dell’arcipelago toscano deve ai Focesi l’antichissima tradizione vitivinicola. Studiosi di enologia e di agronomia hanno scoperto negli acini dell’Ansonica e dell’Aleatico, uve madri, primordiali dell’Elba già diversi secoli prima di Cristo, qualche nucleotide di Dna della vitis vinifera greca o mediorientale. Altri sostengono che anche nel tipo di allevamento di particolari vitigni, ad alberello, tutt’ora praticato in qualche zona dell’isola, c’è lo zampino enologico della civiltà focese.
L’albero genealogico dei vini elbani affonda le radici nel mito e nell’ampelografia, lo studio e classificazione delle varietà di vite, di illustri civiltà. Sicuramente erano vini che piacevano agli Etruschi che sfruttavano il sottosuolo per cavarne il ferro di cui è ricca l’isola, ma mettevano a frutto anche il suolo tracciando le zone più vocate con filari di vigneti. Un altro tralcio genealogico lo occupano i Romani che, in luoghi affacciati sullo splendido mare, costruivano ville assicurandosi che nelle cantine, lo provano i ritrovamenti a Portoferraio, riposassero capaci anfore adibite alla fermentazione dei mosti e all’affinamento dei vini. Che i vini elbani fossero molto ricercati anche nella Roma imperiale lo testimoniano le centinaia di anfore vinarie trovate in fondo al mare elbano, nei resti di navi da trasporto dirette a Portus (Fiumicino) od Ostia.
Anche i Medici, soprattutto Cosimo I, s’interessarono alla viticoltura dell’isola. Dei vini elbani parla lo scrittore marchigiano Andrea Bacci nel De naturali vinorum historia (1596), la prima monumentale guida del vino italiano. Il granduca di Toscana Pietro Leopoldo di Lorena alla fine del XVIII secolo, fissò in sei ore il lavoro in miniera perché gli elbani non trascurassero la vigna.
Ma il vero rinascimento dell’Elba e dei suoi vini porta l’imperiale nome di Napoleone. Dopo il disastro di Lipsia, all’imperatore detronizzato erano state lasciate due alternative: regnare su Corfù o sull’Elba. Scrisse a un generale: «Ho scelto l’Elba considerando la dolcezza dei costumi dei suoi abitanti e la bontà del clima. Essi saranno l’oggetto costante del mio interessamento più vivo». E fu veramente così. Come aveva fatto in Francia e nel Regno d’Italia, Napoleone governò snellendo la burocrazia, incentivando i commerci, innovando e rianimando la cultura, la scienza e l’agricoltura. In modo particolare si dedicò alla coltivazione della vite e alla produzione di quel vino che conosceva e apprezzava. Napoleone introdusse tecniche moderne di potatura, promuovendo nuove varietà di uve, valorizzando le autoctone, costruendo infrastrutture e favorendo il commercio del vino. La viticoltura ebbe un enorme impulso raggiungendo un patrimonio viticolo di 32 milioni e mezzo di piante, mai eguagliato in seguito.
Peccato per l’Elba che il periodo d’oro durò solo nove mesi e mezzo, dal 4 maggio 1814 al 26 febbraio 1815. Quando Napoleone si fece riprendere dal prurito della grandeur, agli elbani non restò altro che piangerlo e rimpiangerlo. Dopo Waterloo, esiliato a Sant’Elena, la nostalgia per l’Elba lo rosicchiò come un tarlo: malato, vicino alla morte, confidò a un ufficiale: «Sei anni or sono esattamente, giungevo all’Isola d’Elba. Pioveva. Io guarirei, se potessi risentire quella pioggia». Morì il 5 maggio 1821. Ancora adesso, dopo 204 anni, ogni 5 maggio, nella chiesa della Reverenda Misericordia di Portoferraio, viene celebrata una messa in suo suffragio.
L’impulso dato dal Bonaparte alla viticoltura elbana durò nel tempo. Nonostante le malattie, l’oidio e la filossera, il vino elbano continuò a essere apprezzato in continente. Nel 1879 Giulio Pullè, nella Monografia agraria del circondario dell’Isola d’Elba, scrive: «La coltura dei vigneti è quella che tra tutte le colture agrarie del circondario ha la importanza massima, essendoci impegnati più di 5.000 ettari di terreno, vale a dire un quarto della superficie totale dell’Elba». Pullè stima in 123.000 ettolitri la produzione di vino: «Il benessere materiale e morale dell’isola sono in relazione intima con le vicende dell’industria vinifera».
All’inizio del Novecento, i vigneti occupano la pianura e le zone collinari, ma si piantano filari anche sui pendii occidentali più impervi grazie ai terrazzamenti sorretti da muretti a secco che seguono le curve di livello del monte. Il benessere economico dato dalla viticoltura continua fino alla metà del Novecento con i vini trasportati sui leudi, imbarcazioni a vela latina capaci di caricare fino a 30 tonnellate di merce. Fu il turismo a cambiare le carte in tavola determinando un lento abbandono dei campi e dei vigneti.
Fino ad oggi. È vero che sono solo 300 gli ettari vitati, solo 15 le aziende vitivinicole, ma nell’isola si respira di nuovo l’entusiasmo «napoleonico». La cultura, la ricerca della qualità, lo sport, la gastronomia, sono le spinte del nuovo rinascimento che fermenta negli acciai, nelle anfore d’argilla, nelle botti e nei caratelli assieme all’Aleatico, vino patriarca, promosso con la Docg nel 2011, ai vini a Doc, Elba bianco, Ansonica, Vermentino, Elba rosso, rosato, Moscato passito, Procanico. La parola d’ordine è: «Non solo mare cristallino e sentieri immersi nella natura: l’Isola d’Elba racconta anche una storia di sapori, tradizioni e vini d’eccellenza». Su questo c’è una unità d’intenti. Massimo De Ferrari, presidente del Consorzio servizi albergatori Isola d’Elba, spiega: «L’ospitalità elbana va oltre gli alberghi sulle spiagge: è un’esperienza culturale a tutto tondo, che passa attraverso il vino, la cucina e i prodotti agricoli locali, di altissima qualità, meritevoli di essere conosciuti in tutto il mondo. Vogliamo promuovere il territorio attraverso la cultura di cui fanno parte il vino e la gastronomia, eccellenze dell’Elba».
I sapori di questa terra, di questo mare, i mitici piatti dei minatori, dei pescatori, dei contadini, dalla schiaccia ubriaca sposa meravigliosa dell’Aleatico, alla sburrita, alla tonnina, allo stoccafisso alla riese, alla grinfia di polipo che all’inizio degli anni Settanta due mitici polpai, Zelindo e Bacocco, traevano dal loro aveggio fumante nelle viuzze della vecchia Portoferraio per offrirlo ai turisti.
Grappoli di storia. Cantine metafisiche. Qui cultura, scienza, sport, architettura, passato, presente e futuro gorgogliano nei calici di vino elbano. All’azienda vinicola Cecilia, in località La Pila, la vigna fa i conti con la matematica. Fondata nel 1990 dall’ingegnere-artista Giuseppe Camerini, vive di vino, d’installazioni artistiche e di frattali, figure geometriche che si ripetono all’infinito. All’Acquabona il vino incontra il golf. «Golf & Wine»: palline in buca e degustazioni di vini tipici. Il fascino della storia, l’incanto della natura e della baia di Portoferraio, appartengono a La Chiusa, un gioiello antico circondato da una cinta muraria che custodisce una villa antica, vigneti e oliveto. Alle Ripalte, nel parco nazionale dell’arcipelago toscano, la cantina della famiglia Ederle porta la firma dell’architetto-viticoltore Tobia Scarpa. Aldo Arrighi a Port Azzurro tuffa l’uva Ansonica in canestri di vimini affinché si nutra del gusto del mare e poi fermenta i mosti nelle anfore di ceramica. A Rio Marina Aldo Appiani, Le Sughere, grazie alle ricerche storico-gastronomiche dell’Accademia italiana della cucina, e a Porto Azzurro Italo Sapere (nomen omen), La Sapereta, hanno riscoperto gli antichi sapori elbani abbinati ai loro vini.