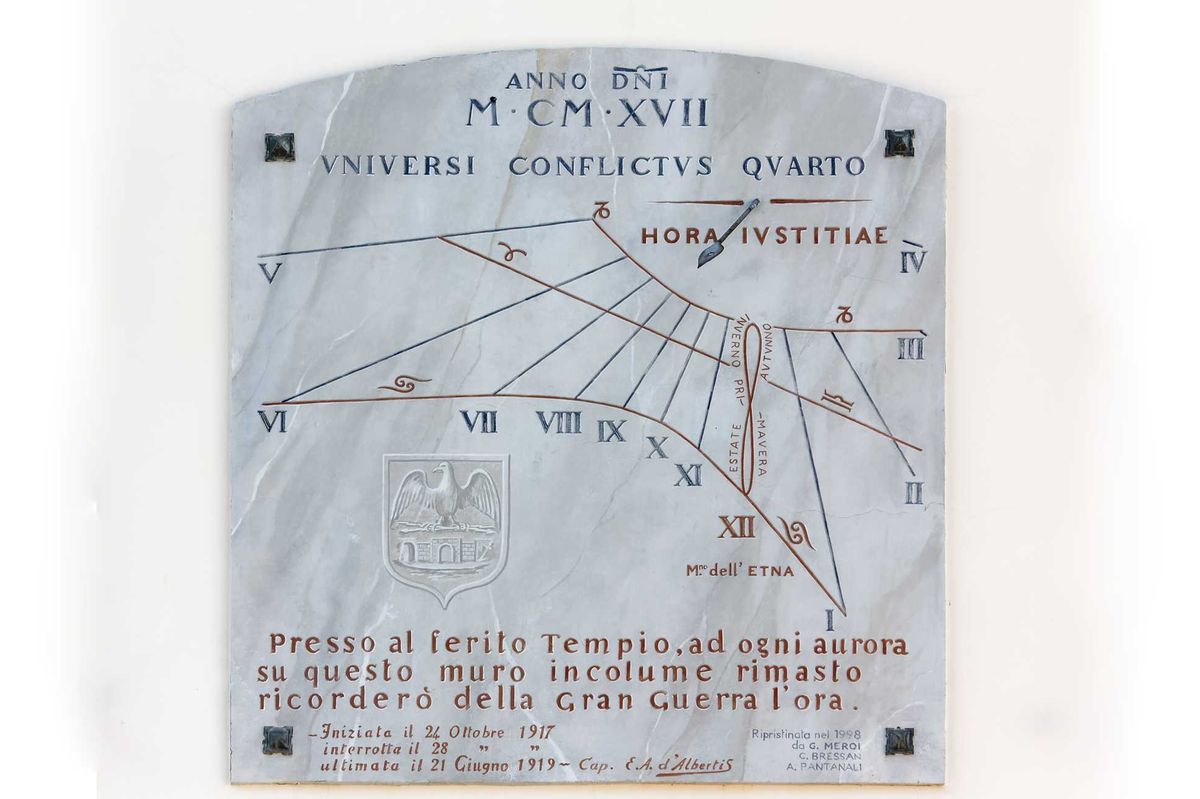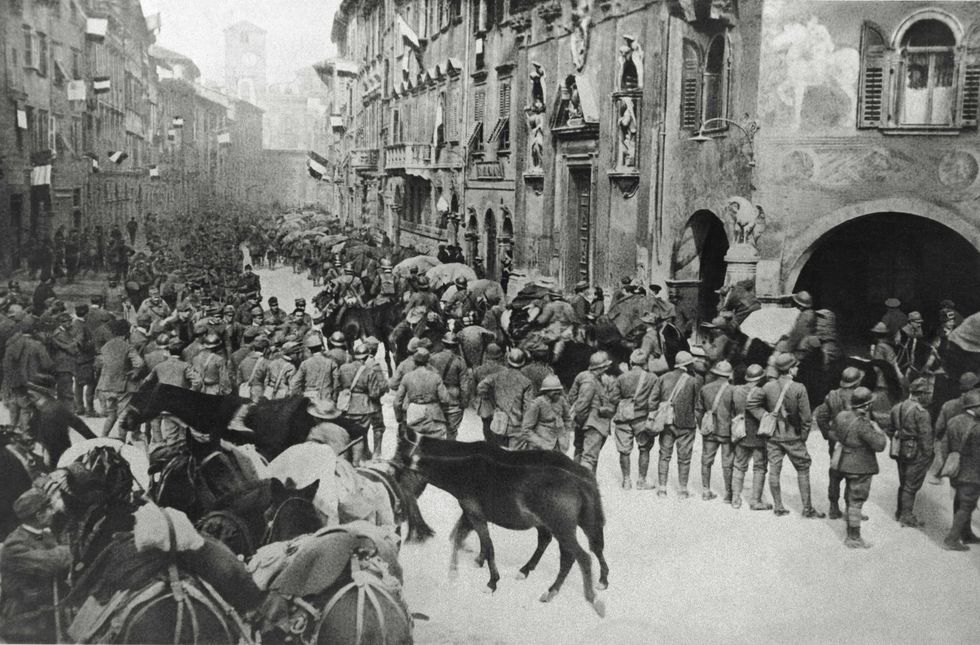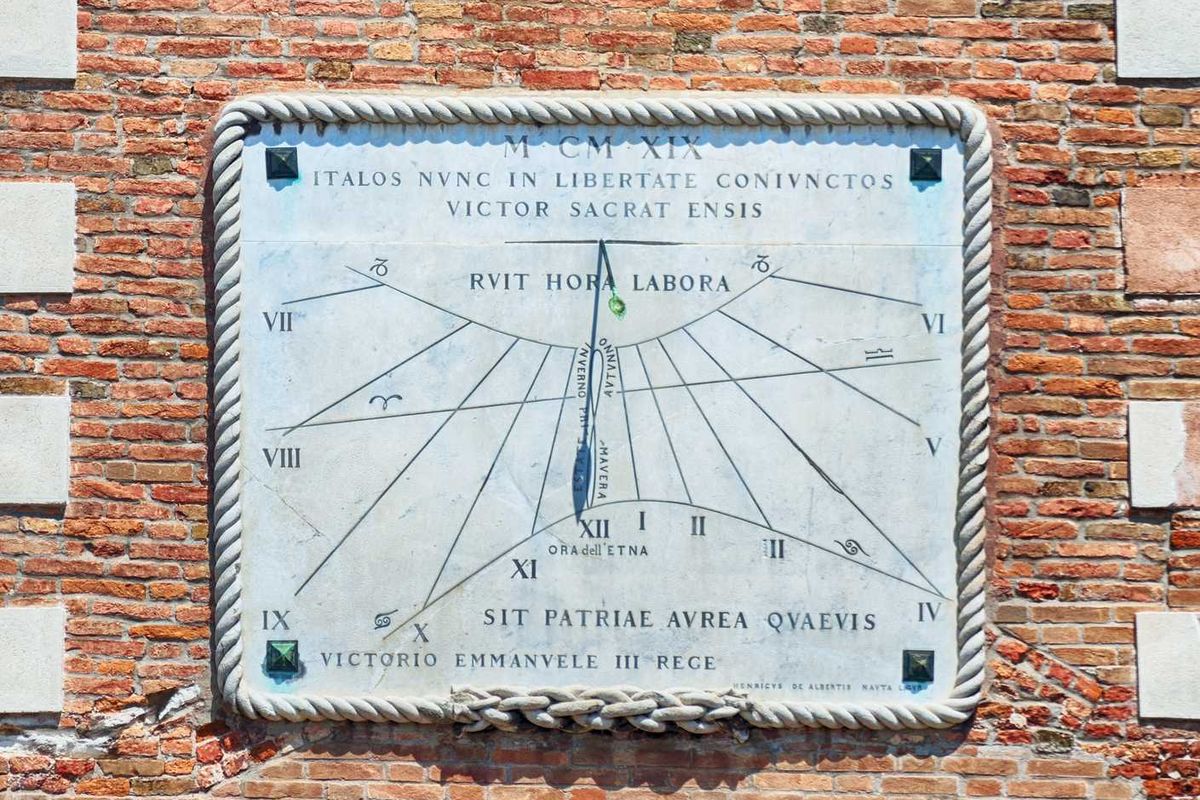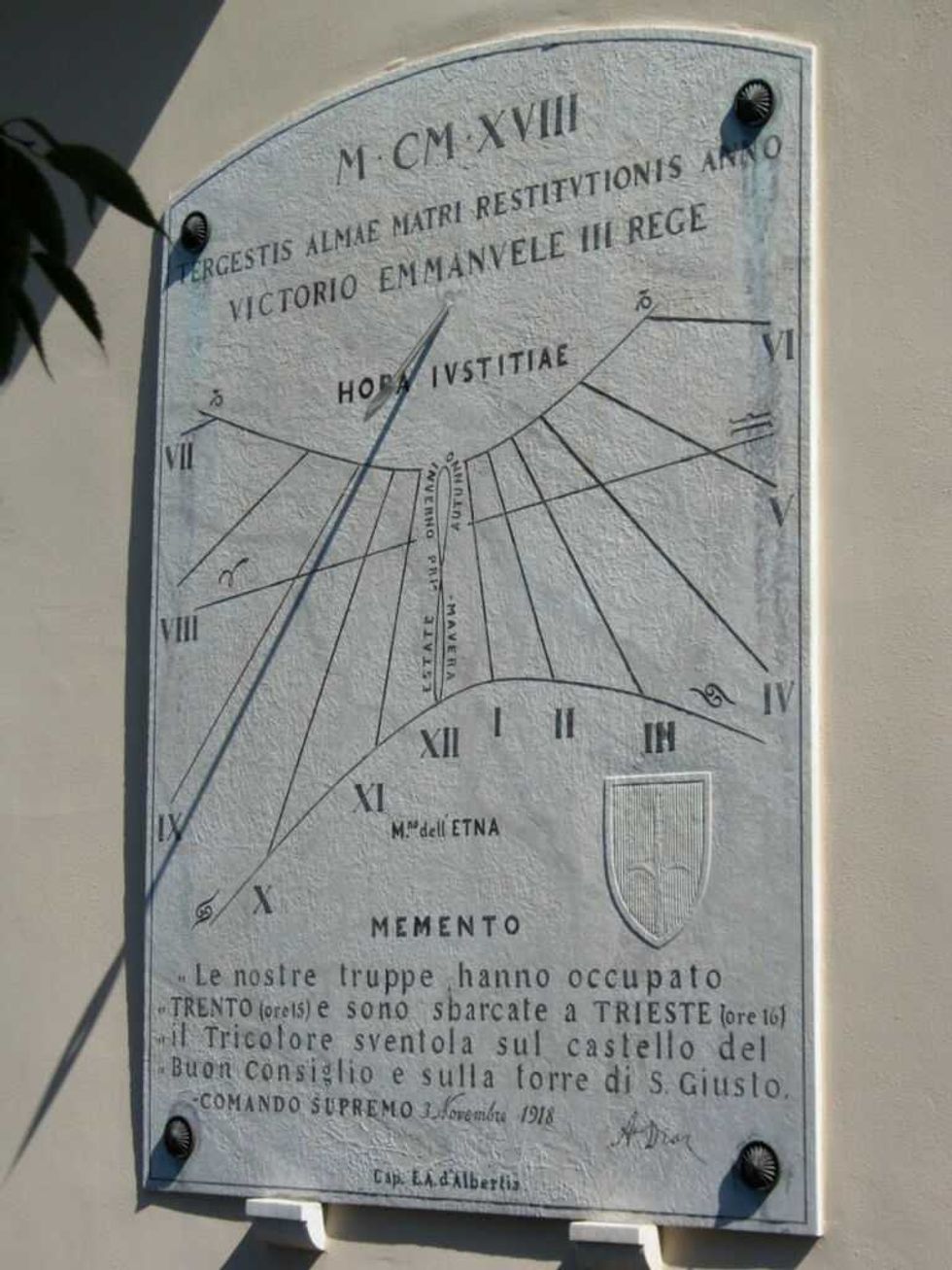Stellantis inchioda sull’idrogeno perché questa Unione non sa cosa vuole
Su queste colonne abbiamo spesso criticato le scelte degli azionisti di Stellantis. Ad esempio la mancata realizzazione della giga factory. Un doppio errore. Primo, perché basato su una strategia errata: quella dell’elettrico. Secondo, perché ha impegnato fondi del Pnrr e non ha nemmeno garantito un posto di lavoro. Ma c’è anche il perenne ricorso alla cassa integrazione, così come sul banco degli imputati ci sono altre decisioni targate Tavares relative al mercato americano. Ma la notizia di ieri spinge a una riflessione molto diversa, a un ragionamento che dimostra come le case automobilistiche siano rimaste bloccate nel guado del modello di transizione imposto dalla Commissione. Ieri, il gruppo ha annunciato la decisione di interrompere il programma di sviluppo della tecnologia a celle a combustibile a idrogeno. Motivi? La limitata disponibilità di infrastrutture per il rifornimento di idrogeno, gli elevati requisiti di capitale e la necessità di maggiori incentivi all’acquisto da parte dei consumatori. Tradotto, l’azienda non prevede l’adozione di veicoli commerciali leggeri alimentati a idrogeno prima della fine del decennio. Pertanto, quest’anno Stellantis non lancerà più la sua nuova gamma di veicoli Pro One alimentati a idrogeno. La produzione in serie avrebbe dovuto iniziare quest’estate a Hordain, in Francia (furgoni di medie dimensioni) e a Gliwice, in Polonia (furgoni di grandi dimensioni).
«In un contesto in cui il gruppo si sta mobilitando per rispondere alle stringenti normative europee sulle emissioni di CO2, Stellantis ha deciso di interrompere il suo programma di sviluppo della tecnologia a celle a combustibile a idrogeno», ha spiegato Jean-Philippe Imparato, chief operating officer per l’Europa allargata. «Il mercato dell’idrogeno rimane un segmento di nicchia, senza prospettive di sostenibilità economica a medio termine. Dobbiamo fare scelte chiare e responsabili per garantire la nostra competitività e soddisfare le aspettative dei nostri clienti con la nostra offensiva di veicoli elettrici e ibridi per passeggeri e veicoli commerciali leggeri». È chiaro che si tratta della prima sfida di Antonio Filosa, scelto da John Elkann per il rilancio del gruppo. Ma di fronte all’incertezza della Commissione e alla mancanza di scelte strategiche, nemmeno il migliore degli amministratori delegati potrebbe fare i miracoli. Va detto chiaro: la colpa è della Commissione. La precedente legislatura ha avviato la desertificazione e l’attuale non sceglie nulla. Non torna indietro né va avanti. Non sceglie le tecnologie sulle quali l’Europa dovrebbe puntare per competere con gli altri Continenti. Questo è il problema delle case automobilistiche. Vale per Stellantis, così come per Renault. Che ieri è crollata in Borsa dopo il taglio delle stime. La reazione negativa del mercato è arrivata all’indomani della comunicazione ufficiale del passaggio di consegne alla guida del gruppo francese, con l’uscita di Luca De Meo - approdato a Kering - e l’arrivo temporaneo del direttore finanziario Duncan Minto al timone operativo. Ma ciò che il mercato teme ancor di più è l’assenza di certezze. E qui corre l’obbligo di ricordare una cosa. Tre o quattro anni fa, chi sosteneva che la transizione green ci avrebbe portato al deserto industriale veniva tacciato di negazionismo climatico o verde. Lo scorso anno, quando gli effetti della perdita di produzione nel settore auto cominciavano a divenire così importanti da non poter più essere nascosti sotto il tappeto, i pro transizione alla Frans Timmermans avevano pronta la ricetta: raddoppiare gli sforzi e i danni. Se il modello non funziona è perché l’impegno non è stato sufficiente. Ora i numeri sono a dir poco inquietanti, ma chi avrebbe dovuto pensare a soluzioni anticipate latita. Lo scorso anno l’industria della componentistica automotive ha perso più di 30.000 posti di lavoro, il doppio di quelli tagliati nel corso del 2023. Un panorama che non mostra margini di miglioramento. Le vetture a batteria elettrica costano molto di più, consentono una mobilità limitata e non permettono un listino che possa essere esteso al concetto di utilitarie. Il risultato è che i prodotti green sono intrinsecamente limitanti e quindi prevedono un mercato con perimetro ridotto. Nemmeno la spinta degli incentivi e della droga del sostegno pubblico potranno ovviare alle basi strutturali. Pensiamo all’Italia. Il nostro mercato potrebbe garantire un giro d’affari da 1,5 milioni di vetture. La produzione attuale supera di poco la metà. E non sfonda. Ci sarebbe tutto lo spazio. Ma si è rotto un rapporto di fiducia finanziaria e sociale. Da qui bisognerebbe ripartire. Poche idee e chiare. Quanto costa riportare le case automobilistiche europee sul percorso del motore a scoppio, garantendo al tempo stesso il minore impatto ambientale? È la prima domanda che dovrebbero porsi a Bruxelles. Perchè non lavorare a un motore diesel in grado di percorre con un solo litro di carburante oltre 10 chilometri? Questa sarebbe una innovazione importante. Ma tornare a essere all’avanguardia non è facile. Soprattutto se la Commissione, a distanza di sette mesi, non ha ancora deciso come gestire le multe per le emissioni di CO2, in un mondo che, dopo l’arrivo di Donald Trump, ha già dato una svolta decisiva a tutto cià che batte bandiera Esg.